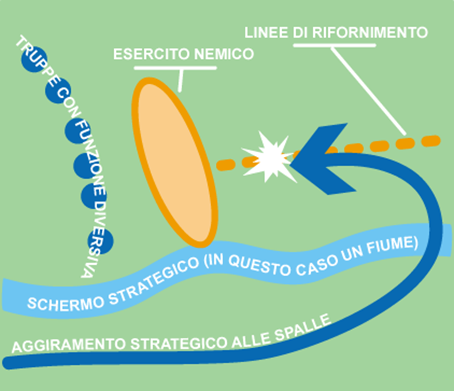
|
||||||
|
||||||
|
Dal suo affermarsi alla scala mondiale, il capitalismo ha sempre
conosciuto
crisi, di varia intensità ed estensione; e quello del perché si
determinano
e come trattarle e superarle è uno dei principali temi di ogni teoria
economica. Generazioni di studiosi borghesi, dal 18° secolo al 20°
hanno
cercato di comprenderne le cause, i meccanismi; ogni scuola ha dato le
sue versioni, le sue cure specifiche, in linea con i principi teorici
che
pretendeva di aver scoperto. Ma non è qui che le possiamo seguire nelle
loro evoluzioni e varianti.
Se gli economisti classici pensavano di trovare, al fondo dei loro studi e teorie, gli strumenti definitivi per governare il processo di produzione capitalistica, evitando le crisi o rendendole semplici e superabili incidenti di percorso, col tempo sicuramente eliminabili, questo programma di progressiva razionalizzazione ha dovuto essere allentato, rivisto e poi abbandonato. L’economia classica, che investigava i concetti fondamentali di valore e di creazione della ricchezza, ha dovuto fare i conti con dei modelli logici che la dinamica reale ha teso sempre a contraddire.
Dall’osservazione della tendenza al decremento del tasso di profitto fatta da Ricardo ad inizio Ottocento, fino all’estremo tentativo di prevenire o controllare le crisi tramite l’intervento dello Stato con strumenti monetari, o al concetto di “prestatore di ultima istanza”, tutta la teoria del processo capitalistico si è ridotta ad un più o meno sofisticato modellare – in termini matematici – le presunte relazioni tra le grandezze economiche scelte, secondo schemi di equazioni differenziali, il cui variare delle “condizioni al contorno” avrebbe dovuto rendere conto del loro svolgersi; ed operare, di conseguenza, gli “interventi” più opportuni a ridurre i danni, o a riportare nei binari del corretto governo le variabili impazzite.
Programma non dappoco. Intanto, però, nei fatti, chi realmente opera nel campo della politica economica internazionale è costretto a muoversi con molta improvvisazione – oltre che cinismo e spregiudicatezza – sempre guidata in realtà soltanto dall’imperativo di difendere i privilegi economici e il potere politico delle classi dominanti, di mantenere ad ogni costo in vita il sistema del profitto, di assicurare che il reddito da capitale, anche e soprattutto da quello fittizio, non crolli trascinando con sé tutto il resto del mondo borghese.
Che il principio basilare della attuale, definitiva, fase del capitalismo finanziario, to increase the shareholder’s value, aumentare il valore del capitale produttivo di interesse, sia oggettivamente un detonatore di tutte le crisi capitalistiche, è però la drammatica, insanabile contraddizione di un modo di produzione giunto al capolinea delle sue potenzialità: il prodotto del lavoro umano è strangolato dal laccio del profitto, ora nel XXI secolo come oltre cento anni fa.
In fondo tutte le crisi del capitalismo si assomigliano, sviluppandosi apparentemente nel truffaldino mondo della finanza, dove si creano valori, “capitalizzazioni” come sono definiti, del tutto fittizi. La “capitalizzazione” è la grande invenzione della finanza: scambiare un più o meno possibile valore futuro con un dichiarato prezzo presente – il cosiddetto “mercato” è la sfera di cristallo che consente di prevedere ciò che avverrà – e su quello calcolare la potenziale produzione di interesse e dichiararla già realizzata.
Qualunque impresa, del settore industriale, commerciale o dei servizi, anche relativa a beni essenziali per l’umano vivere, soggiace a questa legge, che ne decreta in fine il successo – in senso capitalistico – o l’insuccesso. Non esiste un interesse “generale”, o un “bene pubblico” da salvaguardare dal sistema del profitto, dal paradigma costi-benefici ai prezzi di mercato. Tutto ha un prezzo, congruente con la “verità” del mercato. Questo argomento del prezzo è un “comune sentire” che mette teoricamente insieme affaristi capitalisti, benpensanti preoccupati degli intessi dal loro gruzzolo, democratici “dal basso”, ambientalisti di ogni risma e sfumatura e sinistri “anticapitalisti”. Qualunque intervento del lavoro umano sugli elementi naturali ha un costo, genera dei valori, che a quel costo più il profitto devono essere pagati. Non ci sono dubbi, qualcuno lo deve pagare. Per tutti la domanda è solo “chi”. E cambiano ovviamente le risposte.
Polemicamente si potrebbe affermare che la risposta più onesta, più congruente, la danno i porci capitalisti, che pretendono comunque il ritorno dei loro investimenti: la paghino quelli che li usano, i “consumatori”.
Dall’altro fronte la risposta è solo apparentemente opposta. I costi, è pacifico, non si possono eliminare, ma, secondo i progressisti di ogni specie, si devono “distribuire” sulla collettività, secondo il meccanismo della fiscalità progressiva, o addirittura eliminare per il corpo sociale, assumendoseli in toto o parzialmente la mano pubblica.
Sembra una soluzione “ragionevole”, che consenta un po’ di respiro al mordere della crisi che si abbatte in primis sugli strati sociali più esposti, ma pretende che lo Stato sia, onnipotente, al di fuori e al di sopra del capitalismo e delle sue catastrofi. È una soluzione che sta più o meno in piedi fintanto che i profitti sono così alti da consentire una loro ridistribuzione dai borghesi allo Stato dei borghesi.
Nelle fasi di crisi, di crollo dei profitti reali, sostituiti dai profitti fittizi della ingegneria finanziaria, la pietosa mistificazione si svela per ciò che è, la pretesa di riformare l’irriformabile. Poi gli Stati, ovvero i loro governi, possono decidere di operare in regime di creazione di debito per ridurre la pressione sociale, ma questo non sposta i termini del problema.
La pratica di allargamento a dismisura della base monetaria, che ha un illustre precedente nella abrogazione del Bank Act della prima metà del 19° secolo, imposta dalla prima vera drammatica crisi finanziaria del capitalismo negli anni ’40 di quel secolo, ha conosciuto nel tempo innumerevoli variazioni sul tema, sistemazioni pratiche e teoriche, fino alle raffinate teorizzazioni del 20° secolo; ed altrettante feroci opposizioni di altre scuole. La politica economica degli Stati ha poi utilizzato, secondo la bisogna ed il momento contingente, tutti gli strumenti che l’armamentario delle diverse teorie metteva in campo.
Le vicende delle crisi generali del capitalismo – rivendichiamo con orgoglio ed ostinazione questa dizione, aspra ed indigesta per tutti quanti siano sul fronte opposto al comunismo – hanno chiaramente dimostrato la fallacia di ogni rimedio che sia “dentro” il sistema capitalistico, non curabile, non sanabile ma solo da eliminare con la guida dell’unica teoria veramente antagonista al mondo borghese, la cui accettazione però non muove da convincimenti teoretici, ma dalla necessità e dalla volontà di eliminare per sempre e definitivamente l’infamia del salariato e del profitto.
E solo a quella condizione l’umanità intera si potrà riappropriare,
anzi, meglio, potrà tornare ad utilizzare liberamente, ma secondo un
piano
naturale di specie, le non infinite risorse che, mediate dal lavoro
umano
non più sottoposto alla legge del profitto, la natura mette a
disposizione
di tutti.
Origini del movimento operaio in Italia
Le Società di Mutuo Soccorso
In Italia le prime, rudimentali forme di organizzazioni operaie furono costituite da Società laiche di mutuo soccorso, a volte create ex novo, altre volte frutto della evoluzione di vecchie confraternite di ispirazione ecclesiastica.
Le Società di Mutuo Soccorso laiche, di tipo moderno, apparvero e si svilupparono dalla fine degli anni quaranta dell’Ottocento, quasi esclusivamente in Piemonte e Liguria.
La maggior parte degli storici attribuiscono questo fatto al clima costituzionale che, a differenza degli altri Stati italiani, consentiva il diritto di associazione. Inoltre il governo piemontese non solo avrebbe permesso la loro costituzione, ma la avrebbe addirittura incoraggiata. Affermava infatti il Cavour, in un intervento parlamentare del 28 novembre 1854: «Io riconosco altamente quanto sia provvido il consiglio dei Municipii e delle associazioni di pubblica beneficenza di [...] provvedere di pane [...] le classi più numerose. Il Municipio di Torino ha preso una iniziativa che sarà, spero, imitata da tutti quei Municipii in cui si trova accumulata una popolazione operaia [...] Ed il mio collega il ministro dell’interno farà quanto sta in lui per dare appoggio a questi lodevoli intenti dei Municipii, e per promuovere le utilissime associazioni dirette a favorire la pubblica sussistenza. E spero che tutto ciò varrà, se non ad impedire le privazioni a cui purtroppo sono sottoposte le classi operaie, almeno a lenirle. Ma debbo aggiungere che io faccio assegnamento non solo sopra gli sforzi dei Municipii, ma altresì sullo spirito di carità che è cotanto sviluppato nelle nostre popolazioni, e che ha già dato tanti saggi di quanto possa operare».
Quale sia stato lo spirito di carità del Cavour e la sua attitudine a sfamare gli operai lo vedremo tra poco. Per ora ci interessa capire il motivo per cui, da parte del governo, veniva sentita la necessità di “promuovere le utilissime associazioni”. La risposta è semplice: la paura, da parte della borghesia, della minaccia rivoluzionaria. I borghesi, consapevoli delle lotte operaie e delle conquiste ottenute in altri paesi, come la Francia e l’Inghilterra, ritenevano che la migliore tattica da seguire di fronte al proletariato sarebbe stata quella di un paternalismo di tipo riformistico, beninteso bilanciata con quella repressiva, e che lo sviluppo delle Società di mutuo soccorso potesse evitare quello che loro giustamente vedevano come il vero nemico: la nascita di organizzazioni di classe.
Sentiamo ancora il pensiero del Cavour: «Come ho detto altra volta, non vi sono che due modi di combattere il socialismo: le baionette ed i cannoni, o la libertà; io scelgo il secondo sistema, e spero che la Camera vorrà pure preferibilmente applicare questo rimedio, il quale è assai più efficace e più durevole» (Intervento parlamentare del 6 marzo 1857).
Infatti, il compito istituzionale che le Società di Mutuo Soccorso si davano era limitato quasi esclusivamente all’assistenza esercitata per mezzo della solidarietà (i soci versavano una quota e ricevevano un sussidio in caso di invalidità e di disoccupazione). Altre volte la loro attività poteva estendersi anche all’assistenza morale, all’educazione ed all’istruzione.
Anche la più che legittima richiesta di istruzione avanzata allora dal proletariato non andava certamente contro gli interessi del governo e della classe borghese. È ancora il Cavour che parla: «Finalmente io credo che per favorire l’industria si conviene di favorire l’istruzione professionale non solo nelle alte, ma nelle basse sfere degli operai. Noi difettiamo ancora di buoni capomastri nelle nostre fabbriche; s’incontrano assai difficoltà onde procacciarsi dei meccanici ingegneri, che sono meccanici un po’ distinti, e per avere questa classe di capomastri artieri è necessario che vi siano alcune scuole tecniche, dove gli operai, non quelli vestiti di panno fino, ma i veri operai che hanno un ingegno naturale, acquistino quelle cognizioni che sono necessarie per diventare buoni capi d’arte, buoni capomastri» (Intervento parlamentare del 27 maggio 1861).
Quindi le prime Società operaie non si proponevano alcun obiettivo che non potesse essere condiviso dalla classe borghese. Le classi sociali erano distinte, ma si pensava che, anche marciando separate, potessero avere interessi ed obiettivi comuni.
Per la verità già nel 1848-49 si ebbero alcuni tentativi di costituire Società di resistenza, cioè di difesa contro i padroni con l’esercizio dell’arma dello sciopero, ma si trattò di formazioni di lotta temporanee che non resistettero a lungo: malgrado i loro stretti limiti, le Società di Mutuo Soccorso continuarono ad essere ancora per molto tempo le forme tipiche dell’organizzazione operaia. Questo tipo di organizzazione si caratterizzava per l’opera di previdenza e cooperazione e, nei rapporti con i padroni, non presentava alcun carattere di antagonismo o di vera e propria combattività. Fu in questo periodo che venne teorizzata la cooperazione operaia come soluzione per l’emancipazione della classe lavoratrice. Particolare importanza ebbe la Società Generale degli Operai di Torino sorta nel 1850.
Il passo successivo fu quello di cercare un collegamento tra le singole Società del Regno Sardo fino a stabilire un vincolo federale. Il 20 ottobre 1850 si riunirono a Torino i rappresentanti delle Società di Pinerolo, Casale, Tortona, Novi Ligure e Torino; in sei Articoli Provvisori di aggregazione temporanea furono formulate le prime, seppure labili, basi di un’organizzazione unitaria, impegnandosi a fornire reciprocamente assistenza agli operai che migravano da una città all’altra.
Più numeroso, ed esteso a tutto il Piemonte, fu l’appuntamento dell’anno successivo, ottobre 1851, indetto in occasione della festa inaugurale della Società di Torino. Come scopo della Società venne proclamato «il miglioramento delle condizioni morali e materiali della benemerita classe operaia». Alla riunione parteciparono 33 Società del Regno di Sardegna e venne votato un nuovo patto che stabiliva 1’“aggregazione generale” delle Società, cioè la loro federazione, e il trattamento reciproco agli operai migranti, e si dava incarico alla Società di Torino di formulare un progetto di Statuto generale, da sottoporre al terzo incontro, che si sarebbe tenuto, sempre a Torino, nel maggio 1852. A questa ultima assemblea venne respinto il progetto, presentato da Agostino Depretis, di un regolamento unificato per le varie Società.
Il primo vero congresso delle Società operaie si tenne ad Asti
nell’ottobre
1853 e fu a partire da questo che iniziò la numerazione dei congressi
delle Società operaie, che continuerà ininterrotta anche dopo la loro
estensione dal Piemonte a tutto il Regno d’Italia. Sette furono i
congressi
tenuti in Piemonte prima dell’unificazione: Asti 1853, Alessandria
1854,
Genova 1855, Vigevano 1856, Voghera 1857, Vercelli 1858, Novi 1859.
Primi congressi delle Società Operaie
Al Congresso di Asti furono rappresentate 30 Società operaie di cui 4 femminili. Il primo quesito proposto alla discussione era: “Quale istruzione convenga agli operai e quali i mezzi più acconci per conseguirla”. Si deliberò di richiedere l’istituzione di scuole serali e domenicali, di sancire nel regolamento di ogni Società l’obbligo per ogni socio di frequentarle, di presentare petizioni al parlamento, al governo ed ai municipi per l’estensione dell’istruzione elementare, di incoraggiare con premi ai padri di famiglia la frequenza delle scuole elementari da parte dei fanciulli. Furono inoltre trattate le questioni dell’invalidità e vecchiaia e dell’assistenza alle vedove e agli orfani degli operai: una commissione fu incaricata di studiare la possibilità di fondare casse di pensione e asili di ritiro per gli invalidi al lavoro. Grosso modo questi erano gli argomenti tipici, che saranno trattati, più o meno estesamente, anche in tutti i successivi congressi.
Le Associazioni avevano il nome di “operaie” e raccoglievano al loro interno veri proletari, ma la direzione era completamente in mano ad avvocati, dottori, nobili e perfino qualche prete. Abbiamo appena visto come a Torino il progetto di statuto fosse stato presentato da Depretis, il futuro presidente del consiglio. Si trattava di personaggi che, per quanto filantropi avessero potuto essere, mettevano tutto il loro impegno e le loro energie per far sì che il veleno della lotta di classe non contaminasse le Società. Ad esempio, mentre il congresso era adunato, il 18 ottobre a Torino il popolo, esasperato dalla carestia che imperversava in quell’anno, era sceso minaccioso in piazza per manifestare contro il governo ed aveva anche lanciato sassi contro le finestre del Cavour. Appena avuta la notizia il congresso votò un ordine del giorno così formulato: «Intese le notizie della dimostrazione fatta ieri sera a Torino, dichiara altamente di disapprovare siffatte manifestazioni». All’ordine del giorno soltanto le Società di Genova e di Voltri, nelle quali era presente una forte tendenza mazziniana, si rifiutarono di aderire.
Era una ben strana risoluzione da parte di un convegno “operaio” nei confronti della protesta di una popolazione affamata che aveva lasciato diversi morti sul selciato, giuste le direttive di Cavour alla polizia. Eppure chi Cavour fosse le associazioni operaie avrebbero dovuto ben saperlo. Angelo Brofferio il 24 novembre 1853 scriveva su La Voce: «Il conte di Cavour è magazziniere di grano e di farina, contro il precetto della moralità e della legge. Sotto il governo del conte di Cavour ingrassano illecitamente i monopolisti, i magazzinieri, i borsaiuoli, i telegrafisti, e gli speculatori sulla pubblica sostanza, mentre geme, soffre, e piange l’universalità dei cittadini sotto il peso delle tasse e delle imposte [...] Il sangue innocente sparso dal conte di Cavour nella capitale dello Stato, senza aggressione, senza resistenza, per una semplice dimostrazione che potevasi prevenire, fu atto barbaro e criminoso».
Strano ma vero, oggi coloro che accusano Berlusconi di corruzione e di ogni sorta di immoralità portano ad esempio Cavour ed il suo integerrimo senso dello Stato che gli avrebbe perfino impedito di mangiare una trota, avuta in dono, perché pescata in acque demaniali. Questo dicono gli odierni demo-puritani, ricordando come il fatto fosse narrato dallo stesso Cavour in una lettera all’amico Urbano Rattazzi. Però i demo-puritani che citano la lettera della trota ne omettono la pubblicazione perché se ne capirebbe il vero senso: Cavour allora, proprio come Berlusconi ora – anche se indubbiamente con maggior stile – si lamentava di essere talmente spiato e controllato in tutte le sue mosse che, qualora avesse mangiato una semplice trota pescata in acque demaniali, sul suo capo sarebbero cascati i fulmini del Parlamento (“les foudres de la Chambre!”).
Ma torniamo a cose più serie. L’anno dopo, ad Alessandria, il numero delle Società rappresentate era già salito a 50. In quei mesi imperversava violento il colera e, come osservava la circolare di convocazione del congresso, la carestia dell’anno precedente e l’epidemia in corso avevano rivelato molte miserie e molti mali che gravavano particolarmente sulle classi lavoratrici.
Il congresso, che nelle discussioni si occupò largamente delle condizioni di vita delle classi povere e specialmente del problema delle abitazioni, spedì un indirizzo alle singole Società, invitandole a studiare sul posto i mezzi per migliorare le case delle classi povere, in accordo coi municipi, ai quali fu chiesta la vigilanza sulle case di nuova costruzione e la costituzione di un Consiglio permanente di igiene pubblica e provvedimenti atti a garantire lavoro agli operai.
Per migliorare le condizioni di vita degli operai, il congresso
suggerì
soluzioni di tipo cooperativo. Anzi, per risolvere la questione delle
abitazioni,
si propose di estendere il principio cooperativo al settore edilizio e
alla produzione in genere, e fu presentato un progetto per la
formazione
di una Società generale, industriale, agricola, manifatturiera e
commerciale.
Si trattava di uno dei tanti progetti, più o meno fantasiosi, che
venivano
proposti come mezzi per sollevare gli operai dalla loro condizione,
senza
mutare l’ordinamento sociale: l’Associazione generale industriale ecc.
avrebbe dovuto essere null’altro che una società anonima costituita
con capitale raccolto attraverso piccole azioni (di dieci lire)
versabili
in cinque rate. Lo scopo era quello di «rendere fruttiferi i più
piccoli
capitali delle Società operaie» e di «porgere all’operaio il mezzo
di impiegare con sicurezza il suo obolo». In sostanza si trattava della
pretesa di emancipare gli operai dal capitale rendendoli capitalisti
essi
stessi, attraverso le loro associazioni che avrebbero messo a frutto
...
la miseria.
Scopi e metodi
Il primo e più importante atto del Congresso di Genova fu l’approvazione del Regolamento dei congressi delle Società operaie. In esso le finalità del movimento operaio vennero così definite: «Scopo principale del Congresso è di promuovere il benessere morale e materiale della classe operaia per mezzo dell’istruzione e del mutuo soccorso; propagare cognizioni utili di economia sociale e privata relativamente alle condizioni delle classi industriali ed operaie; accomunare le cognizioni pratiche delle diverse Società per utilizzarle nel generale interesse». Il Regolamento stabiliva la periodicità annuale dei congressi e istituiva una Commissione permanente che aveva il compito di raccogliere, nel corso dell’anno, dalle singole Società i “quesiti” da sottoporre al congresso successivo, di coordinarli e di farne una relazione complessiva. Ciascun congresso avrebbe dovuto fissare il luogo e la data del successivo. Da queste norme saranno regolati d’ora in poi i congressi e ad esse ci si richiamerà, specialmente da parte moderata, nelle polemiche successive fra le varie correnti politiche. Questa fu la forma definitiva dell’organizzazione unitaria delle Società operaie piemontesi, ma non mancò tuttavia, in seguito, qualche tentativo di stabilire legami più stretti ed organici.
A Voghera si propose che venisse emanato un regolamento uniforme per tutte le Società operaie, ricavandolo da una sintesi dei vari regolamenti esistenti.
A Vercelli fu proposto, invece, di fondare una Confederazione delle Società operaie, lasciando a ciascuna la propria autonomia, ma indicando gli scopi generali nei quali tutte dovessero convenire. La proposta venne però respinta, per timore che un’organizzazione rigida e vincolante allontanasse molte Società gelose della loro indipendenza, ed anche perché un’organizzazione unitaria sarebbe stata più facilmente oggetto delle non desiderate interferenze governative.
Il Regolamento di Genova rappresentò anche una vittoria della corrente liberale sopra la tendenza conservatrice, che avrebbe voluto trasformare le Società operaie in pure e semplici istituzioni di beneficenza e le sollecitava, quindi, a richiedere dal governo il riconoscimento giuridico, che le avrebbe ridotte alla stregua delle opere pie. Questo tentativo venne bocciato con l’argomentazione che «le Società di mutuo soccorso ritraggono la ragione di loro esistenza dal diritto naturale e dalle speciali disposizioni dello Statuto; che il loro fine economico si limita al ricambio fratellevole dei soccorsi, sopperiti coi risparmi sul profitto degli individuali lavori; che perciò le Società di m.s. non hanno bisogno di autorizzazione governativa a sussistere».
L’anno dopo, al Congresso di Vigevano, la questione tornò in ballo con la discussione sul quesito “se alle Società operaie convenga, e sia conforme ai principi che le informano il ricevere doni”: fu una discussione accanita che occupò quasi tutti i lavori del quarto congresso, perché da essa dipendeva il carattere che avrebbe assunto il movimento delle Società operaie, e si concluse col lasciare facoltà alle singole associazioni di accettare doni non vincolanti, ossia che non ne diminuissero la libertà di azione, ma soprattutto con la chiara affermazione che le Società erano di mutuo soccorso e non di beneficenza. Il rifiuto dei doni rappresentò un primo tentativo, da parte delle Società, di darsi un carattere veramente operaio e liberarsi dei cosiddetti “soci onorari”, cioè di quei borghesi che pagavano le quote di associazione e non ricevevano i sussidi, assumendo quindi la veste di patroni o di benefattori. In effetti l’elemento operaio era sopraffatto dai borghesi soci onorari e contro questa situazione che dava, di fatto, ai soci onorari la direzione delle Società e dei congressi, si levava di tanto in tanto qualche protesta. Si giunse ad esprimere la necessità che il carattere operaio delle Società fosse ben definito e che esse si rendessero “indipendenti dall’amministrazione degli avvocati, dei dottori, dei preti, dei proprietari, degli altri godenti della terra”.
I discorsi pronunciati nei congressi immancabilmente cominciavano col vocativo Operai!, ma in realtà le poche decine di soci che ciascun congresso riusciva a raccogliere appartenevano quasi tutti al ceto intellettuale, e sarebbe problematico trovare fra di essi una rappresentanza diretta dei lavoratori manuali, fatta eccezione per qualche artigiano. Anche se il regolamento di Genova stabiliva che almeno uno dei due soci che ogni Società poteva delegare al congresso dovesse essere “effettivo”, ossia operaio, questa norma, nella pratica, non venne mai rispettata, perché, a differenza che per i professionisti ed i borghesi, per gli operai di fabbrica o garzoni di bottega o contadini era impossibile abbandonare il lavoro per i tre giorni della durata del congresso e sostenerne la spesa. Anche le commissioni permanenti fra un congresso e l’altro furono sempre composte in grande maggioranza da professionisti.
Questi intellettuali che avevano creato il movimento dei congressi
concepivano
le Società di mutuo soccorso come una manifestazione di autonomia
popolare,
di democrazia nel senso più sostanziale del termine, in
contrapposizione
alla beneficenza elargita dall’alto, e quindi avvertivano essi stessi
il disagio di una forte prevalenza dei soci onorari nella direzione
delle
Società operaie.
Il miglioramento della condizione operaia
Si dovette attendere il quarto congresso, a Vercelli nel 1858, perché venissero messi in discussione problemi propriamente operai. In questo congresso per la prima volta si parlò delle condizioni di vita del proletariato delle fabbriche, ed in special modo dell’orario di lavoro. Nelle industrie tessili, le più sviluppate allora in Piemonte, le ore di lavoro giornaliere normalmente erano tredici-quattordici, ma potevano arrivare fino a sedici, inoltre vi si faceva largo impiego del lavoro dei fanciulli, non tutelato ancora da alcuna legislazione protettiva. Se si tiene conto che questo grave problema era già stato da tempo segnalato nel Piemonte stesso da sociologi ed economisti, non si può certo affermare che i congressi operai rappresentassero l’avanguardia del proletariato.
Il quesito a Vercelli era formulato così: “Se sia utile e conveniente determinare in massima un limite di durata ai lavori giornalieri più faticosi e nocivi” e fu svolto da Vincenzo Boldrini, che parlò del lavoro nelle risaie e nei filatoi, ricordò la donna della sua Vigevano che lavorava sin “sedici ore per giorno davanti ad un fornello ardente”, e “bella e robustissima nella prima giovinezza” cadeva a trenta anni “come vecchia e malata”, vittima dello sfruttamento inumano dei padroni; invocò una legge, ma dichiarò di ritenerla possibile solo quando si fosse largamente mobilitata l’opinione pubblica e per questo invitò le Società operaie ad agitare attivamente la questione, ricordando loro il compito di educare a sentimenti di onestà e di «fratellevole giustizia» non solo gli operai «ma anche i produttori e i capitalisti». Altri congressisti denunciarono abusi gravissimi, e il congresso nominò una commissione «coll’incarico di studiare in tutta la sua generalità questo argomento, mettendosi in rapporto con corpi morali e scientifici capaci di porgere cognizioni in proposito, e di pubblicare il risultato delle rispettive indagini»; in base alle quali si riservava di prendere, in seguito, quelle deliberazioni che «senza entrare nella competenza governativa o nelle ragioni dei privati interessi si crederanno più acconcie a rimovere i segnalati inconvenienti».
Nelle discussioni riguardanti la ricerca del miglioramento delle condizioni dei lavoratori prevalevano le proposte intese all’elevamento morale, più che materiale, dell’operaio, ispirate al paternalismo dei liberali che partecipavano ai congressi. Il tema più trattato fu, infatti, quello dell’istruzione degli operai. Su questo tema si era soffermato in modo particolare il Congresso di Vigevano, che deliberò di presentare al parlamento una petizione per l’istruzione elementare obbligatoria. Questa proposta era stata sempre avversata dai conservatori che avevano dichiarato «essere ben poco vantaggio al popolo, massime in questi tempi di estrema carenza d’ogni cosa, nei quali il povero manuale abbisogna di usufruttare tutti i mezzi a sua disposizione, anche le tenerissima braccia de’ suoi figli, onde provvedere al sostentamento della famiglia».
Ma soprattutto la proposta di istruzione obbligatoria era avversata perché considerata pericolosa per l’ordine sociale. La tesi dei liberali, altrettanto reazionaria di quella dei conservatori, era tesa a dimostrare che, al contrario, l’istruzione estesa a tutto il popolo rappresentava la migliore garanzia contro la sovversione: «Rendete obbligatoria l’istruzione primaria, poiché, mentre è necessaria alla felicità e tranquillità d’ogni ceto sociale, è in pari tempo uno dei mezzi più acconci e potenti a togliere o grandemente scemare tante calamità e miserie. Si, o signori, obbligate l’operaio ad educarsi ed istruirsi e diverrà agiato: divenendo agiato avrà di che onestamente campare, e guarderà, ne siamo certi, impassibile e non più con bramosia, i beni dei gaudenti. Obbligate l’operaio ad educarsi, ed istruirsi ed avrete, in una parola, dissipati tutti gli spauracchi della scuola socialista». Borghesi progressisti e reazionari avevano il medesimo terrore, quello dello spettro del comunismo.
In apertura del quinto congresso, Giovanni Mollino, presidente della Società di Voghera, dopo aver lamentato i «gravissimi mali» che «pesarono sempre sul popolo operaio» perché «i legislatori intenti a far base agli Stati, non ebbero per lo più altra mira, che di soddisfare al voto dei più potenti e dei più facoltosi», e dopo aver ricordato che «dal grido di Spartaco al fremito di indignazione che si levò dalle barricate di Parigi, fu una continua protesta contro l’ingiustizia che domina la terra», non si sa con quale logica concludeva: «Non sono però le leggi agrarie, non i falansteri dei comunisti che possono rendere felice l’operaio, né altre esagerazioni di tal fatta, sognate da menti torbide e fantastiche. Egli che sacrifica la vita al comun beneficio, pago di un pane che gli costa lagrime e sudori, non ricerca che i diritti comuni a tutti gli uomini, non domanda che il lavoro, non desidera che allontanare le miserie a cui può soggiacere. Per avventura in Piemonte, da che si ebbero le liberali istituzioni, non è tolta all’operaio la speranza di conseguire i suoi voti. La libera associazione ha già posto rimedio a tanti mali e senza dubbio abbiamo ragione di compiacimento se esaminiamo a ciò che si fece fin qui dalle Società di mutuo soccorso».
Non a caso questa dichiarazione veniva fatta in apertura del
Congresso
di Voghera, nell’ottobre del ‘57. Essa rispondeva ad accuse rivolte
alle Società operaie di essere centri di sovversivismo, in seguito al
moto insurrezionale genovese del 29 giugno, a capo del quale era stato
Filippo Bartolommeo Savi, mazziniano e dirigente della Consociazione
operaia
genovese. Le accuse contro le Società operaie furono poi ripetute dal
Pubblico Ministero nel processo per i fatti di Genova, e contro di esse
protestò il Congresso di Vercelli.
Patriottismo, democrazia, lotta di classe
Alle tradizionali due anime delle Società operaie (la conservatrice
e la liberale) se ne era oramai aggiunta una terza: la mazziniana.
- La conservatrice auspicava il riconoscimento statale ed una
regolamentazione
legislativa delle Società operaie, che le avrebbe trasformate in
qualcosa
di simile alle opere pie, o per lo meno le avrebbe sottoposte a qualche
forma di controllo amministrativo e politico.
- La liberale era contraria alla tutela dello Stato, si ispirava ad
un paternalismo di tipo illuminato, desiderosa di alleviare, per quanto
possibile, i disagi degli operai, ma soprattutto di sottrarli alla
influenza
socialista e quindi badava ad escludere dai congressi le discussioni di
carattere politico.
- L’ingresso della corrente mazziniana, specialmente dopo
l’unificazione
nazionale, servì, come vedremo in seguito, ad accelerare il processo di
maturazione delle Società.
Con il congresso di Novi del 1859 si usciva finalmente dall’angusto perimetro piemontese per la partecipazione di una rappresentanza delle Società operaie milanesi alle quali venne rivolto il caloroso saluto di fratellanza degli operai del Piemonte. Allo stesso tempo non si mancò di ricordare ai nuovi arrivati la funzione moderatrice delle Società operaie: «Fra gli elementi d’ordine di cui si pregiano le antiche Provincie dello Stato Sardo – fu detto – non tengono ultimo luogo le associazioni degli operai che procurano a questa classe forte e numerosa gli incalcolabili vantaggi del Mutuo soccorso e della Mutua istruzione. Un’esperienza di dieci anni sopra questo suolo costituzionale è venuta a risolvere in modo pratico quei problemi che in altri paesi si presentavano sotto forma di minacciose utopie».
Venne stabilito che l’ottavo congresso si sarebbe tenuto a Milano e questo, dell’ottobre del 1860, delle Società operaie italiane, allo stesso tempo può essere considerato il primo a carattere nazionale. Erano infatti presenti 109 delegati, rappresentanti di 64 Società del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia e della Toscana.
Si aprì a Milano il 26 ottobre 1860, il giorno stesso dell’incontro di Teano fra Garibaldi e Vittorio Emanuele, in un momento cioè nel quale l’interessamento generale era tutto assorbito dai grandi avvenimenti politici e militari nazionali. Fra i motti, quasi tutti di carattere patriottico, che fregiavano la sala del congresso, ce n’era uno che più che una dichiarazione di interclassismo rappresentava un vero e proprio ossequio da parte del proletariato nei confronti della borghesia: “A voi che col core, la mente, incoraggiate l’industria, assicurate il lavoro, l’operaio solerte, riconoscente”. Il sindaco di Milano nel suo discorso inaugurale ricalcava questa concezione paternalistica: «Il preparare quelle sacre instituzioni che valgono a promuovere il benessere e rialzare la dignità morale degli operai è opera di uomini di cuore, che, sentendo il beneficio della libertà, la vogliono estesa alle classi oscure e laboriose. Non mancherà il concorso delle classi più fortunate, dei Municipi, del Governo a coadiuvarne la santa impresa, né tarderà che una legge del Parlamento italiano dettar potrà le salutari norme direttive a vantaggio delle classi operaie». Questa era né più né meno che la continuità della tradizione piemontese.
Sennonché il presidente eletto del congresso (Sineo) intervenne con forti accenni democratici rivolgendosi al popolo milanese delle Cinque Giornate, elogiò la partecipazione popolare al Risorgimento e condannò esplicitamente Carlo Alberto che nell’estate del ‘48 e nel ‘49 aveva rifiutato “il concorso del popolo”; paragonò quindi la dannosa paura nei confronti del popolo del ‘48 alla paura nei confronti della democrazia che aveva a lungo trattenuto molti degli attuali governanti «nel panico timore di terribili sovvertimenti sociali», ed invece diede atto alle associazioni operaie piemontesi del merito di avere, con il loro pacifico sviluppo, alieno da «abbaglianti utopie», persuaso infine tutti gli uomini di buona fede che «col popolo si fa tutto ciò che può concepirsi di nobile e di sublime» e che la democrazia non rappresentava un pericolo per l’ordine sociale.
Il Franchini, altro democratico, avanzò questa duplice proposta: 1) che si concedesse il viaggio ferroviario gratuito ai delegati ai congressi operai per facilitarvi la partecipazione dei soci effettivi, cioè dei veri operai. Disse che con il viaggio gratuito i deputati ai congressi operai avrebbero avuto, almeno una volta all’anno, quel diritto di cui godevano sempre gli altri deputati, quelli del parlamento, non eletti dagli operai. Il viaggio gratuito ai congressisti venne concesso l’anno dopo; 2) che si chiedesse il suffragio universale nelle elezioni politiche ed amministrative. Affermò che la libertà, sarebbe sempre stata una illusione ed una menzogna, finché l’operaio non avesse avuto il diritto di votare, ed il negarlo sarebbe stato un atto ostile del governo verso il popolo.
Se già la generica professione di democrazia del Sineo aveva non poco scandalizzato i tradizionalisti piemontesi, la richiesta di suffragio universale venne accolta come una intollerabile provocazione. Così, per scongiurare la scissione del Congresso, venne proposta la seguente formula conciliativa: «Il Congresso esprime il voto che sia riformata la legge elettorale, sì che la classe operaia abbia la giusta sua parte nella nomina dei Deputati». Questa cauta formula venne approvata con una maggioranza di due terzi, e con l’astensione dei rappresentanti di un notevole gruppo di Società, guarda caso quasi tutte piemontesi.
Infine l’unità del congresso fu rinsaldata grazie ai sentimenti patriottici manifestati da tutti i congressisti, che si espressero nell’indirizzo di omaggio a Vittorio Emanuele e a Garibaldi, «invitto Capitano, sorto dalle fila del popolo a capo d’imperterriti volontari». Il congresso di Milano, che si era aperto con un atto di omaggio alla borghesia, si chiudeva con un impegno di patriottismo e di lealismo monarchico da parte delle Società operaie.
Però, oltre l’aspetto macroscopico, ce n’è da segnalare un altro che non fece scalpore e rimase sottaciuto, ma che tuttavia per la prima volta era stato posto. I quesiti di carattere sociale sottoposti alla discussione ebbero in gran parte un contenuto nuovo, e soprattutto quelli proposti dai milanesi: le condizioni igieniche delle fabbriche, le vertenze fra operai e padroni, gli scioperi, la base professionale dell’organizzazione delle Società operaie, ecc. Tutti argomenti che rispecchiavano una società dove il contrasto di classe era più marcato.
Comunque lo sciopero venne condannato come immorale, tanto che il democratico Sineo interpretò l’opinione dominante, di democratici e reazionari, asserendo che «le coalizioni, cagionate talvolta dalla indiscreta avidità dei capi fabbricatori, non sono bene spesso che l’effetto di una lamentevole tendenza all’ozio ed alle illegittime distrazioni». Non restava, dunque, anche in questo caso, che confidare nel «miglioramento morale» degli operai. E per la soluzione delle vertenze salariali fu proposta l’istituzione di consigli di Probiviri «composti di proprietari, di capi-fabbrica, di disegnatori e di operai».
Le soluzioni che questi quesiti ricevettero dal congresso erano
scontate,
lo spirito dominante rimaneva sempre quello di mantenere l’armonia fra
le classi sociali. Ma la novità non risiedeva nella soluzione, bensì
nelle questioni che venivano presentate, al posto di quelle
solidaristiche
solite.
Condizione dei proletari e dei contadini nel Sud
Il congresso di Milano dunque si svolgeva in contemporanea con la conclusione della campagna garibaldina delle Due Sicilie.
Marx il 28 maggio 1860 aveva scritto: «Nell’immediato futuro il successo di Garibaldi, il cui esercito conta appena 12.000 uomini, dipenderà dunque da due importanti circostanze: dal rapido estendersi dell’insurrezione a tutta l’isola e dalla condotta dei soldati napoletani a Palermo. Se questi ultimi vacilleranno ed entreranno in conflitto con i mercenari stranieri che si trovano nelle loro file, il sistema difensivo di Lanza potrà crollare come un castello di carte. Se l’insurrezione acquisterà proporzioni molto consistenti, l’esercito di Garibaldi crescerà in proporzioni ancor più minacciose [...] Se Garibaldi espugnerà Palermo, sarà ufficialmente appoggiato dal “re d’Italia”. Se Garibaldi sarà sconfitto, la sua marcia verrà sconfessata come un’avventura privata. C’è un pathos ironico nelle parole di Garibaldi che, rivolgendosi a Vittorio Emanuele gli dice che avrebbe conquistato per lui una nuova provincia, ma di sperare però che il re non la venderà».
Ma è soprattutto Engels che segue da vicino lo svolgersi della campagna e si entusiasma per il genio militare dell’eroe dei due mondi. Già parlando della «meravigliosa marcia di Garibaldi da Marsala a Palermo», scrive: «Si tratta, invero, di una delle più stupefacenti imprese militari del nostro secolo, impresa che sembrerebbe quasi inconcepibile se non fosse per il prestigio che precede la marcia di un generale rivoluzionario trionfante. Il successo di Garibaldi prova che le truppe regie di Napoli sono tuttora terrorizzate dall’uomo che ha tenuto alta la bandiera della rivoluzione italiana in faccia ai battaglioni francesi, napoletani ed austriaci, e che il popolo della Sicilia non ha perduto fede in lui o nella causa nazionale».
Se la borghesia italiana non fosse ormai in stato di avanzata decomposizione, per il famoso 150° anniversario non avrebbe potuto trovare di meglio che ripubblicare (o almeno plagiare) gli scritti di Marx ed Engels a proposito del suo Risorgimento.
A noi ora interessa lo scritto di un altro personaggio, certamente
non
all’altezza dei padri del comunismo, ma illuminante sulla situazione
siciliana dell’epoca. Cesare Abba, che al seguito dei Mille partecipava
alla spedizione, appena sbarcato in Sicilia rimase colpito dalle
riflessioni
di un frate. E annotava nel suo diario: «Mi sono fatto un amico. Ha 27
anni ne dimostra 40: è monaco e si chiama padre Carmelo [...] Vorrebbe
essere uno di noi per lanciarsi nell’avventura col suo gran cuore, ma
qualcosa lo trattiene dal farlo.
- Venite con noi, vi vorranno tutti bene.
- Verrei, se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero: ma
ho parlato con molti dei vostri, e non mi hanno saputo dir altro che
volete
unire l’Italia.
- Certo; per farne un solo e grande popolo.
- Un solo territorio..! In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre,
soffre; ed io non so che vogliate farlo felice.
- Felice! Il popolo avrà libertà e scuole.
- E nient’altro – interruppe il frate – perché la libertà non
è pane, e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi
piemontesi:
per noi qui no.
- Dunque, che ci vorrebbe per voi?
- Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli
oppressori
grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in
ogni villa.
- Allora anche contro di voi frati, che avete conventi e terre dovunque
sono case e campagne!
- Anche contro di noi; anzi prima che contro ogni altro [... ] Allora
io verrei. Così è troppo poco».
Come si vede il frate siciliano era cento volte più rivoluzionario dei borghesi filantropi che dirigevano le associazioni operaie del Nord Italia liberale e progressista.
Nella introduzione al libro “Nino Bixio a Bronte” Leonardo Sciascia (1963) descriveva così la vita del bracciante siciliano, di quello ritenuto... fortunato: «Le condizioni del “bracciale” di campagna erano tali [...] che viene perfettamente in taglio questo passo di La Bruyère: “Si vedono certi animali selvaggi, maschi e femmine, in giro per le campagne, neri, lividi, nudi e bruciati dal sole, curvi sul terreno che rimuovono e scavano con una straordinaria ostinazione. La loro voce, però, è quasi del tutto articolata e quando si rizzano, mostrano un viso umano: che in effetti sono degli uomini, e a notte sopraggiunta si ritirano nelle loro tane, dove vivono di pane nero, di acqua e di radici. Essi risparmiano agli altri uomini la fatica di seminare, di arare e di raccogliere per vivere; e meritano così di non mancare di quel pane che hanno seminato”.
«Giustamente Courier avvertiva: “badate che egli parla delle persone felici, di quelle che avevano del pane”; e lo stesso avvertimento vale per quanto riguarda il cittadino siciliano: dai tempi di La Bruyère fin quasi ai nostri. Il “decurionato civico” di Bronte, cioè il consiglio comunale, riteneva infatti felici le persone che si trovavano nella condizione descritta dal La Bruyère. Il raccogliere le galle di quercia e i fichi selvaggi, i capperi, i funghi, le mignatte e le rane, non solamente per uso proprio ma per farne “discreto mercimonio, a prezzo vantaggioso” era, secondo i decurioni, nell’anno 1842 di nostra redenzione, il massimo di felicità cui il “bracciale” disoccupato potesse aspirare. I periodi di occupazione del bracciante agricolo erano quelli della semina, della prima e della seconda zappa, della mietitura e trebbiatura: non più di cento giorni all’anno, e con un salario miserevole, di solito anticipato dai padroni, in grano e legumi, al principio dell’inverno, e poi tutta l’annata scontato col lavoro: spietata forma di usura generalmente esercitata dai proprietari fino a pochi anni addietro. Per il resto al bracciante non rimaneva che dedicarsi all’“industria”: ché “industrioso” o “industriale” era chiamato chi a quel “discreto mercimonio” si dedicava [...]
«Su gente come questa cadevano contravvenzioni (generalmente per
evasione
al balzello del macinato e quasi sempre convertite in carcere),
pignoramenti
per usure non pagate, tassazioni arbitrarie, accuse di furto (di solito
per legna raccolta nei boschi ducali o comunali) [...] E quando i
guardaboschi
della signora duchessa di Bronte o quelli del comune sorprendevano
qualcuno
a far legna erano guai grossi: un’ammenda pari al valore dell’albero
vivo e non della legna, e non meno di un mese di carcere. Si trovano
registrate
ammende fino a 39 ducati: somma che il bracciante non riusciva a
buscare
in tutta una vita».
Insurrezioni al Sud e reazione borghese
Mentre nell’Italia settentrionale dovranno passare ancora molti anni prima che si manifestino vere e proprie agitazioni contadine con carattere rivendicativo classista, nel Meridione la questione sociale, come disse Cavour, «era entrata nel suo stadio acuto» nel momento stesso in cui si realizzava l’unificazione. Il fatto sta che il popolo identificava il nemico nel borghese, e per lui non faceva nessuna differenza se il borghese fosse borbonico o... patriota.
La famosa rivolta di Bronte non fu un caso isolato ma una delle tante che incendiarono la Sicilia. Tra giugno e luglio molti furono i paesi in cui la plebe al grido di: “Vogliamo la divisione della terra”, “Abbasso li cappeddi”, “morte ai sorci!” seminò terrore e morte non solo tra i proprietari terrieri ed i lealisti borbonici, perché, nel moto dell’insurrezione l’odio di classe era alimentato da rancori secolari repressi e voglia di vendetta: Nicosia, Reagalbuto, Polizzi, Cesarò, Randazzo, Maletto, Cefalù, Petraia, Resuttano, Castelnuovo, Montemaggiore, Capace, Tusa, Castiglione, Collesano, Biancavilla, Recalmuto, Centuripe, Mirto, Caronia, Alcara li Fusi, Missorìa, Cerami, Mistretta, Linguaglossa, Adernò, etc.
Quando oltre 30 anni dopo si ebbe il moto dei “fasci” di Sicilia, questa volta autentica battaglia della guerra di classe fra proletari e borghesi, al processo che ne seguì, un teste, l’avvocato Battaglia, possidente di Palazzo Adriano, descriveva con queste testuali parole la miseria dei contadini che, non avendo nient’altro, si nutrivano con i finocchi selvatici crudi: «I contadini prima del 1812, quando esisteva il feudo, avevano assicurata l’esistenza, fuorché nelle annate cattive, ma soppressi i feudi divennero salariati e le loro condizioni furono sempre peggiorate, perché non esiste la mezzadria, ma la quinteria».
A questo punto non sarà male rileggerci un brano di un nostro testo classico del 1950, dal titolo: “Il Rancido Problema del Sud Italiano”, dove sta scritto: «Un rivoluzionario autentico, Carlo Pisacane, precorritore assai significativo del movimento socialista, prevedeva bene questo stadio acuto, come sbocco delle situazioni rivoluzionarie, nell’annessione sabauda. Ecco le sue parole, scritte a Genova il 24 giugno 1857, alla vigilia della spedizione in Calabria: “Sono convinto che i rimedi temperati, come il regime costituzionale del Piemonte e le migliorie progressive accordate alla Lombardia, ben lungi dall’avvicinare al Risorgimento, non possono che ritardarlo. Per me, non farei il minimo sacrificio per cambiare un ministro, per ottenere una costituzione, nemmeno per cacciare gli Austriaci dalla Lombardia e accrescere il regno Sardo; per me dominio di Casa Savoia o dominio di Casa d’Austria è precisamente lo stesso. Credo eziandio che il reggimento costituzionale del Piemonte sia più dannoso all’Italia che la tirannide di Francesco II”.
«In questo stesso scritto, benché non sia quello che tratta le
vedute
economiche e sociali del magnifico lottatore, vi sono risolute
enunciazioni
come queste: “Sono convinto che il miglioramento dell’industria, la
facilità del commercio, le macchine, ecc., per una legge economica e
fatale,
finché il riparto del prodotto è frutto della concorrenza, accrescono
questo prodotto ma l’accumulano sempre in ristrettissime mani e
immiseriscono
la moltitudine; e perciò questo vantato progresso non è che regresso.
Se vuole considerarsi come progresso, lo si deve nel senso che,
accrescendo
i mali della plebe, la sospingerà a una terribile rivoluzione, la quale
cangiando d’un tratto tutti gli ordinamenti sociali, volgerà a profitto
di tutti quello che ora è a profitto di pochi”. E più oltre si trova
quest’altra recisa tesi, fin da allora diametralmente gettata contro
la superstizione democratica: “Le idee risultano dai fatti, non questi
da quelle, e il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà
educato quando sarà libero”. Segue l’aperta difesa del metodo della
cospirazione, dell’insurrezione, dell’azione delle minoranze,
apprezzabilissima
scientificamente in rapporto ai tempi» (Prometeo, novembre
1950).
Il conte di Cavour, esemplare della borghesia italica
Il pericolo che nella rivoluzione nazionale si innestasse quella sociale era sentito soprattutto da chi dalla prima aveva tutto da guadagnare. A questo proposito sarebbe interessantissimo rileggersi le lettere di Cavour indirizzate ad ambasciatori, ammiragli, generali, uomini politici ed avventurieri vari al fine di sabotare la spedizione garibaldina. Ne estrapoleremo solo alcuni passaggi significativi
- 14 luglio 1860 scrive a La Farina: «Conviene impedire ad ogni costo che Garibaldi passi sul continente da un lato, e dall’altro promuovere un moto in Napoli. Se questo ha un esito felice, si proclamerebbe senza indugio il governo di Vittorio Emanuele. Questo accadendo Lei dovrà immediatamente partire con tutta la squadra [navale] recandosi a Napoli. Condurrà seco le navi napoletane, quand’anche Garibaldi non vi acconsentisse. Perciò ella avrà cura di tenersi in frequente relazione col cap.no Anguissola e con gli altri comandanti di legni napoletani. Quando questi difettassero di danaro per pagare gli equipaggi, gliene somministrerà».
- 30 luglio 1860 al marchese S. di Villamarina, ambasciatore del Piemonte a Napoli: «È grandemente desiderabile che la liberazione di Napoli non proceda per opera di Garibaldi; giacché, ove ciò avvenga, il sistema rivoluzionario prenderà il posto tenuto dal partito costituzionale monarchico. Se il Dittatore giunge vittorioso nella capitale del regno, s’impianterà la rivoluzione, l’anarchia [...] S’aggiunga il suo pazzo disegno d’andare a Roma, a dispetto e contro la Francia. Ciò sarebbe la completa mina della causa italiana. È quindi necessario, che in Napoli abbia luogo un movimento nazionale, prima che Garibaldi vi giunga. Il tentativo è pericoloso; ma è necessario d’impedire che la rivoluzione non trabocchi in Napoli».
- 30 luglio 1860 al contrammiraglio conte di Persano: «Sig. Ammiraglio, Il marchese Villamarina gli avrà trasmesso il telegramma che le ordinava di recarsi a Napoli colla [pirofregata] Maria Adelaide. Scopo apparente di questa sua missione si è di tenersi a disposizione della Principessa di Siracusa, sorella del Principe di Carignano, cugina del Re. Scopo reale è di cooperare alla riuscita di un piano che deve far trionfare in Napoli il principio nazionale, senza l’intervento di Garibaldi. Principali attori in esso debbono essere il ministro dell’interno signor Liborio Romano, ed il generale Nunziante. Ella sarà posta in relazione con questi due personaggi dal sig. barone Nisco che giungerà a Napoli sul Tanaro e gli consegnerà una lettera da parte mia. Vedrà di agire colla massima circospezione, cercando tuttavia d’ispirare ad essi fiducia ed ardire. Credo che possiamo fare assegnamento su di loro. Sul ministro perché vecchio liberale unitario, provato ed onesto; sul generale perché ci ha dato tanto in mano da farlo impiccare se occorre. Il Tanaro che lo raggiungerà a Napoli con dei viveri avrà a bordo delle casse e di fucili ch’ella porrà a disposizione del ministero. Sbarcati i fucili, penso che sarà facile concertare il moto progettato. Ad esso dovranno possibilmente partecipare i legni da guerra napoletani che saranno nel porto».
Dopo che il moto caldeggiato dal Cavour non venne messo in atto perché, malgrado le promesse di sollevazione avute dal Villamarina, i moderati di Napoli non si mossero, e non fu più possibile scongiurare l’arrivo di Garibaldi, il 31 agosto, Cavour scriveva ancora al contrammiraglio Persano: «Il governo ammette come fatto ineluttabile l’arrivo del generale Garibaldi a Napoli. Solo confida che gli onesti, aiutati da lei e dal marchese Villamarina giungeranno a persuaderlo a non ripetere gli errori commessi in Sicilia, e che chiamerà al potere persone dabbene, devote alla causa dell’ordine, della libertà, dell’unità. Ciò non toglie che potendo ella non abbia ad impadronirsi dei forti, e raccogliere sotto il suo comando l’intera flotta [...] Onde impedire che la rivoluzione si estenda nel nostro regno, non havvi oramai che un mezzo solo: rendersi padroni senz’indugio dell’Umbria e delle Marche. Il governo è deciso a tentare questa ardita impresa qualunque possano esserne le conseguenze. A questo scopo, ecco ciò che fu stabilito. Un movimento insurrezionale scoppierà in quelle Provincie dall’8 al 10 settembre. Represso o non represso noi interverremo. Il generale Cialdini entrerà nelle Marche e si porterà rapidamente avanti Ancona».
Napoli fu presa da Garibaldi, ma subito dopo la città veniva invasa dagli uomini del Cavour, agenti, luogotenenti, proconsoli, consiglieri, generali, mentre i borbonici comprati si trovavano già in loco. A Mazzini fu consigliato che, per la sua stessa incolumità, avrebbe fatto cosa buona lasciando la città. «Anche non volendo voi ci dividete», gli scriveva il Pallavicino; Mazzini capisce l’antifona e scrive: «Mi suonano, mentr’io scrivo, all’orecchio, le grida di morte! Che un pugno d’uomini, comprati dalla gente che s’intitola moderata, o pazzamente briachi, mi s’avventa contro». Mazzini non rappresentava certo un pericolo per la monarchia, ed infatti mai gli si era schierato contro; non lo aveva fatto nel 1831, come non lo aveva fatto nel 1848 o nel 1859.
Nel 1831 a Carlo Alberto aveva scritto in questi termini: «Uniteci Sire, noi ci annoderemo d’intorno a voi: noi vi profferiremo le nostre vite; noi condurremo sotto la vostra bandiera i piccoli Stati d’Italia», e nel 1860 a Vittorio Emanuele II: «Sire, l’Italia rinasce. La sua nazionalità è oggi un fatto avverato. Eravamo ieri 4 milioni e mezzo di sudditi sardi, noi siamo oggi 22 milioni d’Italiani stretti a concordia attorno ad una sola bandiera». Ma non è tutto, Mazzini non solo si sarebbe accontentato di una monarchia, ma perfino di una teocrazia. L’8 settembre 1847 aveva inviato una lettera a Pio IX il cui testo in poco tempo fece il giro d’Europa. In questa lettera Mazzini abiurava tutta la sua dottrina fino ad allora propagandata; vi si legge: «Unificate l’Italia, la patria vostra. E per questo non avete bisogno d’oprare, ma di benedire chi oprerà per voi e nel vostro nome. Noi vi faremo sorgere intorno una nazione al cui sviluppo libero e popolare, voi vivendo presiederete. Noi fonderemo un governo unico in Europa, che distruggerà l’assurdo divorzio fra il potere spirituale ed il temporale; e nel quale voi sarete scelto a rappresentare il principio, del quale gli uomini scelti a rappresentare la nazione faranno le applicazioni».
È evidente quindi che, anche a Napoli, Mazzini non avrebbe mai messo a rischio la monarchia. Ma una cosa era lui come persona ed altra cosa era come Mazzini veniva inteso dal popolo: rivoluzionario, antimonarchico e repubblicano. Quindi era bene che da Napoli sloggiasse.
Non per niente lo stesso Garibaldi, che il 26 ottobre a Teano aveva
fatto dono al re dell’ex Regno delle Due Sicilie, dovette abbandonare
il terreno ed imbarcarsi per il suo rifugio di Caprera. Scriveva: «Qui
finisce il glorioso periodo delle nostre battaglie, nella campagna del
‘60. L’esercito settentrionale, comandato dal re, subentrava alla
conclusione
della guerra, e ben presto si poté capire, che non si desiderava il
nostro
contatto [...] Il 9 dunque di novembre io navigavo per Caprera e vi
giungevo
il 10». Una ventina di anni dopo Alberto Mario, che all’incontro di
Teano aveva partecipato, scriveva: «Garibaldi alle sei antimeridiane
acclama
re d’Italia Vittorio Emanuele regalandogli le Due Sicilie, alle sette
il re non lo invita nemmeno a colazione» (“La Lega della Democrazia”,
24 gennaio 1882).
Dalla rivoluzione nazionale alla lotta di classe proletaria
Forse sarebbe arbitrario asserire che, prima del 1860, movimenti proletari strutturati fossero presenti nelle lotte rivoluzionarie del ‘21, del ‘31 e del ‘48 e che dichiaratamente si fondassero su lavoratori salariati, distinti dai lavoratori autonomi urbani e rurali, artigiani o piccoli contadini, non erano visibili né molto probabilmente esistevano. Ma i proletari indubbiamente lottarono nelle file della rivoluzione anche se confusi con altri ceti popolari. Anzi le numerose citazioni da Marx ed Engels riportate nel corso dei precedenti rapporti ci confermano che il proletariato rappresentò la punta più avanzata di ogni rivolta insurrezionale. D’altra parte nel trapasso dal pre-capitalismo al capitalismo il proletariato storicamente si schiera sempre, e si deve schierare, a fianco della rivoluzione nazionale. Il problema è, per la borghesia, che subito dopo il proletariato supera questo stadio e comincia a lottare per sé.
L’unificazione d’Italia non solo non venne accompagnata da miglioramenti economici per i lavoratori, al contrario dalle Alpi alla Sicilia le loro condizioni peggiorarono sensibilmente ed immediatamente. Questo stato di fatto produsse un risveglio generale dell’antagonismo di classe. Iniziati da Napoli nel febbraio 1861, gli scioperi di intere categorie di lavoratori, fino ad allora episodi limitatissimi, divennero abituali e dilagarono senza eccezione alcuna in tutte le città del nuovo Regno, e senza eccezione alcuna il governo del nuovo Regno represse tutte quante le agitazioni con la massima violenza.
Il fatto che il maggior numero di scioperi operai si verificasse nel Sud d’Italia, ed in modo particolare a Napoli, dava il pretesto alle classi dominanti ed ai giornali governativi di presentarli come frutto di trame borboniche o clericali; solo che così non potevano presentare quelli scoppiati nel Centro e nel Nord: in questi casi la medesima violenta repressione veniva giustificata in altra maniera. “La Nazione” di Firenze il 18 giugno, commentando l’arresto di alcuni fornai scioperanti, scriveva: «Il paese non vuole disordini [...] Il tempo degli arbitrii e delle violenze è finito per il governo e per la piazza. E arbitrii e violenze di piazza sarebbero questi che si vanno eccitando, sotto insussistenti pretesti, onde scomporre la quiete pubblica [...] Questi giovani operai non debbono dimenticare che il codice penale provvede severamente a simili licenze».
L’unità d’Italia determinò anche la nascita di sempre nuove Società operaie svincolate dal paternalismo padronale (caratteristica di quelle piemontesi), nelle quali gli iscritti non tardarono a portare, anche se in modo confuso, gli interessi delle loro condizioni di lavoratori: sempre più spesso i problemi dibattuti riguardavano i salari e gli orari di lavoro. Le nuove Società operaie erano tutte quante caratterizzate da un orientamento spiccatamente democratico e repubblicano. Nella sostanza però si trattava sempre di organizzazioni con ideologia interclassista.
Tanto per fare un esempio, il primo articolo dello statuto della
Fratellanza
Artigiana di Firenze, sorta nel 1861, recitava: «In nome della Patria,
dell’Umanità e del Progresso, gli Artigiani d’Italia, usando le libertà
che i tempi nuovi concedono, fanno fratellanza per cooperare al
miglioramento
intellettuale, morale e materiale della loro classe, mediante la
istruzione,
il soccorso reciproco ed il credito». L’associazione si diffuse
rapidamente
in tutta la Toscana, con l’intendimento di «associare l’istruzione
all’educazione, il lavoro al capitale», e riunire quanti «sudano nelle
officine e nei campi in uno stesso principio di amore fraterno». Non
c’è
da meravigliarsi di questo programma in quanto la quasi totalità dei
fondatori
erano i maggiori rappresentanti della massoneria toscana. La
Fratellanza
Artigiana esercitò il mutuo soccorso, aprì scuole serali e festive,
istituì
corsi speciali di economia. Sulla fine del 1861 contava già 1.500 soci.
La vuota ideologia borghese di Giuseppe Mazzini
A questo punto a noi interessa vedere il rapporto tra il movimento operaio, una volta apparso, con le correnti politiche borghesi/rivoluzionarie dell’Italia unita.
Riprendiamo ancora la lettura di un nostro testo, “Meridionalismo e moralismo” in ”Programma Comunista” n. 20 del 1954: «Queste [correnti borghesi] erano molteplici avendo in comune il postulato di unità-indipendenza politica, e il programma di abbattere i poteri dell’amministrazione austriaca nel nord e degli Stati autocratici nel centro e nel sud, compreso quello del papa, sostituendovi un governo unico parlamentare. Ma si distinguevano in diverse correnti, secondo che erano centraliste o federaliste, monarchiche o repubblicane o anche cattolico-unitarie.
«Protagonista della conquista del potere da parte dello Stato piemontese e della sua monarchia era il generico partito liberale costituzionale; fautore deciso della soppressione del potere papale e della capitale in Roma il partito di azione [...] Mazzini impersonava il partito repubblicano, di cui in senso lato era parte Garibaldi: dopo il 1860 non solo il secondo ma anche il primo, indubbiamente rivoluzionari non a metà, considerano vittoriosa la conclusione monarchica del ciclo, e ciò tanto più colla breccia di Porta Pia. Garibaldi si restringe a Caprera, Mazzini si allarga all’Europa. All’opposizione del governo liberale in Italia si trovano dunque – prima che quello si scinda in destra e sinistra e poi nei loro trasformistici camuffamenti – una democrazia radicale borghese ed un partito repubblicano anche borghese, forse più di tutti conservatore.
«Questi partiti guardarono dunque agli operai, è storico, con diversi intenti, ma che si riducono a quelli di Mazzini: il proletariato è un formidabile strumento della rivoluzione, per la rivoluzione. Organizzare e propagandare dunque i lavoratori non per un movimento nuovo, ad essi ed essi soli proprio, ma come massa di azione ai fini, già dati, di una Rivoluzione [...] È dunque giusto dire che “Mazzini aveva pensato di servirsi della classe operaia italiana come pietra basilare della rivoluzione nazionale, e per questo propugnò l’unificazione delle classi operaie europee”.
«Gli elementi avanzati della classe operaia non furono in primo tempo sordi a tali appelli, e si staccarono dai liberali e dai cattolici in larga misura. Ma non poteva bastare loro il programma di Mazzini, almeno dal momento che le sue richieste di rovesciamento di quanto sopravanzava di feudale (poco in Italia) e di introduzione delle libertà giuridiche ed elettive erano un fatto compiuto. L’istinto di classe degli operai li avvertiva fino da allora che la questione istituzionale, come si diceva, ossia l’alternativa tra re e repubblica, non poteva avere un contenuto rivoluzionario».
Con l’estendersi della organizzazione operaia ed il moltiplicarsi delle Società di mutuo soccorso sempre maggiore si sentiva la necessità di riunire i vari nuclei in una sola grande associazione. Il numero e l’intensità degli scioperi aumentava e alcuni gruppi più avanzati, per esempio i tipografi, cominciavano a costituire delle casse di resistenza e qua e là si riusciva perfino ad imporre tariffe di lavoro.
Gli elementi mazziniani capirono l’importanza e la forza che il loro partito avrebbe acquistato se fossero stati in grado di prendere la direzione del movimento operaio e non se ne fecero scappare l’occasione dando una spinta vigorosa all’incerta tendenza organizzatrice, e prospettando via via soluzioni pratiche ai molteplici problemi della vita operaia individuale e collettiva.
Ma per Mazzini la soluzione del problema operaio non poteva venire che a seguito di una grande rivoluzione morale, religiosa, istituzionale del paese, Mazzini cioè legava la questione sociale a quella politica allo scopo di servirsi dei nuclei operai come centri di propaganda delle sue dottrine politiche insurrezionali. Mazzini si rivolgeva dunque al proletariato ed alla sua organizzazione, ma come strumento per il compimento della rivoluzione nazionale; la questione sociale sarebbe stato un problema da affrontare in un secondo tempo, dopo il conseguimento dell’unità nazionale, ed a patto che il proletariato all’unità nazionale avesse contribuito. Scrivendo alla Società operaia di Napoli affermava: «E perché le classi operaie abbiano diritto agli aiuti della Nazione, è necessario che si mostrino pronte a compiere il loro dovere vers’essa» (11 agosto 1861); ed alla Società operaia di Genova: «Aiutando noi tutti al conseguimento del fine nazionale, voi meriterete il conseguimento del fine sociale, che è vostro diritto» (11 novembre 1863).
In vista del nono congresso delle Società operaie italiane che si tenne a Firenze nel settembre 1861, Mazzini preparò accuratamente il suo piano di conquista delle organizzazioni operaie. La sua influenza sulle Società di antica data non era che scarsa e limitata, ma quelle sorte nell’ultimo biennio si ispiravano nella loro maggioranza alle sue dottrine e, in molti casi, gli avevano offerto la presidenza onoraria. Questo fatto gli dava l’autorità di impartire istruzioni e direttive di comportamento in vista del prossimo congresso.
Il suo programma venne sintetizzato nella lettera inviata da Londra il 14 agosto 1861 alla Società Operaia di Bologna, nella quale affermava energicamente il diritto delle Società operaie e dei loro congressi di occuparsi di politica (per politica intendeva soprattutto il compimento dell’unità nazionale riassunto nel binomio Roma e Venezia) e ribadiva la necessità di insistere nella richiesta del suffragio universale. Ma oltre a questo, e ciò è l’aspetto più importante, rivendicava la formazione di una organizzazione operaia unitaria nazionale. Chiaramente Mazzini non aveva nessuna intenzione di scatenare la lotta di classe, il suo scopo era quello di dare al suo partito di opposizione (leale più che legale) una solida e larga base operaia.
La questione organizzativa era perciò al centro delle sue
preoccupazioni,
mentre i moderati, che avevano compreso il pericolo che una
organizzazione
proletaria nazionale poteva comportare, al contrario miravano a
mantenere
la labile organizzazione dei congressi e delle commissioni permanenti
stabilita
dal Regolamento di Genova. In contrapposizione aperta con Mazzini
c’erano
i vecchi dirigenti moderati piemontesi capeggiati dal Boitani,
segretario
della Società degli Operai di Torino, ma che, guarda caso, era anche un
funzionario del Ministero delle Finanze, distaccato da Cavour, otto
anni
prima, suo uomo di fiducia alla segreteria della Società.
Il congresso di Firenze
La Commissione permanente, controllata dai filo governativi, aveva ricevuto centotredici quesiti da proporsi alla discussione. Tra questi undici riguardavano delle questioni politiche e, di conseguenza, erano stati esclusi. “La Nazione” di Firenze si congratulò con la Commissione avendo compreso «quanto non solo inutile ma dannoso sarebbe stato seguire i consigli che dava il Mazzini»; e continuava, se le Società operaie di mutuo soccorso «si convertissero in conventicole politiche, la loro natura sarebbe falsata, il loro scopo mancherebbe, la loro prosperità sarebbe compromessa dal sospetto e dalla diffidenza, che sono la morte della carità». E terminava augurandosi che il congresso non si facesse strumento della «diffusione di false dottrine economiche, che per ora in Italia non sono penetrate nel popolo. V’hanno quesiti, dal modo di svolgere dei quali dipende il vedere se si vogliono o tener lontane dagli operai o infiltrare in essi certe massime, che può glorificare la scuola socialista, ma non può non condannare chiunque, non diremo profondo, ma sia alcun poco iniziato nello studio dei sani principî economici».
Ma il compiacimento della “Nazione” durò poco.
Così il congresso di Firenze si apriva con due schieramenti in netta contrapposizione: i mazziniani determinati a portare il movimento operaio sul terreno dell’opposizione politica, ed i liberal-governativi che, forti della consolidata tradizione, erano decisi a mantenere le Società operaie ed i loro congressi al di fuori della lotta politica, limitando la loro azione al mutuo soccorso. Poi, come sempre accade, c’era una terza tendenza conciliativa tra i due schieramenti.
A scorno dell’opposizione dei moderati e di quanto aveva deliberato la Commissione permanente, il congresso di Firenze mise in discussione quella che era la questione pregiudiziale; ossia se le Società operaie dovessero occuparsi di politica. Tra le opposte tesi dibattute prevalse alfine quella presentata dal repubblicano Montanelli, formulata nel modo seguente: «L’assemblea dichiara che le questioni politiche non sono estranee ai suoi instituti quante volte le riconosca utili al loro incremento e consolidamento». La mozione passò con 74 voti contro 30, ma c’è da dire che più di 100 delegati, al momento del voto avevano già abbandonato il congresso in segno di protesta contro la violazione dei regolamenti.
Eliminata la pregiudiziale contro la politica i democratici, rimasti praticamente soli, ebbero buon gioco a introdurre i termini proposti da Mazzini: l’unificazione delle Società operaie in un organismo a base nazionale e la rivendicazione del suffragio universale.
Si affermò che l’emancipazione dei lavoratori sarebbe restata sempre una pura utopia fino a quando non vi fossero state delle leggi a favore della classe operaia. Leggi che favorissero l’istruzione, specialmente quella tecnica e professionale, che assecondassero il movimento associativo degli operai, garantissero il lavoro e ne tutelassero la salubrità, provvedessero alla vecchiaia dell’operaio. Ma queste leggi mai sarebbero state fatte se non da deputati che recassero in parlamento la «espressione sincera dei bisogni e delle esigenze della parte più numerosa e meno corrotta della popolazione»; e simili deputati non potevano essere eletti se non dai lavoratori medesimi.
Secondo il Savi «l’artigiano [artigiano come sinonimo di lavoratore] deve avere il diritto di nominarli, come ha il diritto di nominarli il dotto che desidera promosso l’insegnamento e le discipline scientifiche, il commerciante che cerca allargare ed agevolare i commerci, l’industriale che si affatica per l’incremento e la perfezione delle industrie. È tempo che ogni necessità sociale abbia un organo, ogni categoria di cittadini una rappresentanza legale nelle assemblee legislative della nazione. Il lavoro nel senso comune della parola non è rappresentato finora [...] Importa che l’operaio, questo povero reietto, che paziente ha traversato secoli invocando la giustizia sociale, ed ha aspettato sempre alla porta, entri esso pure».
L’assemblea votò per l’unificazione delle Società, per il suffragio universale e per l’istruzione laica e obbligatoria, e infine adottò “I Doveri dell’Uomo” di Mazzini come testo per l’educazione dell’operaio. Così tutti i punti programmatici, indicati nella lettera di Mazzini agli operai di Bologna, avevano ottenuto pieno successo.
Restavano ancora da svolgere i numerosi quesiti di carattere sociale, la cui lunga serie ci offre un quadro molto ampio delle condizioni e delle aspirazioni dei lavoratori italiani nel momento della formazione del Regno d’Italia.
Se al Congresso di Milano si erano affacciati i problemi propri della classe operaia, un allargamento notevole si ebbe a Firenze dove vennero abbracciati gli aspetti generali della questione sociale: condizioni di vita dei lavoratori, salari, orario di lavoro, abitazioni, disoccupazione, concorrenza della mano d’opera straniera tecnicamente più qualificata, scioperi e arbitrato nelle lotte del lavoro, ecc.
Nel passato, ogni volta che nei congressi si erano presentate, le questioni sociali erano state pregiudizialmente respinte, come se ignorandole fosse bastato a scongiurarle. Questa politica, prevalsa anche nel Congresso di Milano, dovette essere affrontata a Firenze, anche se con non troppo entusiasmo, sui seguenti quesiti: “Come si possa ottenere sollecito e completo il riscatto delle plebi” e “Come si possano migliorare le condizioni morali e materiali del proletario”.
Ormai non si poteva più far finta che la lotta di classe non esistesse, scioperi scoppiavano e si susseguivano da un capo all’altro del nuovo Stato. Le “funeste scissure tra imprenditori ed operai”, come le definiva il Guerrazzi, erano divenute ormai un “male troppo frequente”: occorreva pronunciarsi sul comportamento che le Società avrebbero tenuto di fronte alle lotte economiche dei lavoratori, alle loro richieste di più alti salari, di migliori condizioni di lavoro. Ma, ancora una volta, le Società operaie si ponevano di fronte al problema e lo affrontavano con tipico orientamento interclassista: intervenire nei conflitti del lavoro e cercare di sanarli attraverso “amichevoli accordi”.
Venne richiesta l’abrogazione degli articoli del codice penale che, derivati dalla legge Le Chapelier, vietavano le coalizioni operaie. Tuttavia la richiesta abrogazione del divieto di coalizione, che presentava lo Stato borghese senza maschera, poteva servire a ben poco se contemporaneamente si continuava a negare, o meglio, a condannare la lotta di classe.
Il congresso dichiarò “urgentissima” la questione dei salari; ma allo stesso tempo dichiarò “funesto essere agli operai ogni sciopero ed ogni mezzo violento”. Secondo i mazziniani i conflitti del lavoro si sarebbero dovuti risolvere attraverso l’intervento di “uomini probi e retti scelti nel seno delle Società e tra gli amici degli operai”, che avrebbero dovuto adoperarsi per ottenere “equi e cristiani provvedimenti” di aumento di salari e di riduzione delle ore del lavoro.
La vittoria dei mazziniani risultò parziale e modesta tenendo conto della secessione della metà dei delegati. Unico dato positivo fu, come abbiamo detto, il riconoscimento della necessità di una organizzazione strutturata a livello nazionale. Così l’assemblea, che all’inizio dei lavori aveva eletto Garibaldi a presidente, e aveva ricordato Mazzini, “quel grande che ancor soffre nell’esilio”, si concluse al grido conciliante di “Viva il Re galantuomo, Viva Garibaldi”.
«Noi non pensavamo – scriveva “La Nazione” commentando il congresso – che la Toscana, dove le idee di libertà economica sono ormai passate nel sangue di tutti, potesse venir prescelta a discutere di argomenti pigliati a prestito dalla scuola socialista [...] e usati sempre ad eccitare nelle masse incivili passioni».
I moderati che avevano abbandonato il congresso scatenarono subito una violenta campagna antimazziniana fortemente sostenuta da tutta la stampa governativa. Così, il 6 ottobre, la Società operaia di Torino diramava a tutte le consorelle d’Italia un appello nel quale il Congresso di Firenze era definito “nullo e illegale” e avanzava la proposta di convocare in Asti un’assemblea di tutte le Società dissidenti. L’appello era di una intransigenza estrema e manifestava una decisa volontà di rottura con i democratici. I moderati assumevano per la circostanza un tono demagogicamente operaistico: sostenevano che a Firenze non si era rispettata la proporzione fissata dal Regolamento fra soci effettivi e soci onorari e proponevano quindi che all’assemblea partecipassero soltanto “veri operai effettivi”.
I piemontesi capirono però che una posizione di intransigenza li avrebbe condannati all’isolamento, quindi attenuarono subito i toni, come dimostra la circolare del successivo 24 ottobre, diramata congiuntamente dalle Società di Torino e di Asti. In questa nuova circolare si dichiarava di non nutrire ostilità verso il congresso di Firenze, che non si intendeva provocare scissioni, ma che la riunione aveva lo scopo conciliativo, ossia di «raccogliere e riordinare sotto l’antica bandiera di mutuo soccorso le associazioni che si scompigliarono a Firenze nelle gare delle passioni politiche».
Il controcongresso di Asti, che inizialmente era stato definito “riparatore”, venne poi qualificato “conciliatore”; tuttavia le Società che si fecero rappresentare ad Asti erano quasi esclusivamente piemontesi. Ad Asti venne approvata una mozione la quale ribadiva che «lo scopo della Società di Mutuo Soccorso non è la trattazione della politica e che per la propria conservazione e per l’incremento del bene popolare le Società Operaie debbano anzi astenersene» e dichiarava di «non ammette[re] dubbio che l’Operaio possa con ciò essere ugualmente buon cittadino e buon patriota».
In più venne nominata una “giunta” di sette membri incaricata di prendere contatto con la Commissione permanente eletta a Firenze per cercare un accordo. Le delegazioni di Firenze ed Asti non ebbero difficoltà a trovare un accordo riconoscendo che la mozione Montanelli, votata a Firenze, non era contraria al Regolamento di Genova e si stabiliva che in base ad essa si sarebbe d’ora innanzi giudicato sull’esclusione e sull’ammissione dei quesiti da discutere nei congressi. Le Società convenute in Asti si impegnavano inoltre a farsi rappresentare al decimo congresso.
Ciò rappresentava la capitolazione su tutta la linea dei moderati che riconoscevano la piena validità del Congresso di Firenze e dei suoi deliberati. I filo-governativi, rimangiandosi la fiera sconfessione data, tornavano in seno a quella “congrega” mazziniana contro la quale i loro giornali avevano scagliato i più violenti attacchi e che nel primo proclama di protesta avevano qualificato come “l’impero dell’apostolo della sistematica rivolta al governo” e “fucina delle sventure nazionali”.
E nel luglio 1862 le due commissioni permanenti, di Firenze e di
Asti,
dichiararono che gli incresciosi fatti del ‘61 erano dovuti più ad un
equivoco che a una differenza reale di principi. Infatti a Firenze si
era
ammessa la trattazione delle questioni politiche «non in un modo
assoluto,
ma solo ogni qualvolta si riferissero all’esistenza e al consolidamento
delle Società artigiane», ed il Congresso di Asti non aveva inteso
«escludere
la politica in modo assoluto e non poteva non ammetterla quando si
trattasse
d’interessi vitali per le classi popolari». La formula proposta dal
Montanelli a Firenze veniva accettata di comune accordo come norma per
il futuro.
Nuovi tentativi garibaldini
In contemporanea a queste vicende Garibaldi guadagnava in maniera progressiva fiducia sia negli ambienti della democrazia, della quale veniva ormai riconosciuto capo indiscusso, sia come patrono, sempre più invocato, della classe operaia. Molte delle nuove Società operaie all’atto della loro fondazione si mettevano sotto la sua egida, e Garibaldi ad ognuna di essa accordava la sua espressa adesione.
Il 10 marzo 1862 era stata costituita la Società Emancipatrice, che riuniva tutte le associazioni democratiche concordi nel programma patriottico che si riassumeva nel motto: “Roma e Venezia”. All’indomani della sua costituzione Garibaldi riunì a Quarto i membri della Commissione permanente eletta a Firenze e li persuase a tentare la conciliazione, incitando tutte le frazioni della classe lavoratrice a cooperare al bene della patria comune.
Intanto, morto Cavour e caduto Ricasoli, si era formato il governo Rattazzi. Il partito garibaldino allora parve rinforzato e, fidando nel nuovo governo, credette di poter iniziare l’azione per Venezia e per Roma. Garibaldi da Genova partì per la Lombardia, stanziandosi a Trescorre presso il confine veneziano, dove assieme ai suoi veterani metteva a punto il piano di una spedizione in Veneto. Il Ministero, che dapprima lo aveva lasciato fare o addirittura incoraggiato, al momento dell’azione, fece arrestare a Sarnico e a Palazzuolo un gruppo di garibaldini che si accingevano a passare il confine (maggio 1862). La Società Emancipatrice, che rappresentava il focolaio dell’agitazione, fu sottoposta a una sorveglianza strettissima, così come tutti i nuclei democratici e le Società operaie che ad essa aderivano. Ai primi di giugno Rattazzi presentò alla Camera un progetto restrittivo della libertà di associazione.
Allo stesso tempo le condizioni del paese si facevano sempre più gravi a causa delle agitazioni generali accompagnate dalla minaccia di una sedizione armata che si andava delineando; sia con il viaggio e la permanenza di Garibaldi in Sicilia, sia con la partenza di gruppi di giovani per il Mezzogiorno, sia con quotidiani tumulti all’interno delle grandi città. Rattazzi moltiplicò gli arresti, i sequestri di giornali democratici, le perquisizioni presso privati cittadini e le sedi delle varie Società operaie, sospette di favorire il movimento insurrezionale. Infine, con decreto del 20 agosto sciolse la Società Emancipatrice e tutte le organizzazioni aderenti.
Il 29 agosto si ebbe lo scontro di Aspromonte. Garibaldi, ferito ed
arrestato, venne incarcerato al Varignano; infatti per paura di
sollevazioni
popolari era stato ordinato di trasferirlo «separato dagli altri
prigionieri,
al forte di Savona, o altro più prossimo, purché sicuro e lontano dalle
città popolose». Gran parte delle Società operaie furono sciolte,
inquisite,
o comunque costrette a sospendere la loro attività. Con lo scioglimento
venne a mancare quel minimo di soccorso che le Società assicuravano ai
soci poveri, malati o bisognosi.
Stato d’assedio
Il successo dei mazziniani sembrò destinato a durare ben poco. La politica repressiva del Rattazzi fece sì che i filo-governativi trionfassero di nuovo. I cosiddetti moderati avevano ora buon gioco nell’accusare i democratici di subordinare gli interessi operai ai loro fini politici. E alle loro posizioni si accostarono molti nuclei operai che erano stati vittime della repressione statale. La Commissione permanente eletta a Firenze fu costretta ad ammettere che, in quelle condizioni, era assolutamente impossibile convocare il Congresso operaio: «Lo stato d’assedio proclamato nelle province napoletane e siciliane – affermava – non permetterebbe a un terzo d’Italia d’esser rappresentato in questa assemblea e la maggior parte delle Società della Lombardia, della Liguria, della Toscana, dell’Emilia, della Romagna e della Sardegna non sarebbero al grado di nominar delegati, essendo state sciolte con una ordinanza ministeriale del 23 agosto p.p.» (“L’Unità Italiana”, 27 ottobre 1862).
Però, nonostante questo colpo di maglio che si abbatté sulle Società operaie, l’anno 1862 non segnò affatto un arresto nel procedere dell’organizzazione. La statistica delle Società di mutuo soccorso eseguita in quell’anno ci informa che nel corso del 1862 erano sorte 93 nuove Società (14 in Piemonte, 19 in Lombardia, 5 in Liguria, 10 in Emilia, 17 in Toscana, 10 nelle Marche, 4 in Umbria, 1 in Abruzzo, 4 in Puglia, 2 a Napoli, 4 in Sicilia), cosicché al 31 dicembre ne erano state censite 445, di cui circa 400 raccoglievano solo lavoratori manuali (artigiani, operai, contadini), nelle altre vi erano anche impiegati, commessi, ecc.
Le cifre riportate dalla statistica rappresentano solo un indice parziale di un movimento assai più esteso: la statistica comprendeva solo quelle Società che avevano dato notizia di sé al compilatore, e molte, poiché non godevano di alcun riconoscimento da parte delle autorità, essendo anzi appena tollerate o perseguitate, evitavano di fornire notizie sulla propria attività. Specialmente interessate a non farsi conoscere erano sia quelle che aderivano al partito d’azione, considerate alla stregua di associazioni sovversive, sia quelle che promuovevano scioperi e fondavano casse di resistenza. Il compilatore della Statistica lamentava il fatto che, ad esempio, alcune Società genovesi si fossero rifiutate di fornire dati sulla propria attività: «Le risposte che la maggior parte di tali Società ha date alla Prefettura mostrano pur troppo quale sia il loro stato di ignoranza e di anarchia» (citato da: Nello Rosselli, “Mazzini e Bakunin”). Non si trattava di ignoranza, ma semplicemente di forme di precauzione dal momento che erano tutte Società che avevano subito le recenti persecuzioni poliziesche della estate 1862. Anche otto Società napoletane si erano rifiutate di mandare informazioni al ministero.
Sempre secondo la suddetta statistica vi erano 121 Società che raggruppavano gli operai in base alla loro professione (così suddivise: 16 in Piemonte, 31 in Lombardia, 10 in Liguria, 30 in Emilia, 12 in Toscana, 5 nelle Marche, 4 in Umbria, 1 in Puglia, 8 a Napoli, 3 in Sicilia, 1 in Sardegna). Evidentemente anche queste, nella realtà, erano molto più numerose, poiché considerate veri e propri covi di criminali avevano tutto l’interesse a che il governo non venisse a conoscenza del loro esistere.
Questo tipo di Società era tenuto dal potere sotto stretta sorveglianza; in un rapporto del 1863 la Commissione superiore di vigilanza sulle Società di mutuo soccorso diceva: «L’unione degli artigiani della medesima professione, mentre agevola l’attuazione e l’ordinamento di una Società di reciproco soccorso, ne prepara pure l’alterazione e gli abusi. Poiché l’intimità induce la tentazione di occuparsi di interessi d’altra natura e d’altra importanza, oltre di quelli concernenti il soccorso ai malati e agli infermi». Quali fossero gli interessi “d’altra natura” che preoccupavano i funzionari dello Stato è facile dirlo, erano tutte quelle forme che anticipavano la nascita di veri organismi di classe; ad esempio le casse di resistenza, l’adozione di forme di lotta che si mostravano adeguate al raggiungimento di miglioramenti economici, come scioperi, sussidi ai soci scioperanti, tentativi di darsi una organizzazione autonoma libera dal controllo di elementi borghesi, discussioni e prese di posizione sui comuni interessi di tutta la classe, solidarietà proletaria, ecc. Ad esempio, la Camera di Unione degli Onesti Giovani Panettieri di Catania, per evitare la disoccupazione, sottoponeva tutti i panettieri a un rigoroso turno di lavoro.
Con il 1863 si ebbe una ripresa delle agitazioni operaie, tra queste degne di particolare rilievo furono gli scioperi con la quasi totale partecipazione dei tipografi milanesi, dei muratori e falegnami di Torino ed il tragico sciopero dei metallurgici di Pietrarsa (nei pressi di Napoli). È pure significativo che da quell’anno la stampa democratica sempre più diffusamente cominciò a porsi il problema del rapporto tra capitale e lavoro e, a parte le soluzioni proposte, che naturalmente avevano tutte carattere spiccatamente conciliativo piccolo-borghese, ciò dimostrava che il problema del conflitto di classe non poteva più non essere preso in considerazione, anche se lo Stato continuava ad ignorarlo.
Una prova dell’atteggiamento del Parlamento italiano di fronte alle
questioni del lavoro si ebbe nel 1863, quando il deputato garibaldino
Siccoli
interpellò il ministero sulle misure di polizia prese contro alcuni
operai
falegnami di Torino, che si erano macchiati del delitto di sciopero. Il
Siccoli, commentando il fatto, e scatenando un vero e proprio tumulto
fra
gli onorevoli colleghi, affermò che la questione grave dell’epoca non
era né quella della monarchia né quella della repubblica, ma la
questione
sociale e presentò un ordine del giorno con il quale invitava il
ministero
a presentare un progetto di legge riguardante la formazione di collegi
arbitrali per risolvere le controversie tra operai e datori di lavoro:
l’ordine del giorno, respinto dal ministro Peruzzi, non raccolse
nemmeno
un voto favorevole! (Seduta dell’11 giugno 1863).
L’eccidio di Pietrarsa
Una prova dell’atteggiamento dello Stato nei confronti delle rivendicazioni operaie si può desumere invece da quanto accadde a Pietrarsa il 6 agosto 1863. Ecco la cronaca dell’avvenimento così come riportato da un giornale dell’epoca: «Il fatto dolorosissimo avvenuto all’opificio di Pietrarsa, nelle vicinanze di Portici, ha prodotto su tutti indistintamente la più funesta e penosa impressione. Coll’animo affranto e commossi profondamente ne diamo qui appresso i particolari, che possiamo ritenere esatti.
«Un tal Jacopo Bozza, uomo di dubbia fama, ex impiegato del Borbone, già proprietario e direttore del giornale La Patria, vendutosi anima e corpo all’attuale governo, aveva avuto in compenso da questo governo moralizzatore la concessione di Pietrarsa. Costui, divenuto direttore di questo ricco opificio, che è il più bello e il più grande d’Italia, avea per lurido spirito d’avarizia accresciuto agli operai un’ora di lavoro al giorno, cioè undici ore da dieci ch’eran prima – ad altri licenziamento, comunque nel contratto d’appalto v’era obbligo di dover conservare tutti. In queste modifiche il Bozza ha avuto a compagno e collaboratore un tal Pinto, un altro ex impiegato in disponibilità, che ci teneva a lavorare presso di lui. Gli operai così detti battimazza, che avevan prima trentacinque grana di paga al giorno erano stati ridotti a trenta grana; e questi, dopo aver invano reclamato su tale torto, ieri annunziarono al Bozza ch’essi erano decisi piuttosto ad andar via anziché tollerare la ingiustizia, però domandarongli il certificato del ben servito. Pare che il Bozza non solo abbia negato loro il certificato, ma abbia risposto con un certo ordine del giorno ingiurioso a’ poveri operai. Allora ci fu che uno di questi suonò una campana dell’opificio, verso le 3 p. m., ed a tale segnale tutti gli operai, in numero di seicento e più, lasciarono al lavorare ammutinandosi, e raccoltisi insieme, gridarono: abbasso Bozza ed altre simili parole di sdegno.
«Il Bozza impaurito a tale scoppio, si diè alla fuga, fuggendo precipitosamente, cadde tre volte di seguito per terra; indi si recò personalmente [...] a chiamare i bersaglieri ch’erano di guarnigione in Portici, perché accorressero a ristabilire l’ordine a Pietrarsa, non sappiamo in che modo narrando l’avvenimento al comandante. E così accorse un maggiore con una compagnia di bersaglieri. Nel frattempo un capitano piemontese, addetto a dirigere i lavori dell’opificio, uomo onesto ed amato dagli operai, mantenne questi in quiete, aspettando che arrivasse qualche autorità di Pubblica Sicurezza o la Guardia Nazionale per esporre le loro ragioni. Ma ecco che invece giunsero i bersaglieri colle baionette in canna: gli operai stessi ch’erano tutti inermi, aprirono il cancello, ed i soldati con impeto inqualificabile si slanciarono su di essi sparando i fucili e tirando colpi di baionette alla cieca – trattandoli da briganti e non da cittadini italiani, qual’erano quegl’infelici! Il capitano che dirigeva i lavori, e del quale abbiamo accennato più sopra, si fece innanzi con kipì in mano, e gridando a nome del Re fece cessar l’ira della soldatesca.
«Tralasciamo i commenti su quest’orribile fatto. Fu una scena di
sangue, che amareggerà l’anima d’ogni italiano, farà meravigliare
gli stranieri e gioire i nemici interni. Cinque operai rimasero morti
sul
terreno, per quanto si asserisce: altri che gettaronsi a mare, cercando
di salvarsi a nuoto, ebbero delle fucilate nell’acqua, e due restarono
cadaveri. I feriti sono in tutto circa venti: sette feriti gravemente
furono
trasportati all’Ospedale de’ Pellegrini, altri andarono nelle proprie
case» (Il Popolo d’Italia, 7 agosto 1863).
Torna il movimento per le 8 ore
La riduzione dell’orario era da molti anni l’obiettivo principale dei lavoratori, l’unico veramente in grado di farli lottare uniti. Fin dagli anni Trenta e Quaranta le associazioni dei riformatori avevano fatto pressioni perché fossero approvate leggi per la giornata lavorativa di dieci ore prima, poi di otto; ma anche nei casi in cui queste leggi venivano approvate rimanevano poi lettera morta, o quasi. Anche nelle industrie nelle quali, grazie a scioperi e trattative, si era iniziato a ridurre l’orario, i padroni si erano rimangiate le concessioni alla prima occasione; d’altronde, se il sistema delle otto ore non fosse stato adottato dappertutto, le aziende che l’avessero accettato si sarebbero trovate in una posizione di svantaggio rispetto alle altre.
Nel 1884 la Federation of Organized Trades and Labor Unions, che sarebbe in seguito divenuta la American Federation of Labor, adottò una risoluzione che affermava: «Dal primo maggio 1886 l’orario di otto ore dovrà essere la giornata legale di lavoro». Altra risoluzione approvata dalla stessa Federazione nel dicembre del 1885 aggiungeva che la necessità dello sciopero generale per le otto ore si imponeva per il fallimento di altri metodi e vi si ricordava che sarebbe stato inutile aspettarsi l’introduzione delle otto ore per via legislativa, e che la richiesta unitaria di ridurre le ore di lavoro, sostenuta da un’organizzazione solida e decisa, avrebbe avuto maggiore efficacia di qualsiasi legge. L’appello per lo sciopero generale si basava sul concetto che «nel loro tentativo di riformare la situazione economica dominante i lavoratori debbono contare soltanto su se stessi e sul loro potere».
Scarso fu l’appoggio delle organizzazioni esistenti al movimento per lo sciopero del primo maggio. La federazione che aveva proposto tale scadenza era talmente debole che quando si trattò di avere un responso dagli iscritti i votanti furono solo circa 2.500. Powderly, capo dei Cavalieri del Lavoro, vi si oppose fin dall’inizio: in una circolare segreta del 15 dicembre 1884 aveva proposto che, invece di scioperare, in tutte le riunioni dei Cavalieri gli iscritti fossero invitati a scrivere una breve composizione sul problema delle otto ore, da spedirsi ai giornali in occasione del compleanno di Washington, il 22 febbraio 1885!
Gli anarchici nei primi tempi sostenevano che l’agitazione per le otto ore rappresentava un compromesso con il sistema dei salari. Il loro giornale, l’Alarm, dichiarò: «Si tratta di una battaglia perduta (...) anche se fossero accettate le otto ore i salariati non ne ricaverebbero alcun vantaggio». Alla fine però gli anarchici, soprattutto a Chicago, capirono che dovevano restare con i lavoratori in lotta, e diedero al movimento un contributo fondamentale.
L’idea dello sciopero generale per le otto ore aveva però colpito l’immaginazione e risvegliato le speranza di centinaia di migliaia di lavoratori e, malgrado l’opposizione dei dirigenti nazionali, l’agitazione si diffuse da un luogo all’altro in tutto il Paese. Organizzatori locali dei Cavalieri del Lavoro, malgrado le proteste del centro, costituirono nuove sezioni locali prendendo spunto dalla questione delle otto ore; come abbiamo visto, dato lo scarso collegamento tra centro e base, l’atteggiamento negativo della dirigenza non era sentito alla base, e l’agitazione per le otto ore fu una delle componenti del fulminante successo dei Cavalieri tra la fine del 1885 e la prima metà del 1886.
Lo stesso Powderly se ne lamenterà anche in seguito: «Nella prima metà del 1886 molte delle nuove sezioni cominciarono ad approvare mozioni in cui si invitava l’assemblea centrale a fissare al primo maggio 1886 la data dello sciopero per le otto ore, poi le mandavano al Gran Maestro Lavoratore dell’Ordine. Questo si rese conto subito del grave pericolo che rappresentava per l’organizzazione l’ignoranza dei nuovi iscritti raccolti così in fretta nelle nuove sezioni. Costoro erano stati indotti da asserzioni infondate a iscriversi; e molti organizzatori contribuivano ad alimentare le illusioni allo scopo di ricavarne “grandi vantaggi”».
A questo punto Powderly tentò senz’altro di sabotare il movimento. In una circolare segreta alle sezioni locali diceva: «La direzione dell’Ordine non ha mai fissato il primo maggio come data di uno sciopero, e non lo farà mai. Il primo maggio nessuna sezione dei Cavalieri del Lavoro deve scioperare per le otto ore credendo di obbedire agli ordini della direzione, poiché un ordine del genere non è stato mai, e non sarà mai, dato».
Tutta l’agitazione rappresentava un genere di conflitto di classe che Powderly aborriva. Ma l’ostilità dei capi, se non riuscì a fermare lo sciopero né a impedire l’ampia partecipazione ad esso delle sezioni locali dell’Ordine, fu di gravissimo danno all’unità e all’efficacia del movimento.
L’attività di preparazione dello sciopero diventò massiccia in marzo e raggiunse la sua punta massima in aprile. Vi fu un numero considerevole di scioperi per le otto ore in anticipo sulla data fissata, la richiesta delle otto ore venne inserita anche nelle lotte che avevano altri obiettivi e si ebbero imponenti manifestazioni in tutto il Paese. Il movimento aveva i suoi punti di forza nelle maggiori città industriali, a Chicago, New York, Cincinnati, Baltimora e Milwaukee; in misura minore a Boston, Pittsburgh, St. Louis e Washington.
Già prima della fine di aprile quasi un quarto di milione di lavoratori era coinvolto nel movimento; circa trentamila avevano ormai ottenuto la giornata di otto ore o almeno una riduzione di orario. Almeno 6.000 erano già in sciopero nell’ultima settimana di aprile, e nello stesso mese si stimava che non meno di centomila fossero pronti a ricorrere allo sciopero per imporre le loro richieste.
Tuttavia il movimento si dimostrò in effetti più ampio del previsto. Entro la seconda settimana di maggio la partecipazione era arrivata a 350.000 lavoratori, 190.000 dei quali direttamente con lo sciopero. 80.000 scioperavano a Chicago, 45.000 a New York, 32.000 a Cincinnati, 9.000 a Baltimora, 7.000 a Milwaukee, 4.700 a Boston, 4.250 a Pittsburgh, 3.000 a Detroit, 2.000 a St. Louis, 1.500 a Washington, e 13.000 in altre città.
A Milwaukee, molto in anticipo sul primo maggio, aveva avuto inizio una vastissima agitazione operaia. Nel febbraio le assemblee locali dei Cavalieri, contro la volontà della direzione dell’Ordine, vi avevano organizzato la Lega per le Otto Ore, cui aderirono il mese seguente i sindacati del posto. La pressione fu rafforzata da un raduno di massa di tremila lavoratori. All’avvicinarsi del primo maggio le lotte si estesero a tutte le categorie industriali. L’agitazione portò ad un’opera di propaganda davanti a tutti gli opifici, e presto nelle strade della città si era raccolta una folla pacifica. Il governatore, allarmato, inviò tre compagnie della milizia, che furono ovviamente accolte a sassate. Il giorno dopo, il 3 maggio, la truppa affrontò la folla e, dopo un avvertimento che nessuno sentì, fu ordinato il fuoco in seguito ad esplicito ordine del governatore. La folla si disperse lasciando sul terreno sei morti. Fu la fine del movimento per le otto ore a Milwaukee, e gli operai tornarono al lavoro alle condizioni di prima.
Ma non in tutte le città il risultato fu così tragico, nonostante il livore dei padroni. In genere l’agitazione fu un successo: a New York, Baltimora, Pittsburgh, Grand Rapids, St. Louis, Washington, ecc. gli scioperi ebbero una amplissima partecipazione, anche se spesso gli operai coglievano l’occasione per inserire nelle richieste anche aumenti di salario.
A Troy, nello Stato di New York, furono 5.000 gli scioperanti per le otto ore, fra i quali 2.000 operai delle fabbriche di stufe e tutti gli edili. 300 manovali delle ferrovie di origine italiana scioperarono per l’aumento del salario, e, «smesso di lavorare, legarono fazzoletti rossi ai picconi e alle pale e marciarono tutti uniti lungo la ferrovia verso il posto dove si trovava a lavorare un’altra squadra, che convinsero a unirsi agli scioperanti». In molte altre città invece il movimento per le otto ore non riuscì a espandersi, come a Boston.
È stato calcolato che quasi 200.000 lavoratori riuscirono a ottenere la giornata di 8 ore senza riduzione di salario; ma anche gli altri ottennero una riduzione di orario consistente.
Anche se in molti casi negli anni seguenti i padroni scatenarono offensive per recuperare quanto allora concesso, lo sciopero generale del 1° maggio 1886 rappresenta un punto di svolta per il movimento operaio americano, soprattutto per la coscienza acquisita in quella occasione della forza che la classe unita può esprimere e esercitare; ne nacque una spinta mai vista prima all’affiliazione alle organizzazioni sindacali. Quelle lotte, anche a causa dei fatti di Haymarket, che andiamo a descrivere, restano un punto di riferimento storico per l’intera classe operaia mondiale, un ammonimento su quanto la borghesia può essere spietata quando è spaventata dalla forza espressa dalla classe unita in lotta.
Il movimento del 1° maggio 1886 produsse un’eco straordinaria in
tutto il mondo ed in pochi anni il primo maggio divenne un giorno di
festa
operaia internazionale.
La risposta borghese: i fatti di Haymarket
Il cuore del movimento era Chicago. I Cavalieri del Lavoro della città, i sindacalisti e gli anarchici, abbandonata la primitiva ostilità, appoggiavano tutti l’Associazione per le Otto Ore che conduceva le agitazioni per lo sciopero. Per tutto il mese di aprile vi fu una serie di grandi manifestazioni. Tutti erano certi che, con la combattività dimostrata dai lavoratori e l’eccellente organizzazione, il movimento avrebbe ottenuto il successo.
Ma anche dalla parte opposta erano preparati. Già più d’un anno prima i giornali avevano dato notizia che gli uomini d’affari della città avevano costituito dei gruppi paramilitari armando alcuni loro dipendenti, e che la Guardia Nazionale era stata ampliata: «In una sola delle grandi aziende c’è un’organizzazione di 150 giovani, armati di fucili Remington a retrocarica, i quali svolgono regolari esercitazioni (...) E non si tratta certo di un caso isolato».
Alla vigilia dello sciopero una corrispondenza da Chicago del Times riferiva: «Nelle ultime quarantotto ore vari membri del Commercial Club hanno versato quasi duemila dollari allo scopo di dotare il Primo reggimento della Guardia Nazionale dell’Illinois di una mitragliatrice; l’idea era stata proposta martedì sera durante le esercitazioni e l’ispezione al reggimento e fu immediatamente adottata quando venne messo in rilievo che in caso di rivolta un’arma del genere sarebbe stata preziosa nelle mani dei soldati».
Entro il primo maggio a Chicago il movimento era riuscito a ottenere grosse concessioni: mille lavoratori birrai avevano ridotte le loro ore da sedici a dieci, e altrettanto i fornai, che prima lavoravano da quattordici a diciotto ore, avevano ottenuta la giornata di dieci ore. Una buona parte degli operai dei mobilifici ottenne le otto ore con un aumento del venticinque per cento nella retribuzione oraria; 1.600 tessili addetti al taglio delle stoffe si conquistarono una paga per dieci ore lavorandone otto. Una riduzione di orario era stata imposta anche in alcune ditte produttrici di scarpe, scatolame, tabacco e salumi, ma molti di più erano i lavoratori che si preparavano a una lotta molto aspra: fra di loro 4.000 muratori e manovali, 1.500 operai delle fornaci di laterizi, 1.200 metalmeccanici, i lavoratori dei macelli, i carpentieri, i bottai, i lavoratori del legno per edilizia, dei calzaturifici, i tappezzieri e i modellatori di stampi.
Finalmente il primo maggio entrarono in sciopero 30.000 lavoratori, e forse il doppio di questo numero partecipò o assistette alle manifestazioni. Circa 10.000 boemi, polacchi e tedeschi, impiegati nelle segherie e nei depositi di legname, sfilarono per le vie della città con la banda e le bandiere in testa. Forse a causa del numero di dimostranti non vi furono violenti scontri con la polizia.
Entro il 3 di maggio si erano uniti allo sciopero gruppi sempre più numerosi di lavoratori. Un corrispondente del John Swinton’s Paper esultava: «È il vero boom delle otto ore e stiamo ottenendo una vittoria dopo l’altra. Oggi si sono arrese tutte le fabbriche di carne in scatola della Union Stock Yards (...) Gli operai sono pazzi di gioia per questa grande vittoria».
Quel giorno operai della McCormick, ormai senza lavoro già da tre mesi e disperati, tenevano un’assemblea di massa davanti alla fabbrica. August Spies stava arringando la folla sul movimento per le otto ore quando suonò la sirena della fabbrica e, terminata la giornata di lavoro, ne uscirono i crumiri. Scoppiò subito una mischia con pugni, bastoni, lancio di pietre e mattoni. Fu sparato qualche colpo. Poi arrivò la polizia, e, aprendo il fuoco sulla folla, ammazzò in pochi minuti quattro operai e ancor più ne ferì.
In un’atmosfera accesa il giorno successivo, il 4 maggio, vi furono vari scontri fra dimostranti e polizia. Gli anarchici invitarono i lavoratori ad armarsi, con un infiammato volantino intitolato “Vendetta!”. Quella sera erano in programma molte riunioni di massa, fra cui un raduno alla Haymarket Square per protestare contro la violenza della polizia.
Al raduno di Haymarket del 4 maggio erano presenti soltanto in 1.200 circa, in atteggiamento pacifico e che non davano segno di aver seguito l’invito bellicoso degli anarchici. Cominciò a piovere e restarono solo in 300. L’ultimo oratore stava finendo il suo discorso quando con stupore di tutti uno squadrone di 180 poliziotti entrò nella piazza e venne ordinato alla folla di disperdersi. Mentre gli oratori scendevano dal palco, d’improvviso venne scagliata una bomba che esplose in mezzo ai poliziotti uccidendone uno e ferendone quasi venti, cinque dei quali morirono poco dopo. La polizia serrò nuovamente le file e aprì il fuoco sulla folla, uccidendo diversi astanti, non si sa quanti con esattezza, e ferendone almeno 200.
Fu fomentata l’isteria popolare. Eccitata dalla stampa la piccola borghesia attribuì tutta la colpa agli agitatori operai, agli anarchici, ai socialisti. Il New York Times scrisse: «Dai tempi della guerra di ribellione [la Guerra Civile] nessun turbamento della pace ha mai mosso a questo punto i sentimenti e l’opinione pubblica quanto l’assassinio dei poliziotti perpetrato dagli anarchici a Chicago martedì sera. Usiamo la parola assassinio con la perfetta consapevolezza del suo significato. È sciocco definire “tumulto” questo atto di criminalità: tutto sta a dimostrare che si tratta di un assassinio calcolato, progettato deliberatamente ed eseguito a sangue freddo».
L’ondata di rabbia e di paura provocata dai fatti di Haymarket venne utilizzata contro il movimento operaio in generale. Grazie all’opinione pubblica, sempre ingenua e credulona, i nemici del movimento operaio ebbero mano libera nella repressione di quella che fino a quel momento era stata un’offensiva vincente, sebbene non violenta se non in senso difensivo. Il sindaco di Chicago Harrison emanò un proclama in cui dichiarava che, poiché gli assembramenti, i cortei e altre cose del genere erano “pericolosi” nelle condizioni del momento, egli aveva ordinato alla polizia di sciogliere ogni riunione o raduno. La polizia stese le sue reti e nel giro di due giorni fece irruzione in non meno di cinquanta pretesi ritrovi di radicali ed arrestò quanti erano anche vagamente sospettati di affiliazione a gruppi radicali.
La maggior parte degli arresti era avvenuta senza mandato e per qualche tempo non vennero neppure presentate accuse specifiche contro gli accusati. Anni dopo il capo della polizia ammise che la polizia aveva fatto ricorso a tutto l’armamentario più tradizionale per perseguitare rappresentanti del movimento operaio: invenzione di società segrete, confessioni estorte con il terzo grado e torture, falsi ritrovamenti di pistole, dinamite, baionette, bombe varie, ecc.
Dalle centinaia di lavoratori arrestati ne furono scelti otto da processare, non per la professione politica (erano tutti anarchici), ma per il loro ruolo nel successo dello sciopero: otto dirigenti operai che vennero processati e condannati a morte; quattro furono in seguito impiccati (un quinto morì in carcere, ufficialmente per suicidio), anche se non c’era alcuna prova che avessero a che fare con l’incidente. Sorge rammenta così il loro supplizio: «Morirono da uomini l’11 novembre del 1887». Nessuno di loro, eccetto uno che stava parlando dal palco, era presente nella piazza quando fu tirata la bomba. La cronaca del processo è quella di una vergognosa farsa, in cui giudice e giuria non fecero che soddisfare le richieste della borghesia cittadina che chiedeva una sanguinosa vendetta sui protagonisti delle lotte per le 8 ore. Nel 1893, i rimanenti prigionieri furono graziati dal governatore John Peter Altgeld. Nelle motivazioni della grazia si riconosceva che: «la documentazione di questo caso mostra che il giudice condusse il processo con malevola ferocia (...) Pagina dopo pagina insinuanti annotazioni del giudice erano fatte con l’intenzione di portare la giuria verso il proprio pregiudizio (...) Non c’è episodio simile in tutta la storia».
Le stesse organizzazioni del movimento operaio – privo della sua
direzione
politica – non seppero come comportarsi e prevalsero gli atteggiamenti
più reazionari: i Cavalieri del Lavoro arrivarono ad attaccare
pubblicamente
gli imputati, la AFL chiese clemenza solo per avversione alla pena
capitale,
e per non fare degli anarchici dei martiri.
Ritirata operaia
Il movimento si trovò di fronte a una reazione durissima, che, approfittando dei fatti di Haymarket, utilizzava le tecniche già messe alla prova contro gli scioperi nel Southwest System. Gli operai, privi di direzione rivoluzionaria, entro una settimana cessarono le agitazioni e tornarono al lavoro.
In settembre uno dei più validi giornalisti nel campo delle lotte operaie scriveva: «Dallo scorso maggio molte grosse società e associazioni padronali hanno fatto ricorso a ogni genere di espedienti eccezionali per spezzare le organizzazioni operaie, che tanta forza avevano acquisito negli ultimi due o tre anni». La borghesia infatti dispiegava tutte le sue forze di polizia e milizia e divenne generale la formazione di associazioni padronali tese a tener sotto controllo, anzi a far scomparire la pratica sindacale. Thomas Scott, presidente della Pennsylvania Railroad, disse: «Date per qualche giorno agli operai e agli scioperanti una dieta a base di proiettili e poi vedrete come accoglieranno questo pane».
Per prendere solo due casi fra i moltissimi, l’associazione dei fabbricanti di camicie di Jamesburg, nel New Jersey, sospese duemila dipendenti che aveva scoperti iscritti ai Cavalieri del Lavoro, e per lo stesso motivo i fabbricanti di oggetti d’argento di New York, Brooklyn e Providence formarono un’associazione e sospesero duemila operai. In migliaia furono non solo licenziati ma anche messi nelle liste nere, in modo da impedir loro di trovare impiego altrove. L’Iron-Clad Contract (più tardi noto come Yellow-Dog Contract), che costringeva gli operai a giurare che non si sarebbero mai iscritti a una organizzazione operaia o sindacale, diventò un requisito ampiamente richiesto per ottenere l’impiego.
Le serrate divennero pratica frequente. Gli imprenditori che nel 1885 e nei primi mesi del 1886 avevano ceduto alla rivendicazione delle 8 ore si affrettarono a ristabilire le giornate lavorative di 10-12 ore. Chi protestava era bollato come anarchico, e quindi “assassino”, alla luce della propaganda finanziata sui giornali dai padroni. I più colpiti erano gli attivisti sindacali, che finivano invariabilmente sulle liste nere.
Naturalmente gli effetti più devastanti si ebbero sui Cavalieri del Lavoro, che pure agli inizi del 1886 contavano oltre un milione di iscritti: un quinto di questi si dissolse in pochi mesi, iniziando un declino che si sarebbe presto compiuto, come abbiamo visto. Un declino dovuto agli attacchi padronali, in parte, ma soprattutto alle contraddizioni interne all’Ordine, che si era dimostrato inadatto a guidare grandi lotte operaie. Tutti gli scioperi condotti dai Cavalieri dopo i fatti di Haymarket si risolsero in fallimenti.
Certo il movimento per la solidarietà e il potere dei lavoratori
ricevette
un duro colpo, ma entro meno di un decennio sarebbe risorto di nuovo.
Già
da anni si stava sviluppando una nuova organizzazione che, fatto tesoro
delle lezioni dei fallimenti dei Cavalieri del Lavoro, ne che ne
avrebbe
preso il posto, non come fenomeno dalla breve vita, come era accaduto
alle
federazioni sindacali nazionali precedenti, ma come una organizzazione
destinata a restare, nel bene e nel male, nella storia del movimento
operaio
americano sino ai nostri giorni, la American Federation of Labor.
Capitoli esposti alle riunioni di Firenze e Genova nel gennaio e nel giugno 2009
Parte terza - Il capitalismo
C - L’esercito di Francia sotto Napoleone
1. La riorganizzazione dell’esercito:
i reggimenti di fanteria
Dopo gli incredibili sforzi organizzativi del generale Dumouriez, dalla Rivoluzione all’Impero i reggimenti di linea della fanteria francese subirono diverse riorganizzazioni sostanzialmente per rispondere ad esigenze tattiche e alla necessità di integrare un numero crescente di uomini, che dovevano essere nutriti, equipaggiati ed addestrati, il che era possibile solo con un adeguato sviluppo produttivo.
La Francia del XVIII secolo era un paese principalmente agricolo vincolata agli antichi e statici rapporti feudali. Uno studio del commercio nel 1789 riassumeva in queste cifre l’apporto al reddito nazionale annuo: agricoltura 1.826 milioni di franchi, industria di trasformazione 595, all’incirca tre ad uno. Un’agricoltura relativamente poco sviluppata, priva di mezzi e cognizioni moderne per introdurre colture industriali e rapporti di lavoro salariati, come già avvenuto in Inghilterra, in piena rivoluzione industriale.
L’industria però occupava un posto importante nell’economia del paese, come documentano le migliaia di dettagliate tavole illustrate dei 28 volumi della “Enciclopedia delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri” curata da Diderot e D’Alembert, a ragione definita un “capolavoro pratico”. Ci informano in dettaglio sui metodi di produzione e sulla divisione del lavoro, in particolare, nell’esteso campo della produzione tessile, nel settore minerario, della fusione dei metalli e relative trasformazioni metallurgiche. Questa ultima arte, ad esempio, fu in grado, nel momento del grande sforzo militare del 1793, di produrre, solo a Parigi, fino a 700 fucili al giorno compreso il munizionamento e le uniformi. Ovviamente questo fu possibile con decreti straordinari di carattere rivoluzionario per reperire forza lavoro, materiali ed edifici per la produzione; fu d’esempio quello emesso da Saint-Just per la municipalità di Strasburgo: «10 mila soldati vanno scalzi; rendete scalzi tutti gli aristocratici di Strasburgo, e che domattina alle ore 10 diecimila paia di stivali siano recapitati al Quartier Generale».
L’esercito ereditato dalla Repubblica era composto da 79 reggimenti nazionali e 23 esteri, composti ciascuno da 2 battaglioni. Ogni battaglione era a sua volta organizzato su 5 compagnie di circa 120 uomini ciascuna: nel primo battaglione una delle compagnie era di granatieri, nel secondo di cacciatori. Il totale di ciascun reggimento era quindi di 1.200 uomini più gli ufficiali.
All’esercito regolare si era aggiunta la Guardia Nazionale ed una pittoresca pletora di unità volontarie, di “legioni”, di altre unità estemporanee, e gli uomini delle leve del 1791 (l’unica vera leva di volontari, in massima parte borghesi, che si rivelarono ottimi combattenti), del 1792 (la famosa leva della “Patrie en danger”), della leva “dei 300.000” del febbraio del 1793 e infine della “levée en masse” del 23 agosto 1793. Il proletariato, ancora poco sviluppato, non poteva fornire alla leva che una forza minima mentre la sorgente essenziale era di contadini e di sottoproletari.
Si iniziò a mettere ordine già dal gennaio 1791, innanzitutto con un tipico provvedimento “rivoluzionario” borghese: cambiando i nomi dei reggimenti, retaggio della monarchia.
Il primo vero problema era l’omogeneizzazione delle varie componenti, diverse non solo per origine, addestramento e motivazione, ma anche per le paghe che ricevevano: un fuciliere della Guardia Nazionale, ad esempio, era pagato il doppio di un militare regolare. Tra il febbraio 1793 e il gennaio 1794 maturò il provvedimento della “Amalgame”, ovvero il tenere insieme le vecchie unità rivoluzionarie con le nuove leve; questo non produsse effetti fino alla fine di quell’anno, quando le unità di origine rivoluzionaria erano scese al 10% del totale. Le nuove unità “amalgamate” erano le “demi-brigade”, che affiancavano ad un battaglione regolare due di origine rivoluzionaria, nel cosiddetto “Embrigadement”. Successive forme di “Amalgame” portavano le nuove reclute a riempire i ranghi di qualsiasi formazione ne avesse necessità, nella prospettiva finale di una completa standardizzazione dell’esercito senza più distinzioni tra i diversi reclutamenti.
La dittatura giacobina in campo politico e gli sforzi organizzativi in campo militare portarono concreti risultati: nell’autunno del 1793 fu schiacciato un complotto girondino nel meridione e la rivolta nella Vandea; contemporaneamente il nuovo esercito repubblicano passò dalla resistenza agli eserciti invasori al contrattacco respingendoli e riprendendo anche il porto di Tolone, che era stato consegnato agli inglesi dai controrivoluzionari. Nella primavera del 1794 l’esercito rivoluzionario, presa l’iniziativa e cacciati i nemici fuori dai confini, ebbe il suo momento decisivo nella furiosa battaglia di Fleurus, il 26 giugno 1794, con solo la metà scarsa dei suoi battaglioni – per l’esattezza 50 su 103 – riuniti in 17 demi-brigade (una delle quali con 2 battaglioni) e gli altri ancora divisi tra Garde Nationale, reggimenti tradizionali, unità volontarie, ecc., composte di un solo battaglione. Con questa vittoria non solo furono eliminate le minacce straniere ma aprì all’esercito francese la strada per esportare la rivoluzione antifeudale in Belgio, Olanda e Renania.
Il 12 agosto 1793 l’organico di battaglione venne fissato per legge in 8 compagnie di 67 fucilieri e 1 di 48 granatieri, per un totale complessivo con ufficiali di quartier generale, ufficiali di battaglione, sottufficiali, musicisti, ecc. di 771 uomini per battaglione e 2.421 uomini per demi-brigade di 3 battaglioni. Successive modifiche, nel 1796, portarono l’organico di compagnia a 104 fucilieri e a 20 uomini di altri ranghi per un totale sulla carta di circa 3.400 uomini tra ufficiali e fucilieri per ciascuna demi-brigade.
In due anni di “amalgame” le demi-brigade passarono da 198 a 211, per poi, nei primi tre mesi del 1796, essere ridotte a 100 e poi risalire a 110. All’inizio del 1800 l’esercito francese era costituito da 140 demi-brigade, la forza teorica totale dell’esercito francese era così calcolabile in 10.128 ufficiali di compagnia, 47.264 sottufficiali di compagnia e 330.000 uomini di truppa.
Il 24 settembre del 1803 venne reintrodotto il reggimento e la definizione di demi-brigade fu riservata ad unità estemporanee: dei 90 reggimenti 19 furono su 4 battaglioni, per un totale di 4.306 uomini a reggimento, e i rimanenti su 3, complessivamente di 3.234 uomini.
In appena una decina d’anni si triplicano gli effettivi dell’esercito, fatto reso possibile solo da un poderoso sviluppo produttivo; in questo modo la socialmente vittoriosa borghesia francese, con il sostegno di un altrettanto valoroso proletariato, si procura ed organizza lo strumento bellico necessario per le sue successive conquiste.
Engels nei sui scritti militari mostra come, con Napoleone, le tattiche militari risultano modificate, imposte dal nuovo modo di produzione capitalistico. Le battaglie campali fra i moderni Stati erano condotte sul modulo napoleonico dell’impiego massiccio di mezzi d’attacco, di uomini, di artiglierie, di equipaggiamenti e della grande mobilità di tutti questi resa possibile da mezzi di trasporto più efficienti. Questi i principi della guerra borghese.
La pesantezza degli eserciti pre-rivoluzionari era legata alla
limitata
e sparsa produzione feudale. La massa degli equipaggiamenti degli
ufficiali
impacciava ogni movimento e costringeva l’esercito allo stesso ritmo
faticoso. Per i difficili approvvigionamenti gli eserciti si
rifornivano
in un cerchio di venti miglia con le risorse della regione e, quando
esaurite,
erano costretti a spostarsi. Engels sottolinea il fatto di quanto in
realtà
le monarchie assolute fossero povere di mezzi e non in grado di far
funzionare
gli eserciti; bisognerà attendere l’epoca dello sviluppo degli Stati
moderni che accentrano e controllano enormi ricchezze perché i soldati
siano convenientemente nutriti e possano meglio servire dei mercenari
della
fine del feudalesimo.
2. Il decreto del 18 febbraio 1808
Molte furono le leggi, quasi a cadenza annuale fino a Waterloo, per riorganizzare l’esercito francese man mano che si imponevano nuovi sforzi militari, ma, soprattutto, che con l’esperienza si raffinava la macchina militare, avendo cura di salvaguardare l’esperienza, l’affiatamento e l’organizzazione acquisita da ciascun reggimento. A questo scopo, secondo il detto militare in voga “di non mettere tutte le uova in un sol cesto” molto spesso i reggimenti erano divisi per operare su teatri diversi: in questo modo era più difficile che un intero reggimento venisse spazzato via. Per uniformare e snellire ulteriormente l’esercito, con il decreto del 18 febbraio 1808 Napoleone stabilì che i reggimenti fossero formati di 4 battaglioni, più uno di deposito, come riserva, su sole 4 compagnie di fucilieri, guidato da un ufficiale anziano. Nei battaglioni di guerra venne ridotto a 4 il numero delle compagnie di fucilieri, con ogni compagnia costituita da 121 fucilieri e 19 altri ranghi, per un totale teorico reggimentale di 108 ufficiali e 3.862 uomini di truppa, considerando anche i circa 500 uomini del battaglione del deposito e riserva.
Tra le centinaia di decreti emanati da Napoleone questo fu uno dei più importanti; non solo riorganizza i battaglioni e i reggimenti di fanteria ma dimostra la volontà di Napoleone di condurre una stagione di guerre giovandosi di un nuovo e saldo legame fra strategia e tattica.
Dopo tre intensi anni di campagne, subito dopo la pace di Tilsit, siglata il 9 luglio del 1807, Napoleone era cosciente della fragilità dei risultati conseguiti né aveva gli strumenti per rafforzarli. Fortunatamente per la Francia, i suoi avversari erano ridotti in condizioni anche peggiori. La situazione francese, in particolare per quanto riguardava ufficiali e sottufficiali, era molto grave. Dal minuzioso lavoro di A. Martinien, “Tableaux par corps et batailles des Officiers blessés et tués pendant les guerres de l’empire (1805-1815)”, risulta che i 140 reggimenti della fanteria leggera e di linea avevano perso nel periodo 3.114 ufficiali, contro i 300 della cavalleria e della guardia. Si può stimare che alla fine di questo ciclo di campagne l’esercito francese si trovasse con circa il 20-25% di ufficiali in meno di quando le aveva cominciate e la situazione doveva essere analoga per i sottufficiali.
Si doveva anche migliorare l’addestramento dei fucilieri: il maresciallo Gouvion-Saint-Cyr calcolò che un quarto delle perdite della fanteria francese durante le guerre napoleoniche era costituito da soldati colpiti accidentalmente alle spalle dai compagni, da “fuoco amico”.
Napoleone risolse il costante problema della carenza di ufficiali accorpando i gradi e riducendo gli organici reggimentali, per cui ciascun reggimento fu dotato di un totale complessivo teorico di 3.970 uomini: 108 ufficiali e 3.862 sottufficiali e uomini di truppa. Dopo alcuni problemi derivati dalla ridistribuzione degli uomini si arrivò a formare i 122 reggimenti previsti dal decreto con questa composizione fissa: 1 colonnello, 1 maggiore, 4 chefs de batallion, 5 aiutanti maggiori, 1 quartiermastro-tesoriere, 1 ufficiale pagatore, 1 porta aquila, 1 chirurgo maggiore, 1 aiutante chirurgo, 1 tamburo maggiore, 1 caporale tamburo, 4 capimastri. Le compagnie erano uniformate su: 1 capitano, 1 tenente, 1 sottotenente, 1 sergente maggiore, 4 sergenti, 1 caporale furiere, 8 caporali, 121 soldati, 2 tamburini: in totale 140 uomini.
Erano dunque 488 battaglioni da guerra che avrebbero avuto bisogno di un totale di 1.464 ufficiali reggimentali e 8.784 ufficiali di compagnia. Altri 244 ufficiali reggimentali e 1.464 ufficiali di compagnia servivano per i 122 battaglioni di deposito
Limitandoci al calcolo per i 488 battaglioni da guerra possiamo valutare l’esigenza teorica per completare i ranghi di 40.992 sottufficiali nelle compagnie e 360.144 uomini. Secondo i piani di Napoleone, dunque, il suo esercito, facendo tutte le somme (compreso il reggimento ancora su 9 compagnie) doveva raggiungere la ragguardevole cifra di 10.329 ufficiali di compagnia, 48.202 sottufficiali e 422.472 uomini di truppa.
La tabella illustra le complessive variazioni di organico dei
battaglioni
prima e dopo il decreto:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A fronte di un aumento di 66 battaglioni, il 15,6% in più, e del numero degli effettivi di truppa, +32.444, corrisponde un taglio del 12,5% nei graduati: ovvero circa la metà delle perdite dovute alle guerre. Quindi a Napoleone mancavano ancora almeno un migliaio di ufficiali e cinque volte tanti sottufficiali per riuscire a completare i ranghi reggimentali, e benché la riforma in ogni compagnia avesse ridotto ancora al 3,5% il rapporto tra graduati e truppa. Questo vuoto avrebbe richiesto degli anni per essere colmato. La riforma napoleonica aveva indubbi vantaggi, rimediava almeno in parte alla carenza di quadri ma comportava una diminuzione della capacità di controllo dei reparti: ogni 100 uomini di truppa i graduati passavano da più di 17 a meno di 14, ovvero da 1 ogni 5,7 uomini ad 1 ogni 7,2.
Però altri fattori bilanciavano ampiamente questo aspetto negativo. Un primo vantaggio era già insito nella semplice standardizzazione degli organici, che metteva finalmente ordine, almeno formalmente, in un ventennio di spontaneità rivoluzionaria: reggimenti organizzati tutti sulle stesse basi costituivano un riferimento più diretto ed affidabile sia per i comandanti superiori sia per gli stessi ufficiali reggimentali. Un grande vantaggio veniva anche dall’istituzione del battaglione di deposito, che poteva fornire rimpiazzi addestrati con una certa continuità.
I generali di brigata e i comandanti di reggimento, avendo a disposizione unità più piccole ma in numero maggiore, potevano articolare sul campo di battaglia tattiche più elastiche e rapide: i battaglioni su 6 compagnie avevano una velocità di schieramento sensibilmente maggiore, fino a 3 volte nel caso di passaggio da linea a quadrato (circa 5’ contro 1’ e 30”) e 30” più veloce passando da colonna a linea (3’ contro 2’ e 30”), solo per fare due esempi, piccoli guadagni ma che in battaglia potevano fare la differenza. La riduzione nel numero dei graduati di reggimento veniva così ampiamente compensata da questo aumento della maneggevolezza dei battaglioni. Gli eserciti di tutti i tempi hanno sempre avuto il problema della velocità nel cambio di formazione, ad esempio da quella di marcia a quella di combattimento o cambi tattici nel corso dello scontro; il problema si complica con il crescere in grandezza delle formazioni impegnate; numerose storiche battaglie furono compromesse o perse per questo.
La riforma del decreto 18 febbraio 1808 raggiunse il suo scopo alla prova dei fatti: nella campagna del 1809 la Francia fu in grado di sconfiggere ancora una volta gli austriaci, nonostante il perdurare dell’impegno della guerra in Spagna.
Permaneva la norma di “non mettere tutte le uova in un unico paniere”, ovvero dividere i battaglioni su più scenari operativi per limitare la possibilità che interi reggimenti venissero spazzati via per le perdite in battaglia, rendendo impossibile reintegrarli con i rincalzi. La cosa non avverrà, invece, nella campagna di Russia quando i reggimenti vennero impiegati a pieno organico, per l’occasione portato a 5 battaglioni di guerra. Ma senza il decreto probabilmente per Napoleone sarebbe state impossibili armate delle dimensioni di quelle preparate per invadere la Russia, anche dopo tre anni di relativa pace. Tre anni che vennero impiegati per sfornare ufficiali e sottufficiali in abbondanza.
Ma senza il formidabile sviluppo delle forze produttive, che ora la borghesia al potere poteva sfruttare con le buone e con le cattive, non si sarebbe potuto sostenere un simile sforzo, per vestire, armare e istruire eserciti di queste dimensioni.
Alla fine di successivi aggiustamenti si arrivò ad una composizione normale dei corpi d’armata: 2 battaglioni per reggimento; 2 reggimenti per brigata; 2 brigate per divisione; 2 divisioni per corpo d’armata. Questa composizione media si poteva estendere a seconda delle necessità militari attingendo ad altri corpi d’armata; il massimo implemento si ebbe per la campagna di Russia dove la composizione delle sezioni vicino alla linea di fuoco fu notevolmente potenziata.
Per rendere operativo un qualsiasi piano di guerra occorre una valida catena di comando che deve essere la più corta possibile; ovviamente man mano che il corpo d’armata cresce anche la catena di comando si allunga e i problemi tecnici di comunicazione si complicano, anche per l’estendersi del territorio su cui si opera. Basti pensare che i corpi d’armata che Napoleone impiegava nelle grandi campagne si estendevano normalmente su distanze dai 45 ai 200 chilometri. All’inizio dell’aprile del 1796 l’Armata d’Italia era schierata su un fronte di 120 chilometri, a metà settembre del 1805 la Grande Armata copriva un fronte di 200 chilometri tra Strasburgo e Wùrzburg e ai primi di giugno del 1812 il mezzo milione di uomini della Grande Armata di Russia formava dietro la Vistola una linea di partenza lunga più di 400 chilometri. Poi, mentre l’azione si sviluppava, le posizioni strategiche dei vari corpi cambiavano radicalmente secondo esigenze di sicurezza, soprattutto per sconcertare e disorientare gli avversari, per riunirsi improvvisamente, usando anche marce forzate notturne, nel posto da Napoleone ritenuto più propizio per la battaglia, fondendo marcia, combattimento e inseguimento in un’azione unica.
Al comandante di corpo d’armata spettava innanzitutto il coordinamento fra le varie armi, fanteria, artiglieria e cavalleria, decidendone schieramento, modalità e tempi di impiego, e il controllo generale delle operazioni secondo il piano di battaglia generale. Un maresciallo dava comandi ad un paio di generali di divisione, e questi ad un uguale numero di generali di brigata. Questi ultimi, però, avevano ai loro ordini un numero molto meno costante di comandanti di reggimento e soprattutto di battaglione e quindi, di campagna in campagna, dovevano reinventarsi il mestiere.
La catena di comando aveva tre snodi critici: il comandante di corpo d’armata, il comandante di divisione e il comandante di brigata. Al primo spettava nel corso della battaglia il controllo complessivo delle operazioni, mentre la responsabilità maggiore di armonizzare l’elemento massa e l’elemento manovra ricadeva soprattutto sui generali di brigata, che dovevano portare a termine le missioni assegnate con le forze loro disponibili. I generali di divisione, completando la catena di comando, rappresentavano il cruciale collegamento tra le due esigenze belliche: in questo ruolo esercitavano un’influenza decisiva sul corso della battaglia, e non solo relativa alla divisione sotto il loro diretto comando.
Il flusso comunicativo che da Napoleone raggiungeva i singoli battaglioni doveva attraversare quei 3 passaggi e in ciascuno poteva giungere un intoppo, un’errata valutazione o interpretazione, per non parlare di esecuzione mancata: furono più le battaglie decise ad uno di quei nodi che non quelle vinte o perse dal fuoco dei fucili o dai piani di battaglia dello stesso Napoleone.
Ad esempio durante la battaglia di Waterloo i 32 battaglioni del I
corpo
di Reille vennero quasi completamente risucchiati nella voragine di
Hougomont
per le decisioni di Gerolamo Bonaparte, comandante della 6a divisione.
Gli ordini di Napoleone non ebbero l’opportuno controllo da parte di
Reille e furono da Gerolamo eseguiti maldestramente o addirittura
stravolti:
i comandanti di brigata e di battaglione si trovarono così impegnati
nella
gestione di un compito operativo non solo privo di un senso generale
nell’economia
della battaglia pensata da Napoleone (cosa che non spettava a loro
giudicare),
ma anche tatticamente ingestibile e non assolvibile praticamente.
3. La strategia napoleonica
In questa trattazione si è voluto descrivere il legame tra il nuovo potere politico borghese e la conseguente organizzazione militare, di cui Napoleone Bonaparte si fece grandioso tramite, piuttosto che dare una nostra lettura dell’intera opera militare del grande corso. Per cui non sono qui descritte le importanti campagne militari – contro cinque successive Coalizioni anglo-continentali ed in Italia, in Egitto, in Spagna, in Russia – espressioni già del rampante colonialismo borghese francese volto al controllo delle vie commerciali e delle materie prime. Esse sono solo portate ad esempio delle differenti strategie militari adottate.
Carl von Clausewitz, che tanto studiò le imprese napoleoniche, in Della Guerra così sintetizza il moderno concetto di strategia, «impiego del combattimento agli scopi della guerra. Essa deve dunque porre ad ogni atto bellico uno scopo immediato che possa condurre a quello finale. In altri termini, elabora il piano di guerra, collega allo scopo immediato predetto la serie delle operazioni che ad esso debbono condurre, e cioè progetta i piani delle campagne e ne coordina i singoli combattimenti».
Nei due secoli precedenti vi erano state fondamentali evoluzioni: come già riferito, nel Seicento era in auge una strategia di attrito volta a logorare le forze nemiche senza compromettere le proprie; lo scopo finale della guerra era di giungere ad una trattativa per spostare il controllo di alcune roccheforti, fortezze e porzioni di territorio a favore delle parti vincenti col minimo sforzo possibile. Nel Settecento si impone la strategia di esaurimento introdotta da Gustavo di Svezia ma perfezionata da Federico II di Prussia; gli scontri si fanno più intensi e distruttivi allo scopo di erodere la volontà e soprattutto la capacità del nemico a resistere.
Il re-soldato prussiano crede più alle battaglie che alle trattative ed è l’anello di congiunzione con Napoleone che così rafforza il concetto: «Io vedo una sola cosa: e cioè la parte più forte dell’esercito nemico. Io cerco di annientarla, pensando che le questioni meno importanti si sistemeranno da sole». Era nata la strategia di annientamento che esercitò un’influenza enorme sul modo di fare la guerra fino quasi ai giorni nostri; costi e devastazioni crebbero vertiginosamente come ugualmente crebbero le forze produttive che le potevano consentire. In questo senso svolsero un ruolo progressivo.
Napoleone, in realtà, era un istinto pratico e non teorico: non si occupò mai di elaborare un sistema, anzi fondava tutte le proprie azioni sull’imprevedibilità e l’anticonvenzionalità. Cruciale per lui, che combatté sempre contro forze superiori che spesso lo pressavano da più lati, era arrivare sul campo di battaglia con un vantaggio sugli avversari. Nonostante questo vantaggio ogni battaglia fa storia a sé e non è mai vinta in partenza. Ciò non era improvvisazione o superficialità, ogni campagna era studiata attentamente con largo anticipo con una precisione geografica, tecnica, logistica e tempistica incredibile. La scelta dei probabili campi di battaglia era basilare per la sua strategia e poneva molta attenzione all’aspetto topografico della campagna.
La strategia napoleonica è comunque riconducibile a due schemi: in
attacco operò con le manoeuvre sur les derriéres, in difesa con
la posizione centrale.
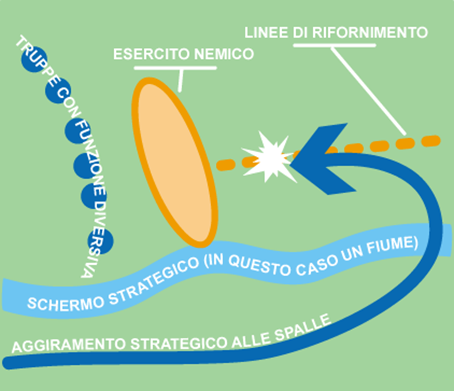 |
La maggiore velocità di spostamento e dislocamento sui teatri militari era anche possibile per un diverso sistema di rifornimento e vettovagliamento delle formazioni napoleoniche. Gli eserciti classici avanzavano in blocco concentrato con grosso seguito di carriaggi che assicurava il funzionamento di tutto il sistema d’arme; più era grande più ne rallentava l’avanzata e la manovra. In particolare il vettovagliamento era in tutto fornito da queste retrovie. Ciò derivava dal fatto che molto spesso i soldati erano stati arruolati contro la loro volontà o presi dalle galere: alla prima occasione tentavano la fuga, soprattutto se si trattava di procurarsi cibo o altro, quindi si cercava di evitare ogni occasione per allontanarli dai reparti. Le nuove formazioni francesi, che avanzavano su fronti separati e su estesi territori, invece avevano scorte su carri ridotte al minimo, ciascun soldato aveva con sé razioni sufficienti per qualche pasto e, in generale, dovevano vivere delle risorse locali. In altre parole, dell’aiuto spontaneo delle popolazioni incontrate nelle loro avanzate rivoluzionarie, o nel regolare acquisto in massa, o molto più spesso nel furto, saccheggio e quanto di meno nobile vi sia nell’avanzata di un esercito in guerra.
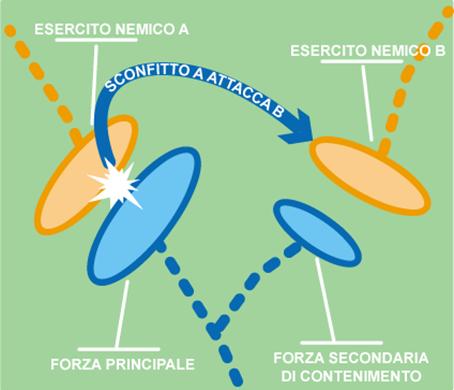 |
Con la posizione centrale (quadro 2), Napoleone inserisce la sua armata tra quelle nemiche, impedendo che si riuniscano e permettendo a lui di sconfiggerle in sequenza: mentre un contingente secondario trattiene un esercito nemico, Napoleone affronta e vince il proprio diretto avversario, quindi attacca immediatamente l’altro prima che abbia la meglio sulla sua forza di contenimento.
A Montenotte l’espediente funzionò egregiamente, a Waterloo no.
Per confondere ed ingannare i nemici e per permettere movimenti rapidi ed un efficiente foraggiamento, Napoleone disperde le sue forze su un fronte molto ampio e le riunisce solo all’ultimo momento, concentrando rapidamente una forza decisiva in un punto critico dello schieramento nemico: la cosiddetta concentrazione sul campo di battaglia (quadro 3). Questo era possibile solo mediante quel miracolo logistico che consentì all’esercito francese di coprire 800 chilometri senza cadere a pezzi, come nella parte iniziale della campagna di Austerlitz: 200.000 uomini tennero per 5 settimane un’incredibile media giornaliera di marcia tra i 20 e i 25 chilometri.
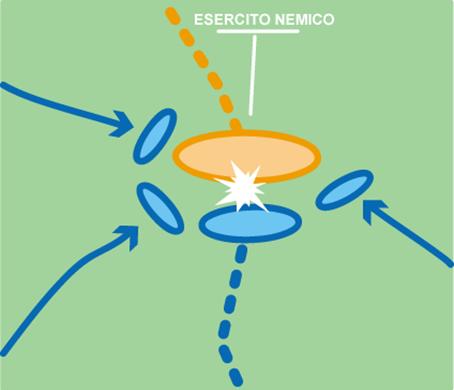 |
La rivoluzione della borghesia contro il sistema feudale aveva indubbiamente in Napoleone “trovato la sua sciabola” ed ora avanzava in tutta l’Europa continentale nella sua opera di demolizione dei rapporti sociali e di produzione feudali.
Certo, il personaggio Napoleone Bonaparte era un uomo audace al limite dell’azzardo, risoluto, capace, meticoloso e infaticabile nel lavoro, particolarmente ambizioso e munifico con i suoi migliori collaboratori: lo strumento umano di cui la Storia aveva bisogno in quel contesto.
Ma condottieri e generali niente possono senza soldati ben addestrati e equipaggiati. Il fante francese era dotato di scarpe chiodate, che duravano di più, assolutamente necessarie per le marce forzate imposte dalle tattiche napoleoniche. In battaglia indossava dei larghi pantaloni bianchi sopra i calzoni aderenti alla zuava e una giubba blu; in testa aveva lo “sciaccò”, un cappello rigido con le insegne del reparto, sulle spalle uno zaino per gli indumenti e oggetti personali al quale sovente erano appese un paio di scarpe di ricambio ed un cappotto. L’armamento prevedeva un moschetto ad avancarica, il più diffuso era il Charleville modello 1777 con un tiro utile di un centinaio di metri, e di una corta spada. Quest’ultima aveva scarsa utilità in combattimento e veniva spesso usata per usi non consentiti come spaccare la legna o reggere la pentola sul fuoco del bivacco; a chi si lamentava delle sue ridotte misure veniva risposto: ”Se la spada è corta, basta fare un passo avanti in più!”. La giberna, che conteneva le munizioni e il classico berretto floscio, era appesa alla spalla sinistra mediante una tracolla di cuoio munita di una tasca per la baionetta a calza, che cioè si infilava sulla parte esterna della canna del moschetto permettendo al soldato di caricare e sparare anche con la baionetta inastata.
Le artiglierie da campagna erano composte da cannoni montati su affusti e trainati da cavalli. I proietti di artiglieria più comuni erano le palle piene, di cui si cercava di sfruttare l’effetto rimbalzo: la palla, di circa tre chili, doveva colpire il terreno davanti al nemico e attraversarne le file uccidendo ad ogni rimbalzo. Questa tecnica richiedeva un terreno duro; a Waterloo i tiri delle batterie di Napoleone furono inefficaci a causa del terreno zuppo d’acqua per le improvvise e abbondanti piogge. Vi erano poi le granate ovvero, palle di ferro vuote riempite di polvere che quando scoppiavano si frammentavano in molte schegge mortali. Lo shrapnel, cosi chiamato dal nome del tenente Henry Shrapnel che lo inventò nel 1784, è una granata che esplode in aria spargendo le sferette della sua carica sul bersaglio. Da un punto di vista tecnico l’esercito francese non era meglio armato di quello inglese, che usava cavalli da battaglia di razze e qualità migliori.
Gli inglesi nello stesso periodo usavano il moschetto Brown Bess con caratteristiche simili allo Charleville, presto però sostituito, sempre in periodo napoleonico, dal fucile costruito dall’armaiolo londinese Baker, molto più preciso e con un tiro utile fino a 275 metri, ben più del doppio degli altri. Questo nuovo modello usava una spada-baionetta che alleggeriva il fante fuciliere, lo agevolava nei movimenti e riduceva il costo dell’armamento. Questo si rivelò di grande efficacia nel contrasto degli assalti della cavalleria francese come fu a Waterloo.
Con una macchina da guerra così organizzata gli eserciti francesi avanzano e travolgono i vecchi eserciti feudali, rafforzati dalla spinta rivoluzionaria che li aveva messi in moto. Ma lo spirito idealista di libertà, uguaglianza e fratellanza celava squisiti interessi economici ed espansionistici che sottoposero le neonate repubbliche a pesanti tributi economici e forti legami di dipendenza creando così un nuovo impero economico francese.
Ben presto le vecchie e nuove masse oppresse si accorsero che il
nuovo
mondo, il nuovo modo di produzione basato sulla forza lavoro ora libera
dai vincoli feudali, è una società ancora divisa in classi economiche
in cui alcune detengono il potere e altre no. Battuto il vecchio mondo
feudale, che velocemente stava scomparendo, si apriva il periodo di
avanzamento
e sviluppo del modo di produzione capitalista; ma anche del
proletariato,
che ora entra nella scena storica verso la sua emancipazione dalle
catene
del salariato!
4. La battaglia di Waterloo
Dal punto di vista militare Napoleone avrebbe potuto vincere la battaglia, nonostante gravi errori, incomprensioni, indecisioni commessi da lui e dal suo gruppo di comando. E per il tradimento di alcuni generali, molti dei quali durante l’esilio all’Elba erano passati al servizio dei Borboni, ma che durante i Cento Giorni furono reintegrati col perdono.
A Waterloo Napoleone disponeva dell’Armata del Nord, complessivamente di 124 mila effettivi, e di 366 cannoni. La Settima Coalizione, approntata per distruggere per sempre l’espansionismo francese di cui il Generale corso era stato il primo strumento, contava su un totale di 800 mila uomini. Però delle cinque armate avversarie erano presenti solo due, che disponevano in campo di 210 mila effettivi, mentre le restanti tre erano al di là del Reno in fase di concentramento e organizzazione per l’invasione della Francia stabilita per il 1° luglio 1815.
Venutone a conoscenza da alcuni disertori belgi e dai suoi informatori, a Napoleone non restava che una sola carta: attaccare d’anticipo con la massima audacia e determinazione prima che le forze della coalizione fossero pronte per la simultanea invasione.
La battaglia di Waterloo è l’evento principale di un insieme di quattro battaglie accorpate in due giorni e nella stessa zona: Ligny e Quatre-Bras il 16 giugno e Wavre e Waterloo il 18 giugno.
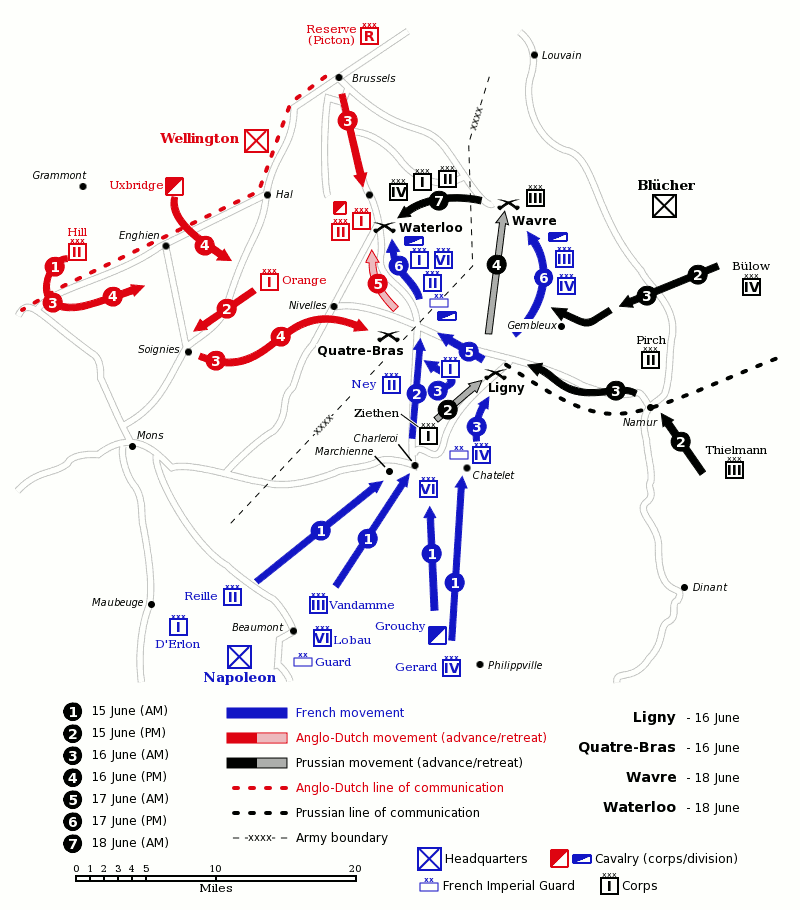
Il 14 giugno l’Armata del Nord raggiunge il confine franco belga al di là del quale erano già schierati due degli eserciti alleati. A Narmur era acquartierato quello prussiano e sassone, forte di 116 mila unità sotto il comando del feldmaresciallo Blücher, mentre a Bruxelles era stanziata una forza di 93 mila unità inglesi, olandesi e tedesche con a capo il generale britannico Wellesley, duca di Wellington. Tra queste due armate c’era sufficiente spazio per poter incuneare le forze francesi che Napoleone quindi divise in due ali d’attacco più una riserva strategica formata dalla Vecchia Guardia, i suoi fidati veterani di tutte le vittorie e considerati imbattibili.
Il 15 giugno l’ala sinistra comandata dal maresciallo Ney e quella destra dal generale Grouchy riuscirono a incunearsi tra le prime linee di Wellington e Blücher così da potersi agilmente muovere su entrambi i fronti.
Per il 16 giugno il piano di Napoleone prevedeva che l’attacco contro Blücher fosse coordinato con un’offensiva di Ney contro gli inglesi; la riserva sarebbe stata pronta a muoversi su uno o l’altro dei teatri di guerra a seconda delle circostanze. L’armata prussiana forte di 84 mila effettivi e 220 cannoni, nella marcia di avvicinamento verso Wellington si dispose lungo il fiume Ligny su un fronte lungo una decina di chilometri che incorporava diversi villaggi dove si trincerò sul versante delle colline oltre una zona acquitrinosa. Wellington conferendo la mattina con Blücher lo sconsigliò di accettare battaglia da quelle posizioni perché troppo esposte al tiro delle artiglierie e senza possibilità di contrattacco per la natura del terreno. Wellington gli promise un suo intervento di appoggio qualora le sue truppe non fossero impegnate dai francesi, come poi non avvenne perché dovettero affrontare le truppe di Ney.
Napoleone approfittò di questa pessima posizione dei prussiani, modificò i piani, riposizionò le truppe, affidò 68 mila effettivi e 210 pezzi d’artiglieria a Grouchy; la battaglia, a causa dei cambiamenti tattici, poté iniziare solo alle 14 e si protrasse fino al sopraggiungere delle tenebre. La micidiale artiglieria francese fece il vuoto nella fanteria prussiana; la battaglia fu molto cruenta con ripetuti attacchi di cavalleria e fanteria francese.
Napoleone inviò allora un messaggio a Ney perché intervenisse colpendo l’armata di Blücher alle spalle, ma questi era già impegnato contro gli inglesi a Quatre Bras. Quattro ore dopo decise quindi di far intervenire per il colpo finale la Vecchia Guardia, le truppe scelte francesi sferrarono l’attacco finale che si concluse con l’ultima decisa vittoria di Napoleone. Dopo un ultimo contrattacco guidato personalmente dal feldmaresciallo prussiano questi, vista la sfavorevole situazione e approfittando dell’oscurità, diede l’ordine della ritirata e per un puro colpo di fortuna non fu fatto prigioniero anche se ferito.
15 mila furono i caduti francesi e 16 mila prussiani più 10 mila dispersi in fuga. A Grouchy fu affidato il compito per il giorno a venire di dare il colpo finale ai prussiani, disperderli e impedire loro il congiungimento con gli inglesi. Cosa che non fece. Perse il contatto col nemico, vagò per le campagne per due giorni alla loro ricerca nonostante l’ordine di Napoleone di accorrere a Waterloo dove i suoi 30 mila soldati avrebbero potuto determinare la vittoria francese.
La battaglia di Quatre Bras fu combattuta da una parte dell’Armata dei Paesi Bassi, al comando del Duca di Wellington, il Principe d’Orange e il duca di Brunswick, per un totale di 33 mila uomini ,contro parte dell’Armée du Nord del Maresciallo Ney forte di 26 mila francesi.
Il quadrivio di Quatre Bras, un villaggio di poche case, fra la strada Charleroi-Bruxelles e quella Nivelles-Narmur, era di importanza strategica per il controllo dei movimenti e per impedire il ricongiungimento delle truppe della coalizione.
Furono inviati a Bruxelles dispacci che riferivano del movimento dell’ala destra francese di Grouchy verso Ligny e della destra di Ney verso Quatre Bras sulla strada di Narmur. Wellington li interpretò come manovre diversive e, nonostante successivi messaggi, non prese alcuna decisione per tutta la giornata; la sera partecipò tranquillamente, con la maggior parte dei suoi ufficiali, al gran ballo della Duchessa di Richmond. Gli ordini furono poi impartiti la mattina del 16 con ventiquattro ore di ritardo.
Il Generale Rebecque, capo dello staff del Principe d’Orange, che aveva deciso di disubbidire agli ordini ricevuti dal Principe e dal Duca ed aveva concentrato le sue truppe a Nivelles, vista la situazione e l’assenza di ordini dal Comando generale, si diresse prontamente verso Quatre Bras per frapporsi all’avanzata francese di Ney.
La battaglia iniziò con una forte supremazia francese che fece arretrare gli olandesi del Principe d’Orange dal quadrivio. Durante il corso delle azioni arrivarono da entrambe le parti continui rinforzi e nel primo pomeriggio giunse anche Wellington. Furono scontri concitati, gestiti nella confusione, successivi cambi tattici per i continui arrivi di nuove truppe, presa e perdita di posizioni parziali, morti per fuoco amico nella Coalizione per la somiglianza delle uniformi.
Alle ore 16 Ney ricevette l’ordine di Napoleone di attaccare in maniera vigorosa ricevendo dei rinforzi. Ma era carente di fanteria e richiese il supporto di quella di D’Erlon il quale stava marciando con Napoleone verso Ligny. D’Erlon, non sapendo se ubbidire all’imperatore o al suo diretto superiore, marciò avanti e indietro nelle campagne senza partecipare ad alcun combattimento.
Nel tardo pomeriggio nel fronte della Coalizione arrivarono i precisi fucilieri inglesi con rinforzi di cavalleria britannica. Sotto una fitta pioggia e giunta la notizia della vittoria francese a Ligny, Wellington diede l’ordine di ripiegare su Bruxelles mentre cessavano gli ultimi combattimenti. Conquistato Quatre Bras Ney subito dopo diede l’ordine alle sue avanguardie di ritirarsi su Frasnes, quattro chilometri a sud di Quatre Bras. Un mistero. Fra morti e feriti rimasero sul campo 4.300 francesi e 4.800 della Coalizione.
La battaglia si concluse con una vittoria tattica per Wellington, che era riuscito a fermare l’avanzata francese; fu però anche una sconfitta strategica per il Duca, che non era riuscito ad inviare rinforzi ai Prussiani impegnati nella contemporanea battaglia di Ligny. L’Armata dei Paesi Bassi perciò, appresa la sconfitta prussiana, fu costretta a ripiegare verso Nord alla volta di Bruxelles per ricongiungersi con l’esercito di Blücher che, per sganciarsi dall’inseguimento di Grouchy, si ritirava velocemente a Nord-Est, verso Wavre. Napoleone scelse di inseguire Wellington con il grosso delle sue truppe e due giorni dopo si incontrarono a Waterloo.
La battaglia di Wavre, combattuta contemporaneamente a quella di Waterloo, 4 chilometri distante, si concluse nel primo mattino del 19. È il seguito della precedente battaglia di Ligny quando l’esercito prussiano fu costretto a ritirarsi in maniera disordinata. Napoleone inviò Grouchy al suo inseguimento con 33 mila effettivi e 80 cannoni ma, lento ed indeciso nell’inseguimento, lasciò a Blücher il tempo per riorganizzare le truppe lasciando una retroguardia di 17 mila uomini con 48 cannoni a copertura del suo congiungimento con Wellington e con i restanti 72 mila uomini. Il maresciallo Grouchy, che aveva avuto ordini scritti e verbali da Napoleone di marciare su Wavre e attaccare i prussiani, e nonostante udisse il fragore della battaglia di Waterloo e i suoi generali gli suggerissero di accorrere sul teatro di guerra principale, mostrando di non voler disubbidire agli ordini dell’imperatore, continuò la marcia su Wavre. I prussiani si attestarono a difesa di un ponte tra Limale e Wavre e bloccarono i francesi permettendo a Blücher di congiungersi a Waterloo con gli inglesi.
Alle 17 Grouchy ricevette un messaggio da Napoleone di accorrere in suo aiuto a Waterloo ma l’ordine giunse in ritardo affinché fosse di reale aiuto: Grouchy continuò nei suoi inutili attacchi alla retroguardia prussiana che si protrassero nella mattina seguente quando i prussiani si ritirarono non potendo più difendere le posizioni. Saputo dell’esito di Waterloo anche il maresciallo francese iniziò a ritirarsi.
Wavre si concluse con un’inutile vittoria tattica francese mentre fu una grande vittoria strategica prussiana perché la loro retroguardia, nettamente inferiore numericamente, aveva bloccato 33 mila francesi che altrimenti avrebbero potuto partecipare a Waterloo e contemporaneamente permise ai 72 mila di Blücher di impegnare Napoleone sul fianco destro. Sul campo rimasero 2.500 morti da entrambi i fronti.
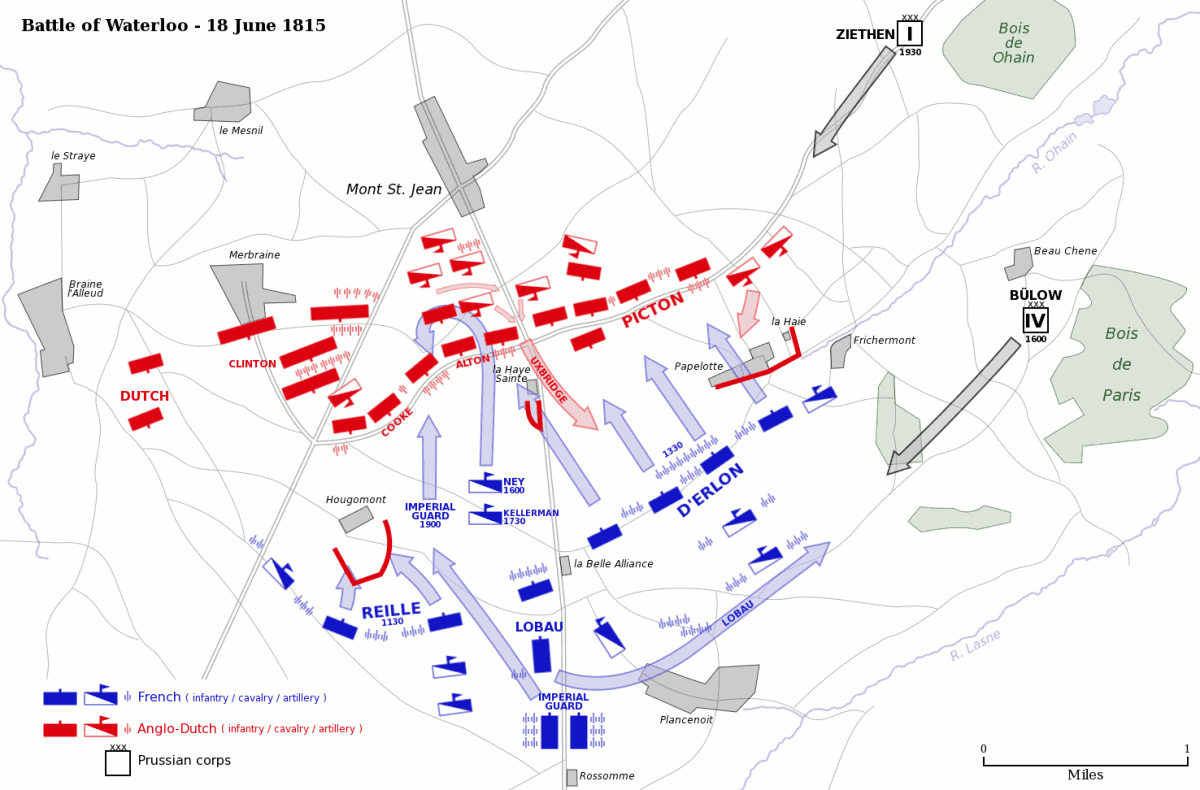
La battaglia di Waterloo si svolse il 18 giugno 1815, durò complessivamente otto ore tra 72 mila francesi e 96 mila della Coalizione. Fu una delle più cruente del XIX secolo: vi morirono oltre 48 mila soldati. A Waterloo si trovava solo il quartier generale di Wellington, il centro della battaglia si svolse in una vasta pianura sotto il Mont Saint-Jean nei pressi dell’incrocio strategico di Quatre Bras. In meno di dieci chilometri quadrati si affrontarono circa 140 mila uomini con più di 400 cannoni.
Il piano di Napoleone prevedeva un attacco di disturbo da parte del maresciallo Ney alla fattoria fortificata di Hougoumont per ingannare Wellington sulle reali intenzioni dei francesi, quindi avrebbe dovuto sfondare al centro in direzione della fattoria della Haie Sainte e di Mont Saint-Jean, e sulla destra, in direzione dell’altra fattoria di Papelotte. Poi, raggiunto da Grouchy, doveva andare avanti oltre Waterloo e la notte si sarebbe dormito a Bruxelles conquistata. Tutto questo in teoria.
L’inizio della battaglia era stato fissato alle sei, massimo le sette, ma una forte pioggia la notte aveva reso il terreno fradicio e si dovette aspettare che l’acqua drenasse e il terreno si rassodasse un po’.
Alle ore 4,10 sorge il sole; piove. Si muovono le armate prussiane a Wavre mentre Napoleone riceve informazioni che Wellington accetta battaglia e alle ore 5 invia gli ordini di battaglia per le ore 9.
Alle 6 inglesi e alleati prendono posizione sulle alture di Mont Saint-Jean su un fronte di 4.5 km sotto il diretto comando di Wellington.
Alle ore 8, dopo colazione al comando francese a Le Caillou, Napoleone ed i comandanti superiori ricevono informazioni dal fratello Gerolamo di reparti prussiani a Wavre, che non giudica importanti.
Alle 9, smette di piovere. Wellington ha ultimato la disposizione delle sue truppe mentre i francesi devono ancora completare concentramento e disposizione in campo. Si sposta l’ora dell’attacco per il terreno fangoso.
Alle 10 Napoleone ispeziona il campo di battaglia, incoraggia le truppe che lo acclamano, morale alto, sposta il punto di comando nella vicina fattoria di Rossomme, che non gli permette, al contrario che per Wellington, una completa visione di tutto il teatro di guerra; invia un messaggio a Grouchy di raggiungere Wavre, entrare in contatto coi prussiani e inseguirli; si completa lo schieramento francese.
Alle 10,30 le avanguardie dell’armata prussiana di Bülow giungono in vista del campo di battaglia e alle 11 Blücher lascia Wavre verso Mont Saint-Jean.
Napoleone terminata l’ispezione e poiché il terreno si è asciugato un po’ ordina l’inizio delle operazioni per le 11,30. Tre colpi di salve dell’artiglieria della Guardia imperiale segnano l’inizio dell’attacco diversivo contro il castello Hougoumont affidato al fratello di Napoleone, Girolamo, con il preciso ordine di attaccare, ingannare il nemico e fermarsi dopo aver occupato le vie di accesso al castello assediando di fatto la guarnigione. Invece Girolamo manda all’assalto in più riprese l’intera divisione che avanzando allo scoperto viene falciata dalla fucileria inglese. Quella che doveva essere una semplice scaramuccia diventa una battaglia importante coinvolgendo sempre più altre truppe che dovevano essere impegnate altrove. Il combattimento per Hougoumont prosegue per tutta la giornata inghiottendo forze francesi dagli altri reparti e alla fine non viene nemmeno conquistato.
Grouchy, pur vedendo il fumo alzarsi dal Mont Saint-Jean, continua la sua azione a Wavre ed invia un messaggio a Napoleone segnalando che i prussiani sono in ritirata verso est, si tratta invece di 6 mila disertori mentre il grosso dei prussiani va a ovest. Chiarito l’equivoco non invia alcun messaggio di rettifica a Napoleone.
Napoleone fissa l’attacco principale per le ore 13: parte un intenso fuoco di artiglieria francese per preparare l’attacco principale: sfondare il centro nemico movendo verso Mont Saint-Jean, conquistare le fattorie della Haie Sante e più a destra quella di Papelotte. Il generale Drouet D’Erlon ha a disposizione 20 mila uomini organizzati in quattro divisioni. Dopo mezz’ora di fuoco avanza la fanteria francese ma è seriamente ostacolata dal terreno non ancora prosciugato. L’enorme testuggine francese si trova esposta al fuoco dei fucili Baker. D’Erlon aveva disposto l’attacco per colonne per limitare le perdite ma il limitato spazio aveva provocato la concentrazione degli uomini, facile bersaglio dei fucilieri. L’avanzata viene bloccata a più riprese dalle divisioni di Picton e dalla cavalleria di Uxbridge di Lord Raglan, qui trentenne, che sarà poi il comandante del corpo inglese in Crimea.
Alle 14 Napoleone scorge dal suo osservatorio l’arrivo di truppe dalla parte di Saint Lambert; venuto a sapere che sono le avanguardie prussiane non si scompone perché suppone che dietro loro ci sia Grouchy che le insegue da due giorni. Però dietro i prussiani non c’è nessuno e Blücher stava portando la sua armata a Waterloo mentre Grouchy rimaneva a Wavre.
Si susseguono attacchi e contrattacchi per la conquista della sommità. Quando i francesi vi giungono vicino cessa il fuoco dell’artiglieria ma dall’erba, dove si erano nascosti, si levano 3 mila fucilieri che da una distanza di 40 metri falciano i francesi e li ricacciano, poi inseguiti dalle forze di Picton. A questo punto l’offensiva di Drouet D’Erlon, che lasciava sul terreno un terzo dei suoi effettivi, poteva considerarsi fallita. Anche sui fianchi i combattimenti sono intensi e la fanteria di entrambi le parti si dispone più volte in formazione a quadrato per contrastare la cavalleria. Gli inglesi formarono 20 quadrati e resistettero a ben 12 cariche di cavalleria, e Wellington più volte trova riparo all’interno di queste formazioni per evitare di essere catturato.
A questo punto, sono le 17, Ney, di sua iniziativa e senza avvisare Napoleone, decide di dare man forte a D’Erlon parendogli di vedere un certo sbandamento fra gli inglesi, forse i feriti allontanati dal campo di battaglia, e manda un primo assalto di 5 mila cavalieri, anche questi falciati dalla fucileria inglese in un fronte largo solo 800 metri tra Hougoumont e Haie Sante, senza il supporto dell’artiglieria e della fanteria, un errore da principiante. Quando, dopo ripetuti assalti senza risultati, decide di utilizzare artiglieria e fanteria, come di regola per quel tipo di combattimento, i suoi reparti sono sterminati. Alla fine della giornata dei 9 mila cavalieri di Ney mandati all’assalto ne sopravvivono 43. Nel frattempo Napoleone spedisce due divisioni con il generale Lobau a contrastare e fermare i prussiani in arrivo. Si susseguono continui attacchi con esiti incerti mentre inizia a scendere la sera.
Alla fine gli inglesi indietreggiano. Napoleone potrebbe impiegare la Vecchia Guardia per chiudere la battaglia ma il grande condottiero è indeciso, temporeggia. Nel frattempo i prussiani, dopo due ore di feroci combattimenti, nonostante anche l’impiego della Giovane Guardia riescono a passare e conquistare Plancenoit.
Non resta che la Vecchia Guardia, i veterani di tutte le vittorie. Alle 19,15 la Vecchia guardia del generale Morand riprende Plancenoit, ma si capisce subito che non serve più a niente: duemila soldati inglesi compaiono all’improvviso come sbucati da sotto terra e la prima ondata dei francesi viene abbattuta. Qualche reparto della Giovane Guardia inizia a scomporsi e retrocedere, confusi con l’invincibile Vecchia Guardia: questo segna l’inizio dello sbandamento francese.
Per ben tre volte il Generale Cambronne con la Vecchia Guardia risponde agli assalti inglesi con formazioni a quadrato rifiutando di arrendersi anche se ormai tutti i giochi sono fatti. Nel frattempo Blücher è riuscito ad insinuarsi tra Drouet e Lobau e prende Plancenoit. Di Grouchy nessuna traccia!
I francesi sono in rotta, i soldati della Guardia si sacrificano per permettere a Napoleone di fuggire. Sul terreno rimangono 25 mila francesi, 22 mila inglesi e 7 mila prussiani; 7 mila sono i prigionieri francesi. L’unico indenne è Grouchy che conoscerà l’esito della battaglia solo il giorno dopo.
* * *
I cultori della storia fatta con i “se” hanno destinato molte energie a chiedersi quale sarebbe stato l’assetto dell’Europa se Napoleone avesse sconfitto la Settima Coalizione a Waterloo. La pesante sconfitta, la distruzione dei suoi migliori reparti, il grande condottiero che abbandona il campo di battaglia protetto dagli ultimi dei suoi segna il definitivo tramonto delle sue fortune militari e di un’era che da queste era stata riverberata. Erano mutate le condizioni storiche e politiche che avevano favorito i successi di Napoleone. Ma se a Waterloo si compie la sconfitta del suo destino personale, non però quella della rivoluzione borghese, ormai trionfante su spezzoni feudali che sopravvivevano a stento nella vecchia Europa ed erano destinati a scomparire negli anni a venire nonostante la Restaurazione seguita al congresso di Vienna del 1815.
La traiettoria delle fortune militari e politiche di Napoleone, che
Von Clausewitz, il suo maggior studioso coevo, definirà ”genio della
guerra”, si infrangeva per concludersi con l’esilio nella sperduta
isola di Sant’Elena. Le forze europee, unite in successive Coalizioni
per la restaurazione delle vecchie monarchie spodestate, erano però ora
costrette a spartirsi il potere con la borghesia.
“Il Martirio del Proletariato nella Venezia Giulia”; con questo titolo la Libreria Editrice del Partito Comunista d’Italia pubblicava, nel 1921, l’intervento parlamentare del deputato Giuseppe Tuntar pronunciato il 21 luglio dello stesso anno.
Si tratta di un discorso tenuto alla Camera dei Deputati, cioè all’interno del tempio della menzogna borghese; è quindi naturale che il linguaggio, in un certo senso, risenta dell’ambiente. In un comizio proletario il tono sarebbe stato certamente diverso: in un comizio si parla per infuocare l’animo dei proletari, in parlamento per gettare circostanziate accuse in faccia ai rappresentanti borghesi. Infatti niente viene sottaciuto, le denunce rivolte al regime democratico sono nette, senza mezzi termini. Viene dimostrato come democrazia borghese e comunismo siamo incompatibili e come la democrazia, di fronte alla difesa di classe, non esiti un istante a violare i suoi stessi principi. Allo stesso modo il deputato comunista non implora il ritorno alla legalità democratica ed al rispetto per il proletariato dei diritti conculcati, anzi non esita a rivendicare il ruolo rivoluzionario del partito, l’uso della violenza di classe ed anche della rappresaglia contro le violenze subite. In poche parole, si tratta di un tipico esempio di quello che Lenin intendeva per parlamentarismo rivoluzionario.
Il documento, per la chiarezza della sua esposizione, non avrebbe bisogno di presentazione, ed i compagni che vogliono rinfrescarsi la memoria non hanno che da rileggersi la serie di articoli apparsi su Il Partito Comunista del 2009 che, rifacendo la storia della Sezione Italiana Adriatica del Partito Operaio Socialista in Austria, mettono in evidenza il suo carattere rivoluzionario, anti-irredentista ed internazionalista. Tant’è che, dopo il congresso di Livorno, nella sua stragrande maggioranza aderì al Partito Comunista d’Italia. Altro articolo da rileggere è quello del novembre 2010 sull’incendio del “Lavoratore “ di Trieste.
Visto che siamo in clima di 150° dell’unità nazionale, vogliamo soffermarci sul comportamento dell’esercito italiano durante e dopo quella che venne chiamata la “IV guerra di indipendenza”, che rappresentò il compimento dell’Unità nazionale e la “redenzione” degli ultimi italiani sottomessi all’Austria.
Il 24 maggio, alle cinque del mattino, le truppe italiane avevano attraversato il confine e nei primi giorni di guerra non avevano trovato resistenza. Gli unici ostacoli, oltre ai ponti fatti saltare, erano costituiti da rudimentali barricate, quasi sempre indifese, costituite da tronchi di alberi messi di traverso nelle strade principali. Pochissime azioni di disturbo furono effettuate da piccoli gruppi di gendarmi e soldati del Landsturm.
Gli austro-ungarici si erano attestati a ridosso della linea trincerata che, scendendo dalla valle dell’Isonzo correva davanti a Gorizia per risalire lungo il monte S. Michele a difesa del margine dell’altipiano di Doberdò, fino ad arrivare al mare tra S. Giovanni di Duino e Monfalcone.
Quello che restava degli abitanti delle zone sgomberate era stato abbandonato al proprio destino, cioè nelle mani dei “redentori”. Quando questi arrivarono, già da quasi un anno la popolazione subiva le conseguenze della guerra. L’ordinanza imperiale del 26 luglio 1914 aveva ordinato la coscrizione obbligatoria per tutti i maschi da 18 a 37 anni. Poi il 6 maggio 1915 furono chiamati alle armi gli uomini validi fino ai 42 anni di età. Qualche giorno dopo, in tutti i paesi del confine, vennero precettati anche i cinquantenni per trasportare verso l’interno, con carri e buoi, macchinari, manufatti e beni provenienti dalle fabbriche e dai magazzini della provincia e tutto quanto non avrebbe dovuto cadere in mano nemica. Quindi gli italiani trovarono paesi con una popolazione composta essenzialmente di anziani, donne e bambini.
Prima ancora che la guerra vera e propria iniziasse gli italiani cominciarono ad internare in massa la popolazione. Anche i preti perché ritenuti, quasi tutti, “austriacanti”. L’obiettivo a cui il provvedimento mirava può essere riassunto nelle parole del Segretario generale per gli Affari Civili, D’Adamo: «È indispensabile sia ben fermo e radicato nelle menti delle popolazioni che abitano nei territori occupati che nessun ritorno allo stato precedente può essere anche lontanamente ammissibile, e che su di esse è esercitata e irremovibilmente la sovranità d’Italia» (20 marzo 1916). Questo fu lo spirito con cui si intese colpire tutti coloro fossero ritenuti contrari o semplicemente “tiepidi” nei confronti dell’occupazione italiana.
Gli internamenti delle persone “sospette” vennero attuati in maniera arbitraria, senza che fosse stata emanata alcuna norma che indicasse le motivazioni in base alle quali si potessero eseguire le deportazioni. Gli arrestati venivano classificati, anche nei documenti ufficiali, nelle forme più varie: prigionieri civili, ostaggi, profughi, espulsi, presunte spie, detenuti, renitenti, etc.; venivano quindi inviati in luoghi di concentramento e carceri.
Il presidente del consiglio, Salandra, in una minuta preparatoria del suo intervento alla Camera dell’11 dicembre 1915, a proposito dei provvedimenti di internamento, scriveva: «L’allontanamento dalla zona di guerra di cittadini sui quali gravano sospetti, è provvedimento di polizia militare, fondato non su fatti specifici (che condurrebbero a processi innanzi ai tribunali di guerra e ad esemplari condanne), ma sulla condotta, su relazioni con l’estero, su pubbliche dichiarazioni, su considerazioni, infine, di qualsiasi natura che inducono a far ritenere pericolosa la presenza di individui che anche incoscientemente e senza loro colpa possono comunque avvantaggiare la condizione del nemico». Da ciò si evince come tutta quanta la popolazione delle zone di guerra potesse venire indiscriminatamente “internata”.
Inoltre esisteva la categoria dei cosiddetti “profughi”, obbligati con la forza a sgomberare e concentrati in varie zone del territorio italiano, per i quali, pur essendo «in una posizione giuridica anormale», Salandra dichiarava che, bontà sua, non vi era «alcuna imputazione di polizia a loro danno».
La misura dell’internamento consisteva dunque nell’arresto e allontanamento in massa di persone considerate pericolose dalle autorità militari che venivano deportate di volta in volta in determinate località del Regno. Da parte loro, gli internati, il più delle volte non venivano nemmeno messi a conoscenza del motivo dei provvedimenti presi a loro carico.
Turati in un suo intervento alla Camera, il 6 giugno 1916, affermava che «si erano espulsi, internati, balestrati in esilio migliaia di individui, rovinate migliaia di famiglie e offese anche nell’onore senza la minima motivazione, senza un atto di accusa qualsiasi, senza il più piccolo contraddittorio, senza neppure quel semplice interrogatorio, che il più delle volte basta a dissipare le accuse infondate contro una persona; senza che i sequestrati, gli staggiti, i deportati venissero a conoscere il supposto perché della loro condanna; senza che avessero la possibilità di vedere in faccia i loro accusatori, di difendersi e, se condannati, di presentare un’istanza d’appello, di invocare quella revisione che non si nega al parricida condannato all’ergastolo!».
Riguardo poi al numero totale di internati dalle autorità italiane sia nel corso della guerra sia nell’anno immediatamente successivo al termine del conflitto, ossia dal 1915 al 1919, non ci sono fonti sicure. In un opuscolo del 1923 intitolato “Giustizia durante e dopo la guerra”, Giacomo Soravito de Franceschi, riferendosi a “calcoli approssimativi che risalgono al luglio/agosto del 1915”, stimava in 70.000 il numero degli internati dalle “terre redente”. Oggi, da parte dei ricercatori, si tende a considerare esagerata detta cifra, ma lo stesso numero, 70.000, veniva citato nel 1939 dallo storico Giuseppe del Bianco nella sua “La guerra e il Friuli”, pubblicata con il consenso del regime.
Di solito i malcapitati, prima di venire tradotti nelle località di destinazione, erano temporaneamente ammassati nelle carceri di Palmanova o di Udine. Un anonimo memorialista narra le vicissitudini dei prigionieri: «Ammanettati come delinquenti, il popolo sui carri, le persone civili in carrozza scoperta, sotto scorta di lancieri e carabinieri a cavallo, un ufficiale alla testa, si avviavano a Palmanova, dove una plebaglia feroce, sapientemente aizzata da fuoriusciti e disertori, munita di frutta marcia, di sassi, di bastoni, dava l’assalto al convoglio e penetrando tra la fila della scorta, copriva di immondizie di vituperi e di percosse l’innocenti vittime della vendetta liberale-irredentistica. Alle porte del carcere mandamentale, bisognava smontar di vettura, passando tra due file di mascalzoni che menavano le mani a più non posso [...] Quando dopo due giorni il carcere era pieno, si facevano scender in cortile i prigionieri verso le 10 ant. si ammanettavano a 2 a 2 fra i lazzi del popolaccio dall’alto d’un muraglione sito dietro il carcere, avendo cura quando i prigionieri raggiungevano il numero di 12, di assicurare le castagnole che univano ogni coppia, con una catena trasversale che saldava dalla testa alla coda l’intera colonna [...] Verso l’una si aprivano le porte, e si caricavano i prigionieri sui camions, gettandoli dentro legati come maiali. Nel salire il popolo gli spingeva sconciamente, strappando la talare ai sacerdoti, colpendo tutti con chiavi, pezzi di legno, sassi ecc.., mentre i carabinieri lasciavan libero sfogo al furor popolare» (Citato da Milocco: “Fratelli d’Italia”).
Poiché non rientra nel nostro costume quello di piangere sulle angherie sopportate dal proletariato, non andiamo oltre nel descrivere le condizioni dei popoli italiani “redenti”, ricordiamo solo che gli internati comprendevano anche bambini e vecchi di oltre settante anni.
Finita la guerra e compiuta l’unità d’Italia la caccia ai sospetti anti-italiani divenne ancora più feroce. Ma ora, accanto alle tradizionali accuse di lealismo austriaco e appartenenza al movimento cattolico, si affiancavano imputazioni di stampo diverso, legate a quello che le autorità italiane consideravano lo spettro del bolscevismo.
“Il Lavoratore” di Trieste del 16 gennaio 1918 denunciava il sistema di internamento praticato dagli italiani: «Non possiamo esimerci dallo stigmatizzare aspramente le misure prese durante l’occupazione dalle autorità militari e civili italiane contro moltissimi friulani, fra cui non pochi compagni nostri nient’altro rei che d’essere rimasti fedeli alle loro convinzioni politiche. Non va neanche sottaciuto che molti degli internamenti furono provocati non tanto per iniziativa delle autorità militari italiane, quanto per la pressioni di quegli “eroi e martiri”, i quali, dopo aver bramato lo scoppio della guerra tra Austria e Italia, alla trincea preferirono la comoda professione di denunciatori, come dimostreremo in momento più opportuno. Fra gli internati c’è ad esempio l’ottimo compagno nostro Clement di Cormons, colpevole d’essersi rifiutato di sottoscrivere il prestito di guerra italiano. Non gli giovò l’affermare ch’egli non avrebbe sottoscritto nessun prestito, a nessun Governo, perché ciò contrastava con la sua coscienza di socialista: fu internato in forme ben poco urbane assieme a tutti i suoi! Né si badò, neppure in Friuli, agli acciacchi dell’età e alle condizioni di salute, ché vennero internati in isolotti e scogli della Sardegna o dell’Italia meridionale vecchi settantenni solamente perché pensionati austriaci o sospetti di “tiepidi sentimenti nazionali”. Gli addetti poi alle Casse ammalati amministrate dai socialisti furono quasi tutti licenziati dai loro posti e internati, e si deve soltanto alle energiche proteste del gruppo parlamentare socialista italiano se a qualcuno l’internamento fu commutato in confinamento».
Nel suo discorso il compagno Tuntar denuncia casi di fucilazioni, avvenute in Friuli, ai danni di “poveri ed innocenti proletari e contadini”, ed in modo particolare quelli di Lucinico e Villesse.
È veramente impressionante come una cappa omertosa abbia cancellato il ricordo di questi episodi. Riguardo a Lucinico non siamo riusciti a trovare la minima notizia, mentre qualche cosa siamo stati in grado di rintracciare per Villesse.
La sera del 25 maggio vi giunsero i primi cavalleggeri italiani. Il 27 il maggiore Citarella prese possesso del paese, impose il coprifuoco non garantendo l’incolumità ai civili trovati per strada nelle ore serali. Non a caso Citarella era un veterano della guerra di Libia dove, con il suo reparto, si era distinto nelle sanguinose repressioni di Sciara Sciat.
Nel diario storico del XIII reggimento si legge: «Nella nottata 29/30 maggio 1915 il comandante del battaglione [Citarella]... ha preso ostaggi. Taluni si sono ribellati e sono stati uccisi dai soldati». In effetti gli ostaggi erano stati già presi in numero di 149, divisi in gruppi, e, in previsione di attacchi austriaci, erano stati posti davanti alle barricate come scudi umani. Nella notte si verificò uno scontro a fuoco, la popolazione venne accusata di avere sparato sulle truppe italiane, immediatamente dopo almeno sei ostaggi vennero fucilati davanti ad una delle barricate che sbarrava l’ingresso al paese. Un altro civile venne poi ucciso davanti al cancello del cimitero. Il motivo? Il maggiore Citarella dichiarò che si trattava di “un giovane robustissimo, intelligentissimo”, quindi non avrebbe potuto che essere “un ufficiale austriaco o per lo meno un messo dell’Austria”.
In un rapporto della prefettura del Friuli del 24 ottobre 1925 (si noti la data!) si legge: «non risponde a verità che gli ostaggi, insieme ad altri cittadini si siano rivoltati alle nostre truppe, poiché persone [...] in quell’epoca alle dipendenze, come informatori, dei nostri Comandi Militari lo hanno completamente escluso». Rimane ora da spiegare l’origine della sparatoria, chi fossero gli attaccanti. Basta continuare la lettura del medesimo rapporto prefettizio che riporta il risultato dell’inchiesta militare ordinata subito dopo il fatto: «Di notte, senza saperlo, per evidente errore i soldati si erano sparati fra loro, come risulta da una perizia fatta eseguire dall’Autorità Militare sui proiettili che erano stati confezionati in Bologna o nei pressi della città». Quindi l’uccisione degli ostaggi fu a puro scopo di terrorismo, pur sapendo della innocenza loro e della popolazione.
Dopo aver ricordato una delle tante gloriose pagine della storia
italiana,
passiamo alla lettura del discorso del compagno Giuseppe Tuntar.
Libreria Editrice del Partito Comunista d’Italia
IL MARTIRIO DEL PROLETARIATO
NELLA VENEZIA GIULIA
Intervento parlamentare del deputato
Giuseppe Tuntar
pronunciato il 21 luglio 1921
PRESIDENTE. - Continuando la discussione sulle comunicazioni del Governo, ha facoltà di parlare l’onorevole Tuntar.
TUNTAR. - Quando l’onorevole Giolitti chiese, dopo le sue dimissioni, l’esercizio provvisorio per un mese, io, a nome del gruppo comunista, dichiarai che noi avremmo votato anche contro l’esercizio provvisorio per un mese perché convinti, prescindendo dalle nostre concezioni generali secondo cui ogni Governo borghese è necessariamente il comitato esecutivo degli interessi della classe capitalista, che il prossimo Governo non si sarebbe differenziato in nulla da quelli precedenti.
L’esame della situazione parlamentare ed il risultato della soluzione della crisi hanno dato completamente ragione a quella mia previsione ed io, siccome dovevo, proprio nello stesso giorno in cui l’onorevole Giolitti presentò le sue dimissioni, esporre l’atto d’accusa delle popolazioni della Venezia Giulia contro l’infame trattamento cui sono soggette da quasi tre anni, ho piacere di vedere al banco del Ministero, come capo del Governo, Sua Eccellenza l’onorevole Bonomi, che dei governi precedenti è stato magna pars.
Il discorso del trono dice: “Ai rappresentanti delle nuove terre, liberamente eletti dalle laboriose popolazioni di cui si accresce e si rafforza l’Italia, io rivolgo il mio saluto. Qui, nell’Assemblea nazionale che si amplia per raccoglierli, troveranno viva e perpetua la tradizione romana che plasma gli ordinamenti diversi e le varietà della cultura in una unità che non è mai soggezione”.
Il trattamento cui è soggetta la Venezia Giulia da circa tre anni è un’aperta smentita alle parole che sono state messe dall’onorevole Giolitti in bocca al rappresentante della Corona. La Venezia Giulia è stata trasformata, per cecità dei rappresentanti del Governo italiano, in una seconda Irlanda (Rumori dall’estrema destra). La Venezia Giulia è stata trattata non come una provincia pretesamente redenta, ma come una colonia, una provincia conquistata.
Si cominciò già nel 1915 allo scoppio della guerra ed io domanderei conto proprio all’onorevole Bonomi, oggi presidente dei ministri, perché ancora il ministro della guerra non ha risposto ad alcune interpellanze riguardanti i fatti obbrobriosi avvenuti a Lucinico ed in altre parti del Friuli, in cui dei poveri ed innocenti proletari e contadini sono stati fucilati ingiustamente da uomini i quali erano venuti nella Venezia Giulia animati da un odio settario contro quelle popolazioni, che non conoscevano, perché era stato loro detto che quelle popolazioni erano tutte austriacanti, mentre erano certamente contrarie alla guerra, ma non meritavano quella crudelissima sorte da parte di coloro che venivano coll’idea di redimerli nazionalmente.
Potrei citare dei fatti tremendi a questo riguardo, ma attendo che l’onorevole Bonomi, il quale è stato ministro della guerra, ecciti il suo collega onorevole Gasparotto ad affrettare quell’inchiesta, la quale, se non fosse alfine esaurita con la punizione dei responsabili, turberebbe la coscienza di quelle popolazioni colpite nei sentimenti più sacri.
GASPAROTTO (ministro della guerra). - Atti di crudeltà da parte di soldati italiani non risultarono mai!
GRECO. - Dica a chi allude! (Commenti - Rumori all’estrema sinistra)
TUNTAR. - All’onorevole Gasparotto, ministro della guerra, io domando l’esito della inchiesta sulle immonde fucilazioni di Villesse e di Lucinico due località e nient’altro.
L’onorevole Gasparotto, che conosce quelle località, spero che risponderà e saprà risarcire le famiglie di quei poveri contadini, i cui capi furono fucilati mentre coltivavano pacificamente le loro campagne (Interruzioni e rumori a destra).
Quello che ha fatto l’Italia borghese
È un fatto che l’Italia borghese, perché io distinguo l’Italia borghese dall’Italia proletaria (Commenti, rumori, interruzioni), l’Italia borghese, monarchica, è venuta nelle nostre provincie del tutto impreparata, benché le truppe italiane fossero entrate a Trieste nell’ottobre 1918, dopo oltre tre anni di guerra, mentre si poteva avere tutto il tempo per studiare la psicologia delle nostre popolazioni, gli ordinamenti esistenti e le differenze tra le due nazionalità. Ora l’Italia, borghese, militarista, monarchica, fu del tutto impreparata ad affrontare tali problemi (Rumori, commenti). Una cosa sola ha fatto: ha mantenuto tutte le peggiori leggi austriache e ha tralasciato di introdurre le migliori leggi italiane (Rumori a destra).
L’Italia borghese avrebbe potuto acquistare, non dirò le simpatie, ma almeno l’adattamento al suo regime, se avesse provveduto, dopo che l’Austria reazionaria e asburgica aveva deportato quasi tutti i profughi, dal Goriziano e dall’Istria nelle baracche di Wagna e in altre località, a ricostruire, come suo primo dovere, le case dei contadini ed operai prima dei palazzi della borghesia. Se voi prendete il treno a Mestre e vi recate verso Trieste attraverso i campi dolorosi di guerra, in cui sono sepolte le migliori forze giovanili lavoratrici del popolo italiano e della defunta Austria-Ungheria; se voi prendete il treno e vi fermate a Gorizia, a Lucinico, a Gradisca, ecc., voi vedrete che le case borghesi, di quella borghesia che sotto l’Austria ammetto in parte che sia stata anche internata, sono state subito ricostruite. I borghesi hanno avuto già i compensi per i danni da loro subiti, le loro case sono ricostruite e i palazzi dei ricchi signori di Gorizia, di Monfalcone, di Gradisca, ecc., sono ben riparati, mentre i contadini, i proletari dormono ancora nelle baracche a Lucinico, a Sant’Andrea, a Podgora, a San Pietro (Rumori, interruzioni vivacissime all’estrema destra).
PRESIDENTE. - Non interrompano!
TUNTAR. - a Podgora, a Lucinico, a Vertoiba, a San Pietro, a Sant’Andrea, a Savogna, a Salcano ed in tanti altri paesi di quella regione i proletari, i contadini vivono in baracche indegne di ogni civile consorzio (Rumori all’estrema destra. Una voce: Esagerazioni! Rumori all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. - Facciamo silenzio! Risponderà il Governo!...
TUNTAR. - A Monfalcone...
GIUNTA. - a Monfalcone ci sono i villini per gli operai!
PRESIDENTE (Con forza). - Ma non posso consentire che si prosegua a questo modo. Lasciamo che risponda il Governo! E se vogliono parlare, ne domandino la facoltà!
TUNTAR. - A Monfalcone gli operai vivono, per quanto riguarda le abitazioni, un po’ meglio che altrove, ma non certo per l’azione governativa, sì bene per quella di un industriale privato e perché non tutte le case operaie erano state demolite dalla guerra.
GIUNTA. - Non è vero! Sono state ricostruite tutte! (Rumori all’estrema sinistra).
TUNTAR. - Nel Carso, poi, la situazione è indescrivibile. La popolazione ha dovuto costruirsi da sé delle miserabili baracche con rozzo materiale residuato e non ha acqua da bere... (Una voce all’estrema destra: Se non c’è mai stata! Rumori all’estrema sinistra).
PRESIDENTE. - Facciano silenzio! Risponderà il Governo che ha diritto e il dovere di rispondere. (Una voce all’estrema destra: Ma se è tutta una diffamazione. Approvazioni all’estrema destra. Rumori vivissimi).
PRESIDENTE. - Prosegua, onorevole Tuntar.
TUNTAR. - Per concludere su questo punto io affermo che, mentre la borghesia nazionalista, tanto italiana che slovena, ha le sue case riparate, il proletariato di lingua slovena nei paesi danneggiati e distrutti ancora deve vivere nelle baracche e anche nelle caverne o nelle spelonche. Questa la situazione vera di quei paesi (Commenti). E quello che ho detto per la ricostruzione vale anche per gli indennizzi. I martiri dell’italianità, quelli che nell’anniversario della battaglia di Novara si inchinavano genuflessi alle autorità austriache, questi pretesi martiri dell’italianità hanno ricevuto tutto o quasi tutto il loro indennizzo per i pretesi danni sofferti, ma per i danni realmente sofferti dai proletari, dalle famiglie degli operai, dei contadini e dei piccoli esercenti della provincia di Gorizia e dell’Istria, costrette ad abitare ancora negli infami baraccamenti, non si è pensato ancora ad alcun indennizzo.
I capi della pretesa italianità, dico pretesa, perché ieri si inchinavano agli Asburgo, oggi si inchinano dinanzi ai Savoia... (Approvazioni dall’estrema sinistra - Rumori all’estrema destra) questi capi dell’italianità hanno ricevuto il loro indennizzo: non l’hanno ricevuto i proletari, i contadini del Goriziano e dell’Istria!
La giustizia e la tortura
Ma, quello su cui devo intrattenermi abbastanza lungamente ancora... (Rumori: Magari fino a mezzanotte! Proteste. Rumori) quello che ha suscitato nelle classi lavoratrici della Venezia Giulia il massimo risentimento verso il nuovo regime, è stato il contegno della giustizia, militare prima e civile poi. Voi mi direte austriacante... (Voci all’estrema destra: No, Jugoslavo! Rumori).
TUNTAR. - Vi dirò che sotto l’Austria i carcerati politici non venivano bastonati (Rumori) Sfido i signori che sono su quei banchi a provare il contrario! Essi non hanno mai provato le delizie delle carceri austriache come le ho provate io! (Voci all’estrema destra: Per quali reati? Ilarità - Rumori).
PRESIDENTE. - Ma la finiscano una buona volta con le interruzioni!
TUNTAR. - I carcerati e condannati politici sotto l’Austria non venivano bastonati, almeno nei nostri paesi. Invece, colla venuta del nuovo regime, non dirò italiano, perché io so distinguere fra il nome italiano e l’Italia borghese e monarchica, nelle nostre terre (Proteste e rumori all’estrema destra) la bastonatura dei carcerati politici è divenuta un metodo un sistema (Proteste all’estrema destra).
Alla vigilia delle elezioni politiche bisognava a Trieste scoprire un complotto. Ci si servì di un certo tenente ex-austriaco Grossman, agente provocatore, pagato dalla questura di Trieste con cinquemila lire, e vennero imprigionati circa 40 giovani comunisti.
Leggerò alla Camera una lettera contenente la descrizione delle sevizie inflitte a quei giovani, i quali (guardate la combinazione) temendosi il processo, di questi giorni sono stati tutti rilasciati dal tribunale di Trieste, perché non era igienico per la giustizia borghese e monarchica... (Vivacissimi rumori all’estrema destra) di aprire un siffatto processo. Udite come sono stati trattati i carcerati comunisti arrestati per il famoso complotto (Voci all’estrema destra: La lettera chi l’ha scritta? L’hanno scritta loro! Rumori all’estrema sinistra).
TUNTAR. - È firmata e se non basterà questa testimonianza, leggerò le attestazioni di giornali non comunisti, per esempio L’Emancipazione di Trieste ed anche di qualche giornale borghese.
Ecco la lettera: «Il tenente Fagioni, noto boia di Trieste della tenenza di via Chiozza, arrestò, in seguito alla delazione di qualche individuo infiltratosi nelle nostre file (l’agente provocatore Grossman, di cui la questura italiana di Trieste si serviva), il compagno Sciabar, il quale battuto a sangue dovette svelare i nomi dei componenti il direttorio, sempre dietro intimidazione del tenente Fagioni. Questi conosceva tutti i componenti il direttorio, ma, volendo essere sicuro dell’autenticità di questi nomi e delle loro funzioni, costrinse a colpi di verga e di moschetto il compagno Sciabar ad affermare veridico quello che si diceva.
«Poi, sempre munito di dati precisi, fece arrestare tutto il direttorio e inoltre moltissimi compagni comunisti. Il compagno Vidali, condotto a San Giovanni, fu battuto a sangue con nervi di bue, finché sanguinante per le percosse cadde mezzo svenuto.
«Riavutosi alquanto, un carabiniere lo prese per le carni della gola, stringendolo così fortemente da farlo cadere mezzo soffocato (Interruzioni - Rumori). È da notarsi che i carabinieri, spaventati dall’immobilità del comp. Vidali e credendo di averlo ucciso, gridarono di chiamare la guardia medica.
«Il tenente Fagioni, (che per ragioni igieniche presentemente è ammalato, ma venne promosso per meriti di ufficio!) categoricamente rifiutò.
«Al compagno Canziani furono legati gli organi genitali con una corda così strettamente che cadde al suolo svenuto, non sostenendo questo dolore» (Rumori vivissimi a destra).
PRESIDENTE. - Facciamo silenzio! La finiscano!
TUNTAR. - «Acciocché vi sembrino più veritiere queste nostre affermazioni, si sappia che mentre alcuni compagni nostri si trovavano a San Giovanni, venne a noi una ragazza tutta spaventata e singhiozzante ad annunciarci che le urla di questi disgraziati si udivano dalla strada, e ci pregò che intervenissimo in qualche modo (Rumori alla estrema destra - Proteste vivacissime all’estrema sinistra verso la destra).
«Il compagno Apollonio fu messo per un’ora sotto una doccia fredda e poscia trasportato in una sala... (Rumori a destra).
GRAY. - Ma nessuno vi crede! (Rumori e proteste all’estrema sinistra).
TUNTAR. - «...ove erano aperte tutte le finestre nella speranza che si prendesse una polmonite. Prima di farlo entrare lo cosparsero di sale, fregandogli la schiena col medesimo (Rumori a destra). E poscia glenuflesso lo fecero camminare sul pavimento cosparso di sale (Commenti - Rumori vivissimi da varie parti). Un brigadiere, Schiffano, sputò in bocca ad un nostro compagno e poi lo prese per il collo in modo che dovette inghiottire il rifiuto (Rumori a destra).
«Gli sbirri capeggiati dal venduto Fagioni, non terminavano le loro atroci invenzioni ma ne trovavano sempre di nuove. Fagioni acciocché i nostri compagni rivelassero la congiura ordinò ai carabinieri di chiudere le mani dei disgraziati fra gli stipiti d’una porta aprendola e chiudendola, in modo che il dolore fosse più acuto. E mentre i nostri compagni giacevano in quella posizione, gli sbirri li colpivano con calci dei moschetti, rompendo allo Scabar due denti (Rumori a destra).
GRAY. - Ma non le credete neanche voi certe fandonie (Rumori all’estrema sinistra).
TUNTAR. - «Scabar inoltre venne legato e steso al suolo e gli salivano con gli stivali sul ventre (rumori e interruzioni a destra) finché un flotto sanguigno gli riempì la bocca».
Queste non sono esagerazioni. Sono verità. Chi più chi meno, tutti i compagni nostri furono trattati allo stesso modo! (Vive interruzioni all’estrema destra, scambio di vivacissime apostrofi fra l’estrema destra e l’estrema sinistra).
A questo punto si è svolto nell’aula parlamentare un vivacissimo incidente, dopo il quale il nostro compagno ha riavuto la parola.
TUNTAR. - Che la mia esposizione non sia solamente di fonte comunista o cosidetta bolscevica, lo prova anche la stampa avversaria.
L’Azione di Gorizia, organo del blocco nazionale nelle ultime elezioni politiche, di cui facevano parte anche i fascisti, scrive: «Ma tanto è inutile chiedere allo Stato italiano quello che non ha mai avuto; cioè la coscienza della moralità dello Stato e della necessità morale di chi lo rappresenta. Per ora l’Italia è quella che è».
E La Libertà, organo dei repubblicani di Gorizia, scrive: «E voi parlate - accennando all’accusa di austriacantismo rivolta alle popolazioni del Friuli - voi parlate di austriacantismo. Ma via! Tacete per carità! E piuttosto badate a che nel nostro paese non vengano introdotti certi costumi degni della Cirenaica e dell’Eritrea. Perché qui non siamo né arabi, né abissini. E se ebbimo bisogno di libertà, non ebbimo, né abbiamo bisogno di civiltà d’importazione».
E non parlo del funzionamento dell’Ufficio centrale per le nuove provincie perché spero di aver l’occasione di trattarne un’altra volta.
Voi comprendete che, dato il malcontento suscitato dall’amministrazione del Governo italiano nelle nostre provincie, bisognava creare per le elezioni politiche una atmosfera favorevole e quindi dalla Venezia Giulia cominciò ad infierire il fascismo, che io non ho mai considerato, a differenza di alcuni miei ex compagni, come un fenomeno localistico della Venezia Giulia, ma come la controrivoluzione prima della rivoluzione.
Non è l’on. Mussolini il capo od il creatore del fascismo nella Venezia Giulia e nell’Italia. Gli alimentatori sono la classe borghese, gli altissimi personaggi della Corte e i generali dell’esercito. Tutti lo sanno: il generale Giardino, il generale Cappello, il generale Caviglia e il Duca d’Aosta sono i principali sostenitori del fascismo (Interruzioni a destra, rumori altissimi, invettive).
GASPAROTTO, ministro della guerra. - Ma non dica cose assurde!
TUNTAR. - Io accuso esplicitamente l’onorevole Bonomi, presidente del Consiglio dei Ministri (interruzioni a destra, apostrofi, rumori), di non aver, mentre era ministro della guerra, impedito... (interruzioni all’estrema destra - rumori. Voci a destra: Basta, basta!)
PRESIDENTE. - L’onorevole Tuntar si rivolge al presidente del Consiglio, il quale per primo ha il diritto di conoscere cosa si dice contro di lui (rumori). Attenda, onorevole Tuntar. (Rumori, interruzioni a destra, voci di: Basta, basta!). Prosegua onorevole Tuntar.
TUNTAR. - Il fatto è che mentre era ministro della guerra l’onorevole Bonomi, gli ufficiali dell’esercito inquadravano i fascisti nella Venezia Giulia e i depositi militari fornivano loro le armi.
BONOMI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’interno. - Lei dice delle cose che non rispondono a realtà. Affermo qui recisamente che l’esercito, nei suoi capi, nei suoi gregari è all’infuori e al di sopra di ogni competizione politica (Vivissimi e prolungati applausi).
TUNTAR. - Il Lavoratore di Trieste ha dimostrato con prove apodittiche che quello che io dico, era ed è vero, e l’onorevole ministro Bonomi non ha preso nessun provvedimento. Era chiaro, ripeto, che bisognava preparare un’atmosfera per le elezioni politiche ed allora si ricorse ai due ferrivecchi dell’austriacantismo e del bolscevismo. Noi non rinneghiamo nulla della nostra gloriosa tradizione internazionalista, che ha sempre guidato le forze del proletariato nella Venezia Giulia (interruzioni, rumori), e questa tradizione internazionalista noi la continueremo, perché in essa vediamo il solo metodo di difesa dei diritti proletari. Questa tradizione noi la portammo immarcescibile nel partito socialista italiano prima, nel partito comunista d’Italia poi.
Contro la cultura proletaria
Se c’era una provincia, una regione, in cui il fascismo non doveva esperimentare i suoi mezzi era proprio la Venezia Giulia, ove convivono due stirpi che fino a ieri erano preda dell’azione fratricida di due borghesie. Il proletariato era riuscito a costruire i suoi fortilizi, i suoi circoli di cultura, perché tanto la borghesia nazionalista italiana che quella slava, teneva nell’abbrutimento intellettuale sia il proletariato italiano che quello slavo. Noi avevamo con grandi sacrifici, giorno per giorno, settimana per settimana, anno per anno, costruito questi grandi fortilizi del proletariato della Venezia Giulia.
I fascisti, protetti dalle guardie regie... (rumori vivissimi a destra) hanno tutto distrutto, e oggi nella Venezia Giulia non esiste più nemmeno un Circolo di cultura proletaria e sono state distrutte anche quelle meravigliose biblioteche, in cui si coltivava l’attaccamento anche alla cultura italiana. Tutto è stato distrutto dal fascismo (applausi all’estrema sinistra) con l’ausilio e la cooperazione del Governo.
Citerò una testimonianza - non crediate che io esponga queste cose con compiacimento, perché so che la borghesia ha altri mezzi per difendersi contro l’avanzata proletaria, che non siano questi mezzi, cui oggi ricorre per cercare di estirpare ogni movimento proletario - citerò una testimonianza non sospetta: quello che ha scritto L’Emancipazione, organo repubblicano mazziniano di Trieste: «Il fascismo devastò ed incendiò, compiendo un vero delitto contro l’italianità a Trieste e nella regione, i circoli di cultura operaia dove c’erano le ottime biblioteche popolari, solamente italiane, che qualunque regione d’Italia avrebbe dovuto invidiare ai “beduini” della Venezia Giulia». Il fascismo ha incendiato la Camera del Lavoro di Trieste, dove si faceva sì della politica, ma dove c’era anche un Circolo di studi sociali, sotto i cui auspici, per esempio, nel 1905, l’onorevole Enrico Ferri teneva le più grandi e popolari commemorazioni dei maggiori patrioti d’Italia, a cominciare da Giuseppe Garibaldi, a Bovio, a Cavallotti, a Imbriani, mentre tanta parte di quella borghesia panciafichista oggi rifugiata sotto il paravento fascista, se ne stava allora a fare il chilo sotto le capaci ali dell’aquila bicipite.
Andrei troppo per le lunghe se volessi dimostrare coi fatti innegabili come la distruzione di tutte le istituzioni proletarie della Venezia Giulia sia avvenuta con l’approvazione e con la cooperazione degli organi governativi. Io mi soffermerò al secondo incendio del Lavoratore, del Lavoratore Comunista, al quale ho assistito.
Alle 19 e mezzo Sua Eccellenza Mosconi il quale rimane governatore di Trieste per i servizi resi ad un ex-presidente del Consiglio, era stato avvisato, dico alle diciannove e mezzo, che alle ventitrè di sera i fascisti avrebbero incendiato Il Lavoratore Comunista.
Alle ventuna e mezzo vennero chiusi dalle guardie regie e dai carabinieri tutti gli sbocchi delle vie che conducono a quella dove era la sede del giornale, mentre i fascisti indisturbati visitavano la saccocce dei passanti per vedere se portavano la rivoltella e per impedire l’accorrere di operai verso il giornale.
Alle ventritrè ed un quarto in punto i fascisti capitarono sotto la redazione del giornale. I giovani comunisti risposero come si doveva rispondere.
I fascisti vennero respinti due volte, ed allora capitarono le guardie regie e si condusse la brigata Sassari all’assalto del Lavoratore Comunista (Rumori). E dopo che eravamo tutti stati ammanettati, mentre il questore Perilli e il Commissario Carusi sorridevano ironicamente, noi venivamo battuti e bastonati dalle guardie regie; frattanto i fascisti, sotto i loro occhi, incendiavano il Lavoratore: si ebbe poi l’impudenza di tenere noi tre mesi in prigione (Applausi all’estrema sinistra).
Santa rappresaglia
Naturalmente il proletariato della Venezia Giulia, stanco di assistere alla impudente connivenza delle autorità governative civili e militari con i fascisti, dopo il terzo incendio (tre volte venne incendiata la Camera del Lavoro, il magnifico fortilizio del proletariato di Trieste... (Vivi rumori all’estrema destra).
Il proletariato di Trieste allora è ricorso alla santa rappresaglia ed ha colpito chi doveva colpire: gli alimentatori del fascismo, incendiando il cantiere di S. Marco. E la giuria popolare di Trieste, compresa la situazione intollerabile creata dal nuovo regime alle nostre provincie, assolse ad unanimità di voti gli accusati incendiari, ai quali io mando il mio saluto solidale! (Applausi dei comunisti - Vivi rumori e proteste a destra).
Il Lavoratore Comunista risorgerà fra breve. Io vi sfido a incendiarlo ancora. Vedrete cosa saprà fare il proletariato di Trieste! Compirà una rappresaglia tremenda!... (Vivi rumori all’estrema destra).
E nei pochissimi giorni del governo dell’on. Bonomi, il fascismo della Venezia Giulia continua imperturbabile le sue gesta. È avvenuto un nuovo incendio della Camera del Lavoro di Pola, della casa di quel proletariato (e in quest’aula c’è qualcuno che potrebbe comprovarlo), il quale in un’ora tragica, veramente tragica per l’Istria, aveva saputo anche fare tutto il suo dovere civile contro le autorità marinaresche austriache! Ebbene, a quel proletariato di Pola, per ben tre volte venne incendiata dai fascisti la Camera del Lavoro, sotto gli occhi delle guardie regie e degli agenti investigativi, senza che nessuno mai venisse arrestato! (Commenti - Rumori).
A Trieste, sotto gli occhi degli agenti, viene bastonato l’avvocato Zennaro, difensore degli accusati per l’incendio del cantiere di San Marco. Domenica 10 c.m. a Mossa (ero presente fortunatamente anche io) dopo che gli operai di quel villaggio industre e laborioso avevano accompagnato all’estrema dimora un loro compagno di lavoro, una squadra fascista, sostenuta, onorevole Gasparotto, dal comandante militare del presidio di Mossa, revolverò quei lavoratori perché comunisti (Vive proteste e rumori alla estrema destra).
Ma che di più? Vengono scarcerati alcuni forti minatori di Albona. Vanno ad Albona e vengono aggrediti dai fascisti. E sapete cosa avviene? Che vengono messi in prigione gli aggrediti liberati dal carcere, e i fascisti sono lasciati indisturbati.
Elezioni infami
Si fecero le elezioni politiche. Io che conosco l’ambiente posso dire che, se le elezioni della Venezia Giulia fossero avvenute in modo corrispondente alla libertà di voto, forse due o tre candidati borghesi italiani sarebbero stati eletti, e non di più (Apostrofi all’estrema destra - Rumori).
La prova migliore l’abbiamo in questo: che nel Goriziano, dove è avvenuto nella giornata elettorale l’unico incidente del defraudo delle urne e degli atti elettorali di una sezione da parte dei fascisti (e adesso ricorrono alla Giunta delle elezioni per questo fatto!): nel Goriziano, dove le elezioni si svolsero secondo la legge, vennero eletti quattro nazionalisti slavi ed un comunista e nessun nazionalista italiano (Interruzioni a destra).
Ai signori della destra rispondo che sono orgoglioso d’aver avuto per la lista del mio partito il voto anche di operai sloveni; mi vergognerei invece di aver avuto il voto dei borghesi. Oltre 4.000 operai sloveni hanno votato per la lista comunista; ma questa ha avuto tale plebiscito nella parte italiana (Friuli orientale - quasi 7.000 voti) che essa avrebbe avuto un quoziente in qualunque caso (Interruzioni all’estrema destra).
PRESIDENTE. - Facciamo silenzio! Questa è diventata una cosa intollerabile! (Benissimo!)
TUNTAR. - A Trieste furono esclusi dalle liste circa ottomila operai e, non paghi di ciò, fascisti e guardie regie strapparono, con le rivoltelle spianate, la mattina dell’atto elettorale agli operai dei villaggi del circondario, scontrini e schede. Così hanno vinto! (Interruzioni).
In Istria, quando venivano fatte le elezioni sotto l’Austria, erano eletti a suffragio universale tre nazionali slavi, due nazionali italiani ed un clericale italiano. In queste elezioni furono eletti, dopo scacciati maestri e comunisti slavi dalle loro sedi ed abitazioni, cinque nazionali italiani: e badate che in due collegi italiani entravano in ballottaggio candidati slavi, perché tutti sanno che l’Istria è abitata dal 62 per cento di slavi e dal 38 per cento di italiani (Interruzioni).
Una parola debbo dire all’onorevole Baratono. Egli, parlando delle elezioni a Trieste, ha detto che se i socialisti furono sconfitti, ciò si deve alla politica del Governo italiano, per cui l’Italia fu odiata a Trieste; il che vorrebbe dire che per questa ragione unicamente gli elettori operai votarono per i comunisti. È questa una insinuazione che respingo a nome del proletariato di Trieste e che ci venne fatta anche a proposito della votazione della Venezia Giulia al congresso di Livorno.
Domando perché i tedeschi della conca del Tarvis hanno votato presso che ad unanimità per i socialisti. Hanno votato non perché tedeschi, ma perché socialisti; invece secondo l’onorevole Baratono e l’Avanti!, gli operai slavi hanno votato per i comunisti, non perché comunisti, ma perché slavi (Interruzioni).
VELLA. - Non ha capito niente! (Commenti).
TUNTAR. - Ho capito benissimo. Il partito socialista italiano ha attirato i socialisti tedeschi del Tirolo meridionale nel suo seno, dopo che esso fu escluso dalla Terza Internazionale (Interruzioni all’estrema sinistra - Rumori a destra).
PRESIDENTE, rivolto a destra. - Vogliono entrare anche in questa questione? (Ilarità).
TUNTAR. - l’on. Scek nel suo discorso, differenziandosi dall’onorevole Wilfan, che rappresenta la corrente borghese nazionalista intransigente, ha auspicato l’affratellamento delle due nazioni che convivono nella Venezia Giulia.
SICILIANI. - Una sola nazione (Rumori all’estrema sinistra).
La classe sopra le nazioni
TUNTAR. - Questi appelli alla solidarietà e alla fratellanza, questi voli lirici provenienti dai banchi nazionali, non devono illuderci sulla realtà della situazione: e la situazione è questa come diceva benissimo il mio amico e compagno Graziadei (Rumori a destra) che ogni borghesia tende a sopraffare le classi proletarie all’interno e i popoli minori all’estero.
Come la borghesia capitalistica italiana, raggiunto, anzi sorpassato il suo confine etnico e geografico, tende ora alla conquista di paesi finitimi abitati per il 95 per cento da un popolo d’altra stirpe, così se la Serbia si fosse piazzata all’Isonzo, avrebbe a sua volta spinto le sue mire ben oltre, verso la pianura friulana e veneta (Applausi all’estrema sinistra - Rumori a destra).
Il problema nazionale nella Venezia Giulia non si risolve con lo spostamento dei confini; esso non poteva venir risolto dalla guerra, perché gli attriti fra i popoli commisti l’un l’altro non si possono risolvere con lo spostamento di confini, ma con la fratellanza, anzi con la fusione delle stirpi, di cui sarà artefice solo il proletariato. A questo fine è diretta la nostra nobile missione alla quale abbiamo sempre tenuto fede (Approvazioni all’estrema sinistra - Rumori a destra).
I capitalisti italiani e slavi tenderanno ad acuire, anche per il loro interesse di classe, sempre più gli antagonismi nazionali; ma io confido che il proletariato delle due stirpi saprà sventare tutti i loro piani fratricidi, forte della sua incrollabile fede comunista.
Da questi banchi mando a quel proletariato un saluto fraterno e solidale con la promessa che non verremo mai meno, neppure in avvenire, ai nostri principi cui abbiamo votato e dato tutti gli anni della nostra gioventù e della nostra maturità (Rumori a destra).
I fascisti potranno, con l’aiuto degli organi governativi, distruggere tutte le Camere del Lavoro, tutti i nostri istituti di cultura, tutti i nostri Circoli; potranno sopprimere anche alcuni di noi, ma non potranno stroncare la fede immarcescibile (Commenti) da cui è animato il proletariato della Venezia Giulia (Rumori a destra - Proteste dell’estrema sinistra verso destra). Questo proletariato combatterà, indomito, in unione ai suoi compagni di tutta Italia, fino al giorno in cui, sulle vette altissime delle Alpi Giulie, esso innalzerà la rossa bandiera dei Soviets! (Applausi all’estrema sinistra - Rumori a destra - Vivi apostrofi fra la destra e l’estrema sinistra).