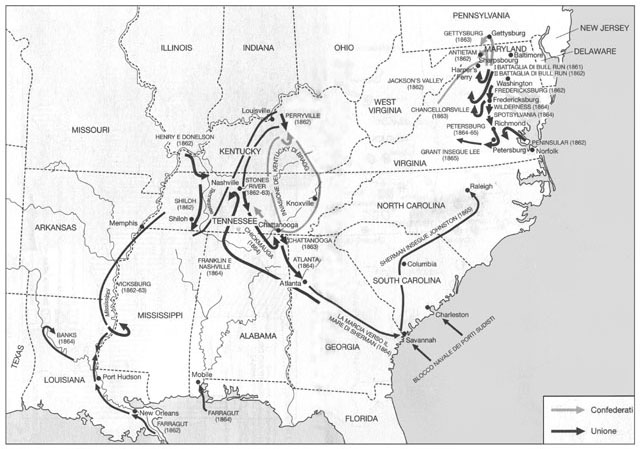
|
|||||
|
|||||
|
Classe e Partito
di fronte all’imperialismo
(53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58).
Si tratta di rappresentare in modo credibile, veritiero, al di là della fraseologia, quale la reale, attuale condizione della classe.
Nessuno più di noi considera il livello politico come centrale, ma alla condizione che si ricordi che sotto la sovrastruttura politica sta l’economia, le forze, gli interessi, secondo il gioco delle contraddizioni tipiche del modo di produzione capitalistico. Non è forse una delle aberrazioni più evidenti del terrorismo di qualsiasi colore l’illusione di procedere a colpi di volontà che educherebbe, plasmerebbe, e così via? Noi abbiamo sempre detto e perfino codificato che senza la presenza e la forza di potenti organizzazioni operaie di difesa economica non sono pensabili iniziative politiche reali.
Nella fase imperialistica del Capitale l’atteggiamento corretto è stato quello di combattere e smentire l’illusione tipicamente opportunista di fare del Partito, o peggio dei partiti (quando erano legittimamente la condizione del movimento proletario) una “boite à lettres”, cioè un’organizzazione anche “internazionale”, ma soltanto per consultarsi, per trasmettersi informazioni. La grande battaglia della Sinistra, quando l’Internazionale rinacque dalla Prima Guerra imperialistica, fu quella di tagliare ogni ponte con chi non voleva che l’organizzazione si concentrasse a livello mondiale, senza compassione per le ragioni nazionali o settoriali. Al punto che le posizioni “della sinistra” apparvero rigide allo stesso Lenin. Certo che la nostra non voleva essere una testimonianza di “sinistrismo” che non sopporta scavalcamenti, ma piuttosto espressione di determinismo, che non abbiamo da rimangiarci.
Insomma, la nostra versione era che nella fase imperialistica la classe deve attrezzarsi alla scala mondiale, sia sul piano economico sia politico. Da allora la nostra posizione non è cambiata, e la “globalizzazione” ci ha dato ragione. Oggi tutti si dicono favorevoli alla “rete mondiale degli interessi e degli scambi”, compresi quegli opportunisti che ci rimproveravano di non comprendere le ragioni dei fattori nazionali, le deroghe richieste per aderire all’organizzazione mondiale politica del proletariato. Sappiamo ormai che fine hanno fatto; non c’è bisogno di rimarcare che erano già allora in cattiva fede, ed i fatti li hanno messi con le spalle al muro. Hanno dovuto vilmente abiurare, ammettere di essersi non solo sbagliati, ma di aver fatto parte di una consorteria di “criminali politici”!
Non ci occuperemo più di loro, che in questa fase stanno lucidando le ali agli scalcagnati aerei di seconda mano della loro Patria acquisita. Vogliamo invece occuparci delle necessità che incombono sulla classe.
Alla verticalizzazione dei processi imperialistici non corrisponde una centralizzazione progressiva del proletariato, anzi è seguito uno smantellamento sistematico perfino delle forme statizzate di difesa corporativa. Lo squilibrio non potrebbe essere più grande e più grave.
Ciò non toglie che nonostante l’infeudamento degli organismi di difesa economica, già di classe, lo lotta operaia continua e continuerà finche vigerà questo tipo di sistema sociale. Ma noi non possiamo contentarci di questo: non sarà mai sufficiente l’appello ai proletari a combattere sul posto di lavoro, nel tentativo di riorganizzare la classe, di stabilire contatti di solidarietà con chiunque lotti, ed in qualsiasi paese, in questa prospettiva. La classe comporta unità di comando e fini comuni. Senza di questo c’è solo arrembaggio, dispersione, sconfitta.
Allora, se nel fuoco della battaglia il tradimento poté scompaginare la classe che era ancora forte, capace di combattimento, oggi, dopo 80 anni di vicissitudini che hanno visto il proletariato costretto ad una Seconda Guerra micidiale, alla conquista da parte degli apparati statali delle sue organizzazioni, si avrà l’idea delle condizioni proibitive in cui si muove quell’organismo che chiamiamo Partito, ridotto ad un numero di militanti che potrebbero apparire un gruppo di testimoni, o di giapponesi rimasti nella giungla senza sapere che la guerra è finita. Con una non piccola differenza: che siamo consapevoli, che la guerra, la nostra guerra, al momento, è rimandata, che non ci illudiamo di rimettere in moto la storia con parole d’ordine. A suo tempo, certi militanti, si trassero da parte, pensando che, a suo tempo, la Storia ci avrebbe pensato da sé a rimetterli in gioco. Gli scenari sui quali il Partito si trova a muoversi non possono essere inventati.
La ricognizione sul terreno concreto delle condizioni della classe sono sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che l’imperialismo, pur nella necessità di manipolare i teatri sia di guerra sia di pace, non può arbitrariamente sfuggire alle forche caudine della caduta del saggio di profitto. Gli stessi “economisti” di nome, anche se al gioco più o meno scoperto del sistema, hanno riconosciuto, da Samuelson ai “nostri” meno blasonati, come il ricordato Alvi, che «la recessione ha preceduto la guerra terroristica». Come non pensare – e pensare male è diabolico, ma necessario! – che si sia presa la palla al balzo, che si sia in qualche modo provocata, per prevenire, secondo la formula ormai collaudata dell’attacco preventivo?
Anche quando si finge di aver finalmente inquadrato il nuovo nemico, identificato in quello invisibile del terrorismo, il pensiero fisso di governi e Stati borghesi non può che essere quello del risorgere della minaccia e dello spettro comunista. Ci meravigliamo, anzi, che non si sia pensato a “combutte”... come si è sempre fatto! Certamente non è facile cercare legami tra la rivoluzione comunista e la Ummah islamica... ma sono capaci di tutto!
La guerra, sia quella di Corea, sia del Vietnam, sia quella contro l’Irak, ha puntualmente trovato un proletariato ridotto a combattere le battaglie per la sua difesa all’interno di organizzazioni passate la nemico. Nelle fasi in cui ciascuna borghesia si arma per combattere un nemico esterno, la sua macchina statale stringe nuove alleanze per fiaccare la classe. La sua funzione di fondo è questa. La peggiore delle condizioni perché il proletariato possa fare esperienza di combattimento per i propri interessi.
Del resto il passaggio di certi esponenti del movimento operaio dalla lotta internazionale alla mobilitazione nazionale segnò la nascita del fascismo. Da allora il modello non è più stato superato. Abbiamo sempre sostenuto che l’attitudine del proletariato a scendere sul terreno della “produzione nazionale” per far forte lo Stato, è equivalente alla cattura da parte del nemico. Non ci siamo lasciati ingannare dal “ritorno alla democrazia” dopo il Secondo conflitto mondiale; il fascismo aveva perduto la battaglia formale, ma non quella sostanziale, nel suo prezioso servizio al Capitale. Poiché nuove organizzazioni proletarie, sulle macerie di questa sconfitta, non possono essere evocate dalla predicazione, il problema rimane quello della valutazione dei margini di manovra che il capitalismo ha in rapporto alle briciole da dividere e da far cadere dal suo banchetto.
Certo, ogni volta che l’imperialismo scatena la guerra, si determinano nuove spartizioni, non solo territoriali ma di risorse d’ogni genere; si disegnano nuovi assetti che esaltano il capo cordata dell’alleanza e della competizione insieme. Il punto in cui ci troviamo vede gli USA nella necessità di rompere gli indugi di fronte ad un calo del tasso di profitto medio veramente preoccupante, nonostante la tanto decantata capacità di “innovazione tecnologica”.
In queste condizioni, il proletariato è costretto ad arretrare sempre più le sue linee difensive, a scala non soltanto regionale ma a volte miopemente, o forzatamente, locale, aziendale, e anche meno. La minaccia della crisi, continuamente incombente, aumenta la competizione operaia, il sospetto nei confronti di “fratelli” sentiti come nemici. Nonostante tutto, però, la classe statistica esiste, e nessuna bacchetta magica borghese può renderla ininfluente. Se è vero che il lavoro pesa sempre più su una base rarefatta di proletari, mentre una schiera sempre più vasta viene messa fuori gioco, ad aumentare la massa dei senza lavoro, oppure di quelli che devono accontentarsi di lavoro ultra precario, ciò significa che la “società dei servizi” ha dovuto ammettere di non essere affatto la soluzione di tutti i mali. In America managers che avevano toccato col dito il successo ed i dollari, chiedono un posto pubblico alle poste, nonostante il pericolo... dell’antrace!
I grandi riassetti mondiali nel mercato delle risorse e del lavoro saranno determinanti nel mettere alla prova la riorganizzazione della classe. Questi schieramenti di forze non sono manovrabili da qualche mano volontaria, ma semmai ed ampiamente da quella invisibile della lotta di classe, dalla necessità. Nella storia che si è svolta fino ad oggi, abbiamo la prova che i grandi momenti degli schieramenti di classe non sono stati i gesti plateali o volontaristici, quanto le necessità che hanno comportato non solo le organizzazioni di resistenza, ma anche la formazione dei partiti operai, fino alla selezione del Partito unico Internazionale, con tutti gli alti e bassi di questo processo. Noi abbiamo decifrato questa realtà, e individuato nel Partito la sola forza cosciente in grado di non perdere di vista metodo e bussola di orientamento. Se ciò sembra poco, si dia uno sguardo a quelle forze che avevano sbandierato “programmi alternativi”: sono finite tutte nella logica del Capitale, ne sono oggi il miserabile puntello, diventate i nemici più agguerriti del proletariato, come sempre avviene con i neofiti d’un nuovo verbo.
Ciò ci invita a non illuderci, ma anche a non perdere di vista i compiti fondamentali, che non sono quelli di dichiarare guerra senza esercito, con uno sparuto gruppo di militanti che si proporrebbe come “generali”. Noi stiamo alla lettura realistica e dialettica della situazione. L’economia di guerra, lo sappiamo, ha il potere di stringere i “produttori” intorno al Capitale con le minacce esplicite dello scegliere il “campo”, oppure quello di esaltarne la potenzialità di ribellione: ma questi due poli non sono meccanici. Né gli appelli della borghesia e la violenza della sua macchina statale hanno il potere di legare al suo carro la classe, né il Partito come suo organo quello di indirizzarla al compimento dei suoi fini storici: perché si realizzi la seconda opzione, che è quella vitale che ci interessa, è necessario che la classe non sia in ginocchio, ma combattiva e combattente. Nell’esperienza del passato troviamo lezioni a non finire. Durante il Primo conflitto imperialistico, nonostante che le correnti di sinistra si dimostrassero coerenti senza mai piegarsi all’opportunismo, anche quello meno destro (che in Italia si risolse nella formula sibillina ed ambigua “né aderire né sabotare”), la formazione esplicita d’un centro mondiale fu tardiva, seppur giusta e vigorosa.
Il proletariato in quanto classe statistica non avrebbe mai potuto da sé tentare di volgere la guerra tra Stati in rivoluzione, senza l’Internazionale. È quello che s’illudevano, o illudevano, di fare gli opportunisti, che con quest’atteggiamento prestarono il fianco alle pressioni degli Stati, fino al punto di rimandare la rivoluzione a guerra finita. Nel Secondo conflitto, ancora più fetido, si ebbe la prova che lo stesso processo controrivoluzionario non poteva essere rovesciato soltanto perché era chiaro alla nostra corrente.
Mai abbiamo pensato di prescindere dalle forze in campo e dal loro storico orientamento. Ciò ammonisce, anche per il presente, a non sottovalutare il fatto che per noi forza non significa una realtà contingente, ma sempre proveniente da lontano e capace di mirare lontano. Per questo battiamo da decenni il tasto dell’organizzazione difensiva puramente operaia e classista, pena l’inevitabile destino di subire gli eventi, per quanto negativi o positivi possano manifestarsi. Nell’economia di guerra si esaltano anzi o i peggiori difetti o i migliori pregi; non esistono vie di mezzo sulle quali far leva. È evidente allora come solo chi ha saputo lavorare preventivamente nella direzione giusta avrà il sopravvento.
La borghesia, in ciascun paese, ha dalla parte sua il vantaggio d’aver a disposizione la macchina statale; il proletariato che non può rinunciare a “farsi Stato”, manca di questo mezzo necessario. La classe oggi è dilaniata da un’infinità di correnti che praticano e teorizzano più o meno lucidamente l’anarcoidismo, l’illusione che si possa emancipare senza gli strumenti necessari.
In queste condizioni svantaggiate, non c’è da illudersi che possa risalire la china a buon mercato. Chiunque lo pensi e lo diffonda si assume gravi responsabilità, oppure rinuncia per sempre al suo progetto. Quello che ha fatto ignominiosamente l’opportunismo storico, che senza mezzi termini ha dichiarato forfait dopo aver perseguitato per decenni i veri rivoluzionari.
Poiché le prediche non fanno la storia, non rimane che indicare alla classe le sue prospettive, non mancando di sottolineare ogni volta compiti e lotte da svolgere. Durante la guerra, che già prende la piega d’un conflitto di lungo periodo, e che comporterà il risorgere di protezionismi e illusioni difensive, l’imperialismo sta mostrando la sua faccia: con una celerità impressionante passa dalla teoria del libero mercato a tutti i costi, alla riscoperta dell’intervento statale, della direzione centralizzata di azione militare ed economica.
Non ci si deve più meravigliare di niente: chi dà o ha dato fiducia a politicanti rotti a tutte le intemperie si trova alla mercè del loro camaleontismo, oggi inteso come valore, abilità di manovra, di fronte alla quale la coerenza delle posizioni è dogmatismo, dottrinarismo, staticità inconcludente.
Di “nuovo” c’è che una guerra definita “terroristica” impedisce la polarizzazione delle forze, tende a mobilitare in senso psicologico, terrorizzando e ricattando a sua volta, come da sempre fa il sistema del Capitale. Nei posti di lavoro – è bene che i proletari se ne ricordino – ogni atto di insubordinazione e di indisciplina verrà visto come disfattismo, antipatriottismo. Li conosciamo questi termini e questi comportamenti a menadito: ma la classe si trova a dover ripetere la lezione. D’altronde ripetere nella nostra versione non significa biascicare giaculatorie, ma riproporre la domanda, letteralmente, riproporre la questione.
Il cristianesimo occidentale più avanzato, quello di matrice protestante, ha affermato che la pace non è possibile senza la libertà di coscienza, e ha prodotto le libertà politiche conquistate dalla rivoluzione francese. Queste non saranno seguite dalla libertà sociale, dal bisogno, un miraggio, in questo sistema di vita, per miliardi esseri umani. La nostra ottica, da riproporre nell’epoca della globalizzazione conclamata, è questa: il punto di vista a cui ci riferiamo non è ristretto ai ceti proletari aristocratici né alle fortezze metropolitane, ma comprende i senza lavoro, i manovali, i reclutati tra i paria, tutti sotto la direzione d’un organo politico che sappia vedere, dialetticamente, a livello planetario.
È un’utopia, un miraggio a sua volta? Ebbene, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciarvi. Se lo facessimo dovremmo accodarci al presunto “riformismo” (almeno oggi non parla di “socialismo”), non di emancipazione della classe proletaria ma al massimo di accomodamento della smodata società senza regole del turbocapitalismo. Non ci accodiamo non tanto per amor di Tesi, ma perché la realtà mostra in modo drammatico che i rapporti sociali non solo non migliorano, ma stanno toccando, per ammissione degli stessi seguaci del sistema, il punto più basso di “socialità”, d’attenzione per le condizioni dei diseredati. Così, schizofrenicamente, mentre da una parte si ammette, dall’altra, in nome delle ragioni del Capitale, si accelera la divaricazione tra chi accumula e chi si vede ogni giorno ridurre le possibilità, non diciamo di miglioramento, ma di sopravvivenza. Stiamo ai dati mondiali, che parlano di circa due miliardi di tagliati fuori dal sopralavoro, dalla fame, dalle malattie.
Non abbiamo così nulla da cambiare al nostro programma, che dall’Ottocento è globale e internazionale. Così, come il Partito fu ricostituito nel 1945 come Comunista Internazionale, senza altri termini posticci, la nostra funzione fu e rimane quella di ribadire i punti fondamentali del programma stesso. Non è nuovo il nostro storico atteggiamento, per dirla con Marx, “a contrastare l’opinione corrente del proletariato”, contro ogni forma di demagogia e di codismo. D’altronde, come potremmo stare alla coda delle cosiddette masse quando, in particolare, sono bloccate dalla marea opposta? Il fatto è che noi non santifichiamo né la parola proletariato, né tanto meno quella cara ai democratici, e cioè di popolo. Come potremmo mettere, specie oggi, la retorica rivoluzionaria al di sopra dello sviluppo rivoluzionario?
Ecco il punto. Ma lo sviluppo rivoluzionario ormai è senza possibilità, senza futuro. Questo hanno detto gli opportunisti, mettendo una pietra tombale su tutta la loro vergognosa storia. Ed allora, diciamo noi, o ci sarà ripresa della classe, discipline nuove determinate da necessarie lotte, oppure avremo la “rovina di tutte le classi”. Il ciclo delle fortune imperialistiche, fondate su massacri generali, sembra chiuso. La preoccupazione dei capi cordata è stata confessata esplicitamente prima ancora del massacro delle “torri”; non è possibile rovesciare la fetida stagnazione senza ricorso ad una guerra che sia lunga. Se il teatro delle operazioni si dimostrerà asfittico, ci sarà sempre la possibilità di allargarlo ad almeno 50 “Stati canaglia”, covi potenziali del nemico invisibile.
Se sarà necessario la guerra non sarà di 10 anni, come quella classica di Troia, ma il cavallo di Troia per un conflitto senza fine e senza tregua. Non è possibile che la classe aspetti di riorganizzarsi quando la guerra sarà finita, come hanno sempre pensato e promesso le correnti opportuniste. Durante e contro la guerra ciò deve avvenire, non con gesti eclatanti, ma con la resistenza alla pressione del Capitale, sul posto di lavoro, nel collegare per quanto possibile i conati di lotta e di organizzazione. Ci sono esempi di battaglie che si svolgono in varie aree del mondo, di proletari che si trovano a dover resistere.
Ma la grancassa bellica ha tutt’altro da pensare e da “comunicare”. Interi Stati rischiano di precipitare nella bancarotta. Al loro interno le frazioni operaie sono chiuse nei loro ambiti locali e regionali: altro che globalizzazione! Il liberismo – lo abbiamo detto fino alla nausea – non è che l’altra faccia del protezionismo, che convive insieme, e non alternativamente. Le due globalizzazioni, quella imperialistica e quella operaia non si rispecchiano meccanicamente. Anzi, quando il liberismo celebra i suoi fasti, significa che comprime la base proletaria come non mai, vanifica le sue organizzazioni, esporta la competizione al suo interno, determina una lotta al coltello tra proletario e proletario, di razza, religione, credo politico. Come liberismo politico e liberismo economico non si corrispondono automaticamente, così libertà di movimento delle merci e capacità organizzativa operaia, solidale, politica, non si scambiano facilmente. Altrimenti in che cosa consisterebbero le contraddizioni del modo capitalistico di produzione e di distribuzione? Di questo è necessario tener conto se vogliamo avere una rappresentazione non retorica, ma credibile ed oggettiva della condizione della classe. La flotta proletaria ha bisogno come non mai di ritrovare la sua navigazione, che se non sarà mai facile e pacifica, dovrà però almeno avere un senso, una direzione.
Il riformismo impossibile dei “democratici” viaggia lungo le coste mefitiche del Capitale e approda al primo porto che gli conviene. Altro che colonne d’Ercole da oltrepassare, che invece ci competono, da sempre! La classe non può essere imbarcata da qualche nuovo Partito, o da coalizioni strampalate che si richiamino genericamente al “progresso”, a nuove regole da proporre al capitalismo selvaggio. La storia del Novecento ha selezionato una forma Partito alla scala mondiale, non soltanto come prospettiva organizzativa, ma come programma da realizzare, contro altri secoli di lotte e di tragedie. Non esistono alternative.
Capitoli esposti alle Riunioni del settembre 2003 e del maggio
2004.
– (I):
– (II): Una guerra di lunga durata - L’anno della
svolta - La “marcia verso il mare” - L’emancipazione degli schiavi
- Il proletariato bianco - Le conseguenze della guerra - La guerra per
il Nord - L’atteggiamento di Marx e di Engels - La “Ricostruzione”
e il suo fallimento - La mancata riforma agraria - La “Ricostruzione”
secondo i Radicali - La “Redenzione” - A mò di conclusione.
Una guerra di lunga durata
Dopo il bombardamento di Fort Sumter, che si può considerare il primo punto a vantaggio del Nord in quanto fece apparire i sudisti come gli aggressori e fece tacere tutti quelli che al Nord erano contro la guerra, si corse allegramente alle armi, certi, da entrambe le parti, per diverse ragioni, che la guerra sarebbe finita presto.
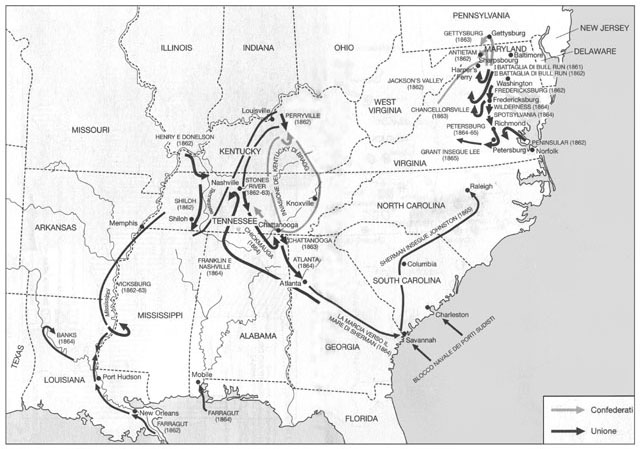 |
Il reclutamento si basò inizialmente sui volontari, che accorrevano numerosi in entrambi i campi, ma già nel secondo anno di guerra si dovette cominciare a richiamare i coscritti, soprattutto nel Sud. Nel Nord il sistema divenne più tassativo solo nel 1863.
Una risoluzione immediata della guerra si poteva avere solo nell’Est, con la caduta di una delle due capitali; fu quindi su quel teatro che si appuntò l’attenzione in quell’estate del 1861. Nel Nord l’opinione pubblica richiedeva a gran voce una vittoria risolutiva, anche perché gran parte delle truppe era arruolata a termine, per un periodo di tre mesi (queste le previsioni che a Washington si facevano). “A Richmond!” era il grido di guerra di politici e pennivendoli, di quelli che pensavano che ci sarebbero andati in carrozza o in treno, e non marciando o strisciando nelle trincee. Ma avrebbero dovuto aspettare qualche anno: la battaglia che si svolse il 12 luglio 1861 a Bull Run, in Virginia, fu una sonora sconfitta per il Nord, anche se, rispetto a quelle che sarebbero seguite, fu poco più di una scaramuccia.
I nordisti si trincerarono nella vicina, e fortificata, Washington, a ripensare sul da farsi. In ogni modo per Lincoln la sconfitta si risolse in una vittoria, in quanto confermò il Congresso nella sua determinazione a proseguire fino alla vittoria; a Lincoln fu concesso di emettere un prestito per 400 milioni di dollari (erano una cifra enorme), e di arruolare 500.000 volontari per 3 anni o per tutta la durata della guerra. Al di là dei partiti, delle fronde, dei gruppi di interesse, questo era il modo che la borghesia aveva per esprimere la sua determinazione unitaria a raggiungere i suoi obbiettivi economici e politici.
Il resto dell’anno scorse senza battaglie importanti, anche se prese di contatto tra gli opposti eserciti si ebbero, oltre che in Virginia, anche nel Missouri, in West Virginia e nella Penisola a sud-est di Richmond. Il Nord, inoltre, utilizzò subito la sua schiacciante superiorità navale per imporre il blocco e per conquistare un certo numero di forti costieri e isole.
Cosa si doveva fare? Per i sudisti la decisione era relativamente facile: difendersi dagli attacchi, in attesa che le sconfitte, il logoramento e le pressioni delle potenze straniere convincessero l’opinione pubblica del Nord che non valeva la pena di continuare la guerra. Al Nord, che si era dato il compito di sconfiggere un nemico che occupava una superficie territoriale sterminata e che contava una abbondante popolazione, toccava il compito di attaccare. Ma dove?
Il piano di Winfield Scott, il generale in capo delle forze nordiste, prevedeva una guerra di almeno tre anni, e forti perdite, per sottomettere il Sud. Oltre al blocco navale, un obbiettivo primario per lui era il corso del Mississippi, che in mano nordista avrebbe separato il Sud dai territori dell’Ovest. In tal modo il Sud sarebbe lentamente stato strangolato dall’isolamento e dalla mancanza di rifornimenti, e dalla pressione militare da tutte le direzioni. Il piano, per queste sue caratteristiche, fu chiamato “Piano Anaconda” e, pur se con punti deboli, era migliore di altri successivi. Lincoln, dopo Bull Run, non intendeva modificarlo gran che, ma il successivo affidamento del comando a McClellan dovette far accettare un cambio di indirizzo. McClellan vedeva l’Est come l’unico punto su cui fare pressione per schiacciare la ribellione, mentre l’Ovest diventava un teatro molto secondario. E su questa base condusse la sua campagna successiva. In realtà Richmond aveva un valore psicologico, ma non strategico: persa questa città, i sudisti potevano ritirarsi in un retroterra sconfinato, dal quale ripartire in ogni momento e in ogni direzione.
In ogni modo la guerra continuava: nell’Ovest i sudisti occuparono una città del Kentucky, Columbus, e questo portò all’abbandono della neutralità di questo Stato che si schierò decisamente con il Nord. Il quale contrattaccò nella stessa zona con una serie di attacchi a città e a posizioni fortificate, con la conseguenza dell’abbandono dello Stato da parte dei sudisti nel febbraio 1862. Principale artefice di questa avanzata fu il generale Grant, uno che avrebbe fatto carriera. Il comandante in capo all’Ovest era Halleck, ma la storia successiva fece in modo che la stella militare dell’epoca fosse proprio Grant.
Questa campagna è ben descritta da Marx in un articolo del 27 marzo, che riporta anche la sua opinione sulla strategia generale della guerra; un comunista seduto in una biblioteca di Londra vedeva più chiaro dei generali che impettiti percorrevano i campi di battaglia e avevano tutte le informazioni disponibili: «Negli Stati popolosi e più o meno centralizzati, vi è sempre un punto che rappresenta il cuore della resistenza nazionale; questa si spezza se quello cade in mano al nemico. Parigi offre un magnifico esempio al riguardo. Gli Stati schiavisti tuttavia non possiedono tale centro; sono scarsamente popolati, con poche grandi città, e quelle poche situate tutte lungo la costa. Quindi ci si chiede: esiste malgrado ciò un centro di gravità militare, la cui occupazione spezzerà la spina dorsale della resistenza, oppure quegli Stati sono come era ancora la Russia nel 1812, cioè non si possono conquistare se non occupando ogni villaggio, ogni podere, insomma, tutta la periferia? Diamo uno sguardo alla formazione geografica della terra dei secessionisti, con la sua lunga striscia di costa sia sull’oceano Atlantico sia sul golfo del Messico. Finché i confederati tenevano il Kentucky e il Tennessee, il tutto formava una grande massa compatta. La perdita di tutti e due quegli Stati ha aperto un immenso squarcio nel loro territorio, separando a mo’ di cuneo gli Stati dell’oceano Atlantico settentrionale dagli stati del golfo del Messico. La linea diretta dalla Virginia e le due Caroline al Texas, Luisiana, Mississippi e anche parte dell’Alabama passa attraverso il Tennessee, che ora è occupato dagli unionisti. L’unica strada che dopo la conquista completa del Tennessee da parte degli unionisti unisce ancora i due gruppi di Stati schiavisti passa attraverso la Georgia. Questo dimostra che la Georgia è la chiave per arrivare alla terra dei secessionisti. Con la perdita della Georgia la Confederazione sarebbe tagliata in due parti prive di qualsiasi collegamento. Una riconquista della Georgia da parte dei secessionisti sarebbe addirittura inconcepibile, perché le forze militari degli unionisti sarebbero radunate in una posizione centrale, mentre i loro avversari, divisi in due campi, avrebbero forze appena sufficienti per sferrare un attacco coordinato.
«La conquista di tutta la Georgia, con la costa della Florida,
sarebbe
indispensabile per una tale operazione? Niente affatto. In una terra
dove
le comunicazioni fra posti lontani, dipendono più dalle ferrovie che
dalle
strade, è sufficiente occupare le ferrovie. La linea ferroviaria più
meridionale fra gli Stati del golfo del Messico e la costa atlantica
passa
per Macon e Gordon, nei pressi di Milledgeville.
«L’occupazione di questi due punti, di conseguenza, taglierebbe
in due la terra dei secessionisti e metterebbe gli unionisti in grado
di
sconfiggere le due parti una dopo l’altra. Ne consegue anche che senza
il possesso del Tennessee non può esistere una repubblica sudista.
Senza
il Tennessee il punto vitale della Georgia dista solo otto o dieci
giorni
di marcia dalla frontiera; il Nord terrebbe costantemente le mani alla
gola del Sud, e alla minima pressione il Sud dovrebbe cedere o
riprendere
a combattere per la sopravvivenza, in circostanze in cui una sola
sconfitta
eliminerebbe ogni prospettiva di successo.
«Dalle precedenti considerazioni si deduce quanto segue:
«Il Potomac non è la posizione più importante del teatro
di operazioni. La presa di Richmond e l’avanzata dell’armata del
Potomac
verso sud – difficile per via dei molti fiumiciattoli che tagliano la
linea di marcia – potrebbero dare una spinta psicologica formidabile,
ma da un punto di vista puramente militare non deciderebbero un bel
nulla.
«Le sorti della campagna dipendono dall’esercito del Kentucky, che
ora è nel Tennessee. Da una parte questo esercito è vicinissimo ai
punti
nevralgici, dall’altra occupa un territorio senza il quale la
secessione
non può sopravvivere. Di conseguenza questa armata dovrebbe essere
rafforzata
a spese di tutte le altre, sacrificando tutte le operazioni minori
(...)
Altrimenti, se dovesse esser messo in atto il piano dell’Anaconda,
malgrado
tutti i successi nei singoli scontri, e anche sul Potomac, la guerra
potrebbe
prolungarsi all’infinito, mentre le difficoltà finanziarie e le
complicazioni
diplomatiche potrebbero dare al Sud maggiore libertà di manovra».
Vedremo che sarà proprio questa la strada della vittoria per il Nord, anche se questa strategia sarà applicata solo parzialmente e con due anni di ritardo. Ma andiamo con ordine.
Nella primavera del 1862 la situazione dei Confederati appariva tragica. Vinte alcune battaglie, i sudisti avevano trascorso l’inverno crogiolandosi nella memoria delle vittorie; al Nord invece si era passato l’inverno di non dichiarata tregua (l’ultimo) a formare reggimenti, a fondere cannoni, a organizzare la logistica necessaria a eserciti che contavano i loro uomini a decine, se non centinaia di migliaia.
L’offensiva iniziata nel gennaio nel Kentucky aveva portato alla “liberazione” dello Stato. La marcia nordista era continuata verso Sud, e il 25 febbraio cadeva Nashville, la capitale del Tennessee. Altre vittorie si ebbero anche nel trans-Mississippi, in Arkansas e in New Mexico; si trattava di un teatro minore, inospitale e poco popolato, ove operavano armate di piccole dimensioni, ma importante per il Sud per gli approvvigionamenti.
La fortuna sembrò cambiare quando, dopo altre importanti conquiste costiere da parte dei nordisti, nella baia di Norfolk, in mano sudista ma chiusa dalla flotta da guerra del Nord, apparve una nuova e potentissima arma: una corazzata. Si trattava della Virginia, una nave di nuova concezione, impenetrabile alle cannonate dei pezzi allora disponibili e che quindi poteva avvicinarsi alle navi da guerra e affondarle in tutta comodità. Sarebbe stato un vantaggio capace di far saltare il blocco navale dei nordisti. Senonché anche loro avevano messo in cantiere qualcosa di simile, anzi, forse di meglio, il Monitor, che proprio il giorno dopo l’attacco della Virginia raggiunse la baia di Norfolk, dando luogo a uno scontro furibondo, ma il cui risultato fu che tutto restava come prima.
Ma nell’Ovest la fortuna continuava a mancare per il Sud. Un tentativo di contrattacco in Tennessee determinò una sanguinosa battaglia a Pittsburgh Landing. Grant venne attaccato mentre attendeva il resto della sua armata, ma la quasi disfatta si trasformò in una netta vittoria, e i sudisti si dovettero ritirare a Sud dei confini dello Stato del Mississippi.
Intanto un’altra offensiva era quella tesa alla conquista del grande fiume, per lo più ad opera delle flotta fluviale appoggiata da terra dalle fanterie. Piano piano i forti e le città sul fiume sono conquistati; quando, per evitare di essere aggirati, i sudisti devono abbandonare Memphis, le navi nordiste scendono a Sud per centinaia di miglia. Memphis cade il 6 giugno. Ma già il 25 aprile era caduta una città ben più importante, New Orleans, sul delta del fiume, grazie ad un’azione estremamente audace della squadra navale dell’ammiraglio Farragut. I nordisti erano poi risaliti verso Nord, per fermarsi in corrispondenza di una fortificazione apparentemente insuperabile, Port Hudson. La flotta fluviale che in giugno discende il corso del Mississippi, invece, deve fermarsi circa duecento miglia in linea d’aria più a nord, a Vicksburg, dove i sudisti hanno approntato difese formidabili. Non potevano far altro, visto che la perdita del padre dei fiumi avrebbe significato il distacco dagli Stati al di là del fiume, con le conseguenze che abbiamo descritto. Così, per ora, per i sudisti resta aperta una porta di comunicazione con l’Ovest, un collegamento che non si può per nessuna ragione perdere.
Ad Est il comando in capo delle truppe nordiste, prima dell’armata del Potomac e poi di tutto l’esercito del Nord, è affidato a McClellan, un grigio e presuntuoso organizzatore che si dedica a costruire un esercito enorme e quindi, si pensa, invincibile. Ma il generale appare restìo ad impiegarlo e lo schiera solo quando riceve un esplicito ordine da Lincoln. Fedele alla sua visione di un attacco concentrato su Richmond, McClellan concepisce un piano di attacco che prevede uno sbarco a sud-est di Richmond su una penisola delimitata dagli estuari dei fiumi York e James. Da lì intende muovere il suo enorme esercito verso Richmond, da espugnare grazie a un assedio con tutte le regole. Per fortuna dei sudisti, McClellan non aveva mai fretta di combattere e il suo esercito si muoveva molto lentamente. Infatti, appena sbarcati, i nordisti, invece di gettarsi a tappe forzate su Richmond, preferiscono assediare Yorktown. L’approntamento delle batterie per l’investimento della città richiede un mese, ma naturalmente il giorno prima dell’inizio dei bombardamenti la guarnigione sudista alla chetichella abbandona la città.
Il ritardo consente a Lee, il nuovo comandante in capo sudista, di raccogliere un esercito che, se non pari a quello federale, può opporvisi con efficacia. Così la caduta di Yorktown e del porto di Norfolk, di per sé positiva, è controbilanciata dagli spazi lasciati ai confederati, che con Jackson attaccano in West Virginia e minacciano Washington. Truppe federali vengono rispedite a Nord, indebolendo un esercito comunque fortissimo (125.000 uomini dopo il distaccamento al Nord). Ma non sono abbastanza per McClellan, che ha la curiosa propensione ad attribuire al nemico effettivi sempre molto superiori alla realtà. Quindi, attaccato da Lee nella battaglia dei Sette giorni (25 maggio-1 giugno) arretra fino alla testa di ponte; qui McClellan decide di reimbarcare la sua armata, che non ne esce troppo danneggiata, a differenza dei confederati, cui la vittoria costa enormi perdite. Ma Lee ha salvato Richmond, McClellan ha consumato enormi risorse senza concludere niente. Anzi, viene offerto il destro ai sudisti per un contrattacco, che passa per una seconda battaglia di Bull Run e che porta l’esercito di Lee fin nel Maryland. Qui il 17 settembre si ha una battaglia, ad Antietam, senza vincitori né vinti, ma Lee deve ripiegare verso Sud.
Per Marx questo successo dei Federati è estremamente importante, e decide delle sorti della guerra, anche per i suoi effetti sulla battaglia di Perryville (Kentucky) del mese successivo; se i sudisti avessero vinto a Antietam, avrebbero avuto maggiore spinta nel Kentucky. Da lì basta passare il fiume Ohio e si penetra nell’omonimo Stato, e il Nord è spezzato in due. Pur non sapendo come andrà a finire quando scrive, Marx è ben conscio dell’illimitata potenza tecnica ed economica del Nord, ma sa anche che in quel momento non c’è certezza sull’atteggiamento dei Border States, né su quello delle potenze europee: un crollo militare dell’Unione avrebbe potuto anche costringerla a una pace favorevole al Sud. Una specie di rovesciamento della tattica che auspicava per il Nord nell’articolo del 27 marzo.
McClellan è sostituito da Burnside, che tenta di lanciare un attacco su Richmond passando da Fredericksburg, città sul fiume Rappahannock. Ivi Lee schiera il suo esercito, e da posizioni imprendibili i sudisti il 13 dicembre massacrano i soldati dell’Unione, che sono mandati a morire a ondate successive senza speranza di successo (12.000 morti). I nordisti ripiegano, Burnside è licenziato (ma il suo stile da macellaio sarà imitato da tutti i generali che gli succederanno, da entrambe le parti), in Virginia si passa alla guerra di posizione, mentre i sudisti cominciano a pensare che forse possono vincere.
A differenza dell’Est, a Ovest, pur se con qualche ripiegamento, l’avanzata delle truppe federali è costante. Halleck è richiamato a Washington per prendere il comando generale, e l’armata dell’Ovest è divisa in 3 tronconi, il che è fattore temporaneo di debolezza finché il comando non è affidato a Grant.
L’avanzata nordista si arresta in Tennessee per un contrattacco
sudista
(battaglia di Chattanooga), che però è presto interrotto e respinto a
Perryville l’8 ottobre, dopo che Grant aveva vinto a sua volta a
Corinth.
Un’ultima sanguinosa battaglia si ha a Stone’s River, nel Tennessee,
e i sudisti fra il 31 dicembre e il 3 gennaio devono di nuovo
abbandonare
lo Stato.
L’anno della svolta
Vicksburg, la fortezza sul fiume, diviene ovviamente un obbiettivo primario, ma richiede ripetute campagne, che per tre volte falliscono per la posizione particolarmente vantaggiosa del caposaldo, alto sulle acque e in mezzo a una zona in gran parte acquitrinosa. Infine Grant, con una manovra di aggiramento rapida e ardita, in quanto rischia di restare isolato in mezzo alle forze nemiche, riesce a porre l’assedio alla città, che capitola il 4 luglio 1863. Poco dopo Port Hudson subisce la stessa sorte; la vittoria, oltre al vantaggio strategico di controllare l’intero corso del Mississippi, frutta ai nordisti ben 36.000 prigionieri.
A Est il comando dell’esercito nordista passa a Hooker, e anche lui riesce ad essere sconfitto da Lee nei pressi di Fredericksburg (Chancellorsville, 2-4 maggio). Ma bisogna ricordare che in queste battaglie non sempre il bilancio dei morti e feriti stava a favore del vincitore; al contrario, talvolta il prezzo della vittoria era un ampio tributo di sangue. Quindi ogni battaglia, salvo qualche eccezione, era più svantaggiosa per i sudisti che per i nordisti, sempre in superiorità numerica e con popolose retrovie. Quando quindi Lee decise di tentare nuovamente l’invasione del Nord, non poteva aspettarsi di avere di fronte un esercito indebolito. E a Gettysburg, in Pennsylvania dall’1 al 3 luglio, si ebbe un ennesimo massacro di fanti ad opera delle artiglierie, in seguito al quale l’armata di Lee, respinta con forti perdite, fu costretta ad abbandonare il campo e a rientrare in Virginia, dalla quale non sarebbe più uscita.
Anche a Ovest l’anno 1863 si concluse a favore del Nord, dopo l’eclatante successo di Vicksburg. Una imponente offensiva nordista arrivò a occupare Chattanooga, importante città al confine con la Georgia, ma poco più a sud, sul Chickamauga i sudisti attendevano Rosencrans e la sua Armata del Cumberland. Lì questa fu sì sconfitta, ma come spesso succedeva, non annientata né dispersa, anche se la battaglia (19-20 settembre) fu estremamente cruenta, una delle più sanguinose della guerra con 12.000 i morti e feriti per il Nord, 19.000 per il Sud, circa il 25% degli effettivi. Rosencrans ripiegò su Chattanooga e vi si rinchiuse.
Prima di fare la fine di Vicksburg, però, i Federati furono soccorsi da 2 eserciti, sotto la guida diretta di Grant, ormai comandante in capo delle truppe dell’Ovest; dopo uno scontro alle porte della città il 23-25 novembre i sudisti furono costretti a ripiegare a Sud.
Oramai la guerra volge a favore del Nord, ma questo non significa che la sua fine sia vicina. I sudisti possono sempre sperare di resistere nella sterminata fortezza ancora a lungo, e così attendere sinché il Nord si sarà stancato di combattere. Quindi è necessaria una strategia di conquista e, soprattutto, di distruzione dell’esercito nemico, unica vera condizione per la vittoria, viste le dimensioni del retroterra confederato.
Lincoln fa avere a Grant il comando di tutte le forze armate federali, la Luogotenenza Generale, carica che solo Washington aveva ricoperto in precedenza. Il piano di Grant è semplice, ed è quello suggerito da Marx un paio di anni prima: attaccare con un forte esercito dal Tennessee verso la Georgia, raggiungere il mare spezzando la Confederazione in due tronconi, ricongiungersi verso Nord con l’armata del Potomac e costringere i sudisti a battersi con la prospettiva di essere distrutti. Ma Grant non ha letto bene Marx, e continua a privilegiare il fronte virginiano, con il risultato di inchiodare là forze enormi che avrebbero meglio servito altrove. Il Nord è però talmente ricco di tutto, che può permettersi sprechi. In particolare quello di vite umane.
Ad Est l’attacco si svolge su tre direttrici: Valle dello Shenandoah; Centrale (fiume Rapidan); Sud (penisola). Ovviamente la direttrice principale è quella centrale, e il primo scontro si ha a Wilderness il 5-6 maggio 1864; sanguinosissimo, come è ormai la norma, e i nordisti sono fermati. Grant preferisce non insistere e si sposta più a Sud, costringendo Lee a correre per anticiparlo e attestarsi su posizioni vantaggiose, a Spotsylvania, dove si ha un’altro gigantesco macello nei giorni dal 9 al 19. Altro stallo, altro scivolamento più a Sud di Grant; Lee lo affronta a North Anna il 23, ancora su posizioni imprendibili, e ancora Grant si disimpegna verso Sud, avvicinandosi in modo minaccioso a Richmond. Lee si attesta a Cold Harbor, e Grant vi fa confluire tutte le sue forze. Ma anche Lee ha bisogno di tutte le sue forze e, a differenza del 1862, invece di inviare distaccamenti a minacciare le retrovie nordiste deve richiamare a sé tutti i reparti disponibili, anche da altri teatri. È a questo punto che all’Ovest Sherman inizia la sua marcia su Atlanta.
Il 3 giugno Grant attacca, e le sue forze sono respinte (7.000 morti e feriti in un giorno solo) in una battaglia che gli varrà il nuovo nomignolo, abbastanza esplicito, di “butcher”, macellaio; intanto più a Nord, nella valle dello Shenandoah, i nordisti guidati da Sheridan distruggono l’armata sudista che li fronteggiava, e minacciano Richmond di aggiramento, il che costringe Lee a inviargli contro truppe. Grant compie un ultimo balzo, repentino (almeno quanto gli è consentito dalle dimensioni dell’esercito), ancora verso Sud, per investire Petersburg, città a sud di Richmond e che fa parte del suo sistema difensivo (13-18 giugno). Lee, preso di sorpresa, resta inchiodato nella piazzaforte, e per quasi un anno ancora deve difendere la capitale sudista dall’esercito nordista che lentamente ma inesorabilmente chiude la morsa intorno alla città; ma quel che è peggio gli è preclusa la possibilità di compiere quelle manovre che sono state la sua forza negli anni precedenti.
L’unico spazio di manovra resta la valle dello Shenandoah, sguarnita
dai nordisti, che viene risalita dalle truppe del generale Early nel
mese
di luglio, fino ad affacciarsi nel Maryland e minacciare Washington. Ma
è una minaccia che ormai non fa più paura; Early non riesce a fare
quello
che era riuscito nel ‘62 a Jackson, cioè a costringere il Nord ad
inviare
truppe consistenti alla difesa della capitale, indebolendo lo
schieramento
principale di fronte a Richmond. Così Early rientra in Virginia con un
nulla di fatto; continua però con le sue azioni di disturbo, finché
Grant
non incarica Sheridan di dargli la caccia.
La “marcia verso il mare”
Il 4 maggio 1864 iniziano le operazioni di Sherman in Georgia, partendo dalla base di Chattanooga. Di fronte ha l’Armata confederata del Tennessee al comando di Joseph Johnston. La superiorità di forze consente a Sherman di operare continue azioni di aggiramento delle posizioni dove si attestano i confederati; i quali, se non vogliono essere circondati, devono ritirarsi continuamente, o accettare battaglia in condizioni di ovvia inferiorità. Una volta che Sherman attacca una di queste posizioni trincerate viene respinto con perdite; ma poi Johnston deve ritirarsi ancora, e ancora, sino ad Atlanta. Si tratta in fondo di una ripetizione dell’avanzata di Grant a Est: finalmente i federali hanno imparato a sfruttare la loro superiorità in uomini ed equipaggiamento.
Il 17 luglio Johnston è rimpiazzato da Hood, perché al Sud non si è contenti della tattica temporeggiatrice del vecchio generale; grave errore, perché Johnston era riuscito a ritirarsi (altro non si poteva fare) rallentando al massimo l’avanzata dell’esercito dell’Unione, che era avanzato di soli 140 km in due mesi e mezzo. Questo con poco più della metà degli effettivi dei nordisti e senza seriamente intaccare le sue forze, un piccolo capolavoro. Hood invece non esita a dare battaglia davanti Atlanta, e subisce forti perdite. Infine Sherman ricorre di nuovo all’aggiramento da Sud, e Hood deve abbandonare Atlanta, che è occupata dai federali il 2 settembre.
Nel 1864 le vittorie arridono al Nord anche sul mare: Mobile, in Alabama, ultimo grande porto dei meridionali, è preso dalla flotta di Farragut in agosto. Anche verso un’altra spina nel fianco dei federali, la guerra di corsa, le cose si mettono bene: il 19 giugno viene affondata nella Manica, in Europa, la famigerata Alabama; in ottobre la Florida viene abbordata nottetempo mentre è alla fonda nel porto di Bahia, in barba alle convenzioni internazionali. Il Brasile non era la Gran Bretagna, e le convenzioni si rispettano solo quando c’è qualcuno che può punire i trasgressori; della validità di questo assioma abbiamo avuto esempi freschissimi, e proprio da chi comanda nella “terra del libero, casa del coraggioso”.
Intanto in Virginia lo scontro tra le armate di Grant e Lee continua. Bloccato su Richmond e Petersburgh, che non può abbandonare anche se sarebbe la scelta tattica migliore, Lee mantiene una minima possibilità di manovra, con le truppe di Early, nella Valle dello Shenandoah. Ma a chiudere anche questo fronte viene comandato Sheridan, che in agosto organizza l’Armata dello Shenandoah. Gli ordini di Grant sono non solo di distruggere l’esercito nemico, ma anche di devastare la Valle e renderla inutilizzabile per i confederati. E non solo per l’esercito regolare, ma anche per le bande partigiane che, presenti in diversi Stati, sono in quella valle particolarmente attive, comandate da un ufficiale sudista, il colonnello Mosby. Anche questa, di bande partigiane che operano nelle retrovie nel corso della guerra e tengono impegnato un numero molto alto di forze nemiche, è una innovazione abbastanza originale della guerra civile, e che avrà un futuro nelle guerre a venire. Così Sheridan avanza verso Sud, inseguendo i confederati che sconfigge puntualmente grazie a una schiacciante superiorità numerica lungo il corso del fiume.
Non è difficile individuarne il cammino, perché è ovunque segnato da dense colonne di fumo che riempiono l’intera valle. Il generale Sheridan mette così in pratica gli ordini di Grant, di “trasformare la valle in uno squallido deserto”, talché perfino “i corvi recandovisi debbano portarsi dietro le provviste”. Con spietata sistematicità gli unionisti danno alle fiamme i cascinali, le stalle, i mulini; distruggono i raccolti, i fienili, perfino le scorte di legna da ardere accumulata per l’inverno; sequestrano e portano via tutto il bestiame e i negri; arrestano e imprigionano tutti gli uomini fino a cinquant’anni di età. Le case di abitazione dovrebbero essere escluse da questa sorte: in realtà assai spesso, vuoi per rappresaglia contro azioni partigiane, vuoi a iniziativa di singoli soldati ubriachi o saccheggiatori, anch’esse sono date alle fiamme e gli sventurati abitanti sono lasciati senza tetto, a ingrossare le file dei miseri fuggiaschi che le avanguardie federali si spingono avanti lungo le strade della Valle, un tempo fertile ora ridotta a un deserto.
All’avvicinarsi dell’autunno Sheridan si ritira a circa metà vallata. Il 19 ottobre i sudisti attaccano di sorpresa gli accampamenti federali a Cedar Creek, ma alla fine, anche grazie al tempestivo e fortunato rientro di Sheridan da Washington, devono ritirarsi sconfitti. Ormai per loro è finita anche nella valle che ha visto negli anni precedenti numerose e brillanti vittorie confederate.
I successi di Sheridan e Sherman consentono a Lincoln di essere rieletto trionfalmente al secondo mandato presidenziale (8 novembre), sconfiggendo un riciclato McClellan; ma la vittoria di Lincoln è soprattutto sui radicali all’interno del suo partito, che come vedremo più avanti si mostrano sempre più attivi.
Tornando un pò indietro, e al fronte occidentale, vediamo che Sherman, già il 7 settembre, ordina l’evacuazione di Atlanta. Hood ha deciso di rinunciare a affrontare frontalmente le truppe di Sherman, e decide di puntare verso Nord e invadere Tennessee e Kentucky, nella speranza di essere inseguito da Sherman. Ma i tempi sono cambiati; la superiorità numerica dei nordisti consente la separazione delle forze, e si costituiscono quindi due eserciti dell’Ovest: uno, più piccolo, agli ordini di Thomas, è inviato a fermare Hood in Tennessee, l’altro, al comando dello stesso Sherman, destinato ad investire la Georgia e gli Stati atlantici, per poi risalire a Nord verso la Virginia.
L’unico problema per Sherman sono le linee di rifornimento, troppo lunghe; la soluzione è accumulare più equipaggiamento e provviste possibile, e per il resto prevedere di vivere sulle risorse del territorio attraversato. È una scelta audace, che taglia i ponti alle spalle e che costringe l’armata ad avanzare fino alla vittoria o alla distruzione; una ripetizione, più in grande, della manovra vittoriosa di Grant a Vicksburg. È anche una scelta spietata, che fa ricadere sulla popolazione civile il peso della guerra, come già aveva fatto Sheridan al nord. La prima misura è proprio nei confronti di Atlanta, che dopo l’evacuazione è rasa al suolo, in modo da non poter servire da base per un improbabile contrattacco confederato.
Il 16 novembre l’esercito si mette in moto, per la celebrata “Marcia verso il mare”. Ma più che un’offensiva, visto che davanti non ha un vero esercito, si tratta di una discesa trionfale verso il ventre molle della Confederazione. Per l’avanzata l’esercito è diviso in quattro colonne, che devastano e distruggono tutto su un fronte di 100 chilometri di ampiezza. Nemmeno qui ci si preoccupa molto delle buone maniere dei soldati. Il 21 dicembre la città portuale di Savannah è occupata. Il sacrificio della Georgia non è compensato da successi confederati sugli altri fronti: in Tennessee, a Franklin il 30 novembre e a Nashville il 15-16 dicembre, l’esercito del Sud è sconfitto in battaglie quasi suicide, dopo che le diserzioni hanno raggiunto livelli altissimi, ed è costretto a ripiegare. Ma ormai non si può più parlare di esercito: Hood si dimette.
Il 10 gennaio del nuovo anno Sherman si rimette in marcia da
Savannah
verso Nord. Columbia nella Carolina del Sud è presa il 17 febbraio,
Charleston
il 18. Intanto l’ultimo porto importante, Wilmington nella Carolina del
Nord è preso dal mare il 15 gennaio e raggiunto da terra il 22
febbraio.
Mentre Sherman mette l’odiata Carolina del Sud a ferro e fuoco
(nell’immaginario
collettivo nordista questo Stato era considerato il più guerrafondaio
e quello dal quale la secessione si era originata), le sparse forze
sudiste
sono riunite in Nord Carolina, e il loro comando è restituito a
Johnston.
Qui Johnston tenta, ma inutilmente, di fermare i federali, e la sua
abilità
di temporeggiatore poco può contro forze soverchianti. Intanto Sheridan
disperde le ultime forze sudiste di Early, nella valle dello
Shenandoah,
e porta la sua cavalleria davanti a Petersburgh: Grant lancia un
attacco
avvolgente (battaglia di Five Forks, 29-30 marzo, e il 2 aprile un
attacco
sull’intero fronte. Lee, per non essere aggirato, il 3 aprile è
costretto
ad abbandonare la città, e con essa Richmond. L’esercito di Grant lo
insegue e gli taglia la strada: a Appomattox Court House Lee rinuncia
ad
una estrema resistenza, e il 9 firma la resa. È la fine: anche se è
solo
un’armata che si arrende, il Sud è sconfitto, e presto anche gli altri
generali si arrendono ai federali.
L’emancipazione degli schiavi
La questione della emancipazione delle masse di africani ridotti in schiavitù, e presenti in gran numero negli Stati meridionali, percorre tutta la vicenda della guerra civile, costituendone sia una delle cause scatenanti, sia un fenomeno rilevante nel corso della guerra stessa, sia un problema scottante nel periodo successivo.
Per Marx ed Engels la questione della schiavitù è la questione centrale, origine dei dissapori tra Nord capitalistico e finanziario e Sud agrario e latifondista. Non così apparve però ai contemporanei, che sembravano tenere la questione dell’emancipazione in scarsa considerazione. A parte i gruppi d’agitazione abolizionista che operavano nel Nord, ben pochi nordisti sembravano avere a cuore le sorti dei negri. A livello popolare, poi, sembra addirittura che vi fossero più simpatie verso i negri, e la loro emancipazione, al Sud piuttosto che al Nord, almeno fino alla guerra.
Il fatto è che i vari attori dell’evento che si stava svolgendo non ne avevano chiara coscienza, e si muovevano, come sempre accade, come burattini mossi dai fili dipanati dalla storia e dall’economia della società in cui vivevano. Di Lincoln si può dire quello che è il motto più lungimirante di Cromwell: «Nessuno va così lontano come chi non sa dove sta andando». Infatti il buon Abramo passò quegli ultimi 5 anni della sua vita a rimangiarsi nei fatti le posizioni che aveva assunto in precedenza.
Fin dal primo anno di guerra Marx aveva ben chiaro, invece, quanto la questione dell’emancipazione fosse fondamentale per la riuscita di quello che si può considerare il completamento della rivoluzione borghese in America del Nord, rivoluzione che era iniziata con quella inglese del ‘600 ed aveva attraversato l’Atlantico sulle navi dei colonizzatori. Sviluppo capitalistico che, disperso nello sconfinato Nuovo Mondo, sarebbe dapprima regredito in sue forme specifiche. La cosiddetta Rivoluzione americana, cioè la Guerra di Indipendenza, segnò l’emancipazione nazionale della borghesia americana dalla sudditanza coloniale alla Gran Bretagna; a questo si riduce la sua portata sociale ed economica, sia negli scopi sia nella condotta dello scontro, che coinvolse solo una piccola minoranza dei coloni americani. La Guerra Civile, al contrario, aveva la possibilità di scatenare in modo completo quelle forze produttive che secondo la nostra dottrina preparano la strada alla rivoluzione proletaria. Il sistema economico del Sud, e quindi la schiavitù, si frapponeva a questa liberazione. Di qui il sostegno, il “tifo” che Engels e Marx sempre mostrarono a favore del Nord.
Già verso il 1° novembre 1861 Marx scriveva: «L’attuale conflitto fra Nord e Sud altro non è che un conflitto fra due sistemi sociali, fra il sistema della schiavitù e quello del lavoro libero. Tale conflitto è scoppiato perché i due sistemi non possono più coesistere pacificamente l’uno accanto all’altro nel continente nordamericano, e potrà concludersi unicamente con la vittoria di un sistema o dell’altro. Se gli Stati di confine, sul cui suolo i due sistemi hanno lottato sinora per conquistare la supremazia, costituiscono una spina nella carne viva del Sud, è peraltro inequivocabile che nel corso degli eventi bellici sino a questo momento hanno anche rappresentato la più grave debolezza del Nord (...) La preoccupazione di assecondare la buona disposizione degli schiavisti “lealisti” dei border states, la paura di spingerli tra le braccia dei secessionisti – in breve, il desiderio di non toccare menomamente la suscettibilità, gli interessi e i pregiudizi di questi infidi alleati, ha provocato la debolezza cronica del governo dell’Unione sin dall’inizio della guerra, lo ha indotto a prendere mezze misure, lo ha costretto a dissimulare il principio della guerra e a non colpire il punto più vulnerabile del nemico, la radice del male – la schiavitù stessa. Quando, solo di recente, Lincoln ha revocato con pusillanimità il proclama del Missouri di Frémont sulla emancipazione dei negri di proprietà dei ribelli, lo ha fatto esclusivamente per placare le vibranti proteste degli schiavisti “lealisti” del Kentucky. Ad ogni modo si è giunti ormai ad un momento cruciale (...) Il corso stesso degli eventi spinge a lanciare il grido decisivo – emancipazione degli schiavi».
La liberazione degli schiavi si era quindi presentata anche come una necessità militare. Quando più tardi il generale Hunter si fece promotore di una iniziativa analoga a quella di Frémont, la risposta del presidente fu la medesima. Nel 1862 però l’inadeguatezza dello sforzo militare da un lato, e le minacce di una parte del partito repubblicano di dar vita a un terzo partito d’impostazione più radicale dall’altro, costrinsero Lincoln a muoversi in modo più deciso. La borghesia più determinata aveva fatto sentire la sua voce.
«Il mio obbiettivo di fondo, in questo conflitto, è quello di salvare l’Unione – annunciò Lincoln nel 1862 – Se io riuscissi a portare a termine questa operazione senza liberare alcuno schiavo, lo farei, così come libererei tutti gli schiavi, o soltanto una parte di essi, se una delle due alternative mi consentisse di raggiungere quello scopo». Ma nell’autunno del 1862 i tempi erano maturi: il Sud non mostrava di voler cedere, e solo ad Antietam era stata bloccata dall’esercito unionista la controffensiva vittoriosa di Lee. Sull’onda di quella vittoria (che qualcuno considera una sorta di giro di boa della guerra, l’inizio della fine per il Sud) Lincoln diffuse un primo proclama in cui egli annunciava la propria intenzione di liberare, a partire dal 1° gennaio 1863, tutti gli schiavi che si trovavano nelle aree sotto il dominio dei ribelli.
Secondo Lincoln si trattava di una misura prettamente tattica: «Senza il problema della schiavitù, la ribellione non sarebbe mai avvenuta – egli sostenne – e, privata della schiavitù, questa non potrebbe continuare». Si può anche concordare con lui e con questa lapalissiana considerazione, ma va ricordato che il Sud non era semplicemente il Nord più gli schiavi. In realtà abbiamo visto che la schiavitù aveva influito in profondità sulla struttura economica e sociale del meridione, ed era illusorio pensare che la rimozione “del problema” avrebbe sic et simpliciter rimesso tutto a posto; e lo si sarebbe visto ben presto.
Il proclama invitava gli Stati del Sud a rientrare nell’Unione, previa l’emancipazione obbligatoria di tutti gli schiavi, in cambio della fine del conflitto. In quell’occasione fu anche promesso un risarcimento delle perdite economiche derivanti dall’emancipazione. Il proclama definitivo, emanato il 1° gennaio 1863, comprendeva soltanto i territori in mano alla Confederazione, mentre non si applicava nei border states, né nelle aree “liberate”. Si trattava comunque di un evento straordinario (anche se “cavilloso”, ma pur sempre “storico” per Marx).
Se si pensa a quello che era il pensiero di Lincoln all’epoca del suo insediamento, quando, tra l’altro, si era detto disponibile ad accettare un tredicesimo emendamento alla Costituzione che garantisse il permanere della schiavitù negli Stati del sud, si vede quanto poco conti l’uomo: il medesimo personaggio auspicava ora un tredicesimo emendamento che prevedesse l’abolizione della schiavitù negli Stati della Confederazione. Ma il Congresso, di tendenza assai più radicale del presidente, andò molto più in là varando un provvedimento che proibiva la schiavitù in tutto il territorio degli Stati Uniti. Ratificato nel dicembre 1865, otto mesi dopo la morte di Lincoln, questo emendamento rappresentò una significativa alterazione della Costituzione.
Il proclama di emancipazione non poteva più essere rimandato, anche perché non faceva che ratificare quanto già stava avvenendo nelle fattorie e piantagioni di tutto il Sud. La carenza di controllo sugli schiavi dovuta all’emergenza della guerra, con tanti uomini bianchi in uniforme, rese possibile un rilassamento della disciplina, con numerosi casi di renitenza al lavoro, di indisciplina, di fughe, di insubordinazioni. La situazione poi esplodeva dove arrivavano i federali. Già nel 1862 era stata approvata una legge che proibiva all’esercito la restituzione degli schiavi fuggitivi (che venivano comunque sfruttati come lavoratori ausiliari dell’esercito stesso; molto disinvoltamente li chiamavano “contrabbando di guerra”); poi la schiavitù fu abolita nel District of Columbia (la città di Washington) e nei Territori, misura più che altro simbolica.
Il proclama di emancipazione ebbe come conseguenza la possibilità di arruolare negri nell’esercito unionista. Se da un lato questo consentiva l’accesso di truppe abbondanti e motivate, dall’altro suscitava qualche timore. Che farà il negro armato quando avrà imparato ad ammazzare bianchi impunemente? Sin dall’inizio si sprecavano gli inviti ad astenersi dalla violenza ove la liberazione degli schiavi era applicata; ed in realtà i fatti di violenza furono abbastanza scarsi al confronto dell’estensione del fenomeno dell’emancipazione. Piano piano quindi al Nord si cominciò ad accettare l’idea del negro con il fucile. D’altronde, dopo molte esitazioni, e troppo tardi, anche al Sud si era deciso di armare i neri. La necessità l’aveva avuta vinta sulla fifa: i negri, che in potenza rappresentavano un pericolo sociale spaventevole, raramente si erano dimostrati all’altezza dei timori dei bianchi; erano una classe di schiavi, ma si trovavano in una miriade di situazioni particolari, senza contatti tra loro, senza capi; raramente si ribellarono e in genere il loro obbiettivo principale era occupare un pezzo di terra per viverci. Ma ai bianchi ci vollero anni per comprenderlo.
Al Sud lo capirono troppo tardi: alla fine si resero conto che l’enorme inferiorità numerica era un problema insormontabile per le loro armate; mentre il nemico usava i “loro” negri contro il Sud stesso. Da lungo tempo il presidente Davis e alcuni tra i più eminenti capi militari meridionali, tra i quali Lee, stavano meditando di emancipare almeno in parte gli schiavi per salvare l’indipendenza della Confederazione. Infine, malgrado l’opposizione del Congresso confederato, Davis pervenne a far approvare una legge per cui gli schiavi che si fossero arruolati volontari nell’Esercito confederato avrebbero avuto alla fine della guerra non solo la libertà, ma (ciò che era veramente notevole allora) anche la cittadinanza e un pezzo di terra. Ciò mentre il Nord – e lo stesso Lincoln – ancora pensavano di risolvere il problema dei liberati con la deportazione in Africa.
La storia è andata diversamente ma questo fatto, a parte una poderosa conferma del determinismo nella storia umana, mostra come il momento fosse di fatto rivoluzionario: il bene supremo per il Sud era l’indipendenza, ma per mantenerla il Sud sarebbe andato incontro ad un graduale sfascio del suo sistema economico, sostituendovi gradualmente un sistema singolarmente simile a quello contro cui combatteva. Quindi la storia avrebbe avuto il suo corso comunque, al di là delle latitudini, degli schieramenti, del colore delle uniformi, delle razze, dei generali, delle idee e della coscienza che gli uomini avevano della situazione nella quale operavano. Alla fine l’America del Nord doveva trasformarsi per consentire al sistema capitalistico di svilupparsi ai ritmi che il commercio mondiale e le risorse disponibili gli consentivano. E così fu.
Alla fine della guerra, nel 1865, quasi un milione di ex schiavi, un
quarto dei negri meridionali, aveva lasciato le piantagioni e cercato
riparo
presso le truppe unioniste, lavorando poi per l’esercito, spesso in
condizioni
durissime e senza salario. Circa duecentomila afroamericani,
provenienti
per l’80% dagli Stati confederati, combatterono nei ranghi della marina
e dell’esercito unionisti, in “reggimenti neri” comandati da ufficiali
bianchi. Ovviamente molti erano scettici sulla loro capacità di
combattere,
ma dovettero presto ricredersi. Inizialmente i negri ricevevano paghe
inferiori,
ma alla fine furono equiparati ai bianchi, la prima vera equiparazione
significativa nella storia dei negri in America; nell’esercito i negri
venivano alfabetizzati, ed erano sottoposti alle stesse regole dei
bianchi.
Si batterono con estremo coraggio, anche se venivano destinati
regolarmente
alle missioni peggiori; il trenta per cento di loro non tornò a casa,
una percentuale molto superiore a quella dei bianchi.
Il proletariato bianco
In realtà i negri facevano paura più al Nord che al Sud. Il Partito Democratico in particolare, che al Nord era all’opposizione, fece leva sulle difficoltà sorte dalla guerra per contrapporre l’interesse dei negri ad abolire la schiavitù a quello dei lavoratori bianchi, impoveriti dal prolungarsi del conflitto e dall’inflazione e minacciati dalla prospettiva del rovesciamento di milioni di afroamericani sul mercato del lavoro salariato. Prospettiva improbabile, ma creduta.
I proletari bianchi avevano le loro ragioni, come classe, ad avercela con il Partito Repubblicano e con il governo. La coscienza di classe, che stava cominciando a formarsi a Est, durante la guerra civile fu repressa sia al Nord sia al Sud dal richiamo all’unità patriottica, predicata dai politici e messa in atto dalle armi. Nel corso di questa guerra per la libertà, i proletari che osavano scioperare, soprattutto nelle fabbriche importanti per lo sforzo bellico, venivano affrontati da reparti dell’esercito armati di tutto punto; e chi si permetteva di criticare Lincoln finiva in galera senza l’ombra di un processo. Si arrivò a circa trentamila prigionieri politici, a testimoniare della democraticità della borghesia “rivoluzionaria”. Intanto il fiore del proletariato andava a morire sui campi di battaglia in Virginia e nel Tennessee.
A Nord la guerra determinò forti aumenti dei prezzi dei generi alimentari essenziali, anche del 100%, senza che i salari aumentassero; ne risentirono le famiglie, che facevano già fatica a mangiare regolarmente con i prezzi vecchi. Fu uno dei tanti modi in cui la borghesia sfruttò il tempo di guerra per arricchirsi in maniera sfacciata. Gli scioperi furono frequenti un pò ovunque, e per tutta la durata della guerra, in tutti i settori; questo portò anche a un rifiorire dei sindacati. In realtà si verificò una carenza di manodopera che conferiva una qualche forza ai proletari; molte furono le donne che entrarono per la prima volta in fabbrica, mal viste dai compagni maschi che in questo cambiamento vedevano soprattutto un attacco al livello medio dei salari, visto che le donne erano pagate meno. Nonostante la guerra, nel 1864 il proletariato era riuscito a risollevare la testa: 200.000 erano i lavoratori sindacalizzati, in sindacati anche nazionali, con propri organi di stampa.
L’estendersi degli scioperi fece sì che il padronato si rivolgesse al Congresso per avere una mano. Che non mancò: la Contract Labor Law del 1864 rendeva possibile assumere lavoratori stranieri che si impegnavano a fornire un anno di lavoro gratuito in cambio dei costi dell’emigrazione. Questo consentì ai capitalisti di avere manodopera a basso costo, e che non poteva scioperare. L’esercito era utilizzato per far fallire gli scioperi, talvolta riconducendo gli operai al posto di lavoro in punta di baionetta.
Tutto congiurava a far percepire ai proletari questa guerra come combattuta per lo schiavo negro, o per il capitalista in ghette, per tutti meno che per loro. Nel marzo 1863 fu varata la nuova legge sulla coscrizione, che dava a chi era estratto (il sistema funzionava come una lotteria, non c’era una leva generale) la possibilità di scansare l’arruolamento pagandosi un sostituto o versando 300 dollari al governo. Per la stragrande maggioranza che non poteva pagarsi l’esenzione – 300 dollari erano più del salario annuo di molti lavoratori – si trattò quindi di “una guerra di ricchi combattuta da poveri”. Niente di nuovo sotto il sole!
Nel luglio di quello stesso anno, subito dopo l’entrata in vigore della legge, la rabbia popolare esplose in rivolta nelle città del Nord. A New York una folla inferocita distrusse l’ufficio di reclutamento; poi, per tre giorni, gruppi di scalmanati percorsero la città distruggendo edifici, fabbriche, omnibus, case private. Le cosiddette “rivolte della leva”, draft riots, raccolsero lo scontento scomposto e cieco di disperati che si sfogarono contro ricchi, repubblicani, e soprattutto negri. Dopo il saccheggio di case di ricchi, i rivoltosi si accanirono soprattutto contro questi ultimi. Fu dato fuoco all’orfanotrofio dei bambini negri; molti negri furono impiccati, gettati nel fiume, braccati dalla folla; molti si rifugiarono in Central Park. Al quarto giorno i disordini furono fermati dalle truppe che avevano appena combattuto a Gettysburg. Si pensa che i morti, in questo evento di violenza interna, che resta il più imponente nella storia del Paese dopo la Guerra Civile e il crollo delle torri gemelle, siano stati circa quattrocento. Altre rivolte, meno cruente, si ebbero in molte altre città.
L’emancipazione fu quindi un fatto progressivo anche nel senso
dell’avanzamento
della lotta di classe, come scriverà poco tempo dopo Marx ne “Il
Capitale”:
«Negli Stati Uniti d’America ogni movimento operaio autonomo è rimasto
paralizzato finché la schiavitù deturpava una parte della repubblica.
Il lavoro in pelle bianca non può emanciparsi là dove è marchiato a
fuoco in pelle nera».
Le conseguenze della guerra
Anche nel Sud non tutto scorreva liscio. Due terzi dei bianchi non possedeva schiavi, e la maggioranza di questi “bianchi poveri”, poor whites, non era certo in condizioni economiche floride, quando non addirittura alla soglia della povertà, anche prima della guerra; quindi non tutti condividevano nel Sud l’entusiasmo per la guerra che sembrava pervadere la società sudista, soprattutto tra i piantatori. In realtà nelle zone più collinari e montagnose dell’interno vi furono voci discordi, che nel caso del West Virginia sfociarono in una secessione; ma situazioni analoghe si ebbero in East Tennessee, Arkansas, Missouri, Stati che fornirono volontari in gran numero anche all’esercito dell’Unione. Si trattava di yeomen, piccoli proprietari coltivatori diretti che non erano interessati alle ragioni dei piantatori, ma che avevano uno scarso peso politico. Lo scontento si allargò notevolmente durante la guerra, per la scarsità di cibo e per la coscrizione obbligatoria: anche al Sud esisteva la regola che consentiva ai ricchi di non combattere; inoltre ogni venti schiavi i piantatori avevano diritto ad una esenzione. Questi piccoli contadini costituivano il nerbo delle armate di Lee ma, dopo i primi entusiasmi, combattevano sempre meno volentieri, con il pensiero rivolto alle famiglie che dovevano fare a meno delle loro braccia per i lavori dei campi, e agli orrori della guerra che bussava spesso proprio a casa loro. In effetti furono le zone a diffusa yeomanry (Tennessee centro-orientale, Virginia del Nord, zone collinari del nord di Georgia, Alabama e Mississippi) le più devastate dagli eserciti nordisti.
Nel 1863 vi furono rivolte quindi anche al Sud, per la leva e per il pane. E la fase finale della guerra fu decisa anche dalle paurose fallanze di diserzione che si aprivano nelle file confederate. Erano appartenenti alla classe degli yeomen i più di 100.000 disertori che nei 4 anni di guerra abbandonarono l’esercito confederato, per non parlare dei renitenti alla leva. Il 1° gennaio 1865 oltre la metà dei soldati sudisti risultava assente senza licenza.
Si calcola il numero di perdite umane della guerra in oltre 365.000 per il Nord, e più di 320.000 per il Sud. Ci si avvicina quindi ai 700.000 morti, non pochi in un Paese di circa 30 milioni di abitanti; a questi va aggiunto un altro mezzo milione circa di feriti, invalidi e minorati fisici. Eppure queste cifre, pur enormi, non danno l’idea delle reali devastazioni subite dal territorio e dalle popolazioni delle due parti.
Il rivoluzionamento più brutale era stato subito ovviamente dal Sud. A parte i danni diretti, incalcolabili, il meridione aveva visto distrutto il suo mondo; la classe dei piantatori sudisti era stata radicalmente sconfitta e rovinata, più di quanto non lo fossero stati la nobiltà e il clero al tempo della Rivoluzione Francese. Sull’onda provocata dall’uccisione di Lincoln i vincitori imposero una pace cartaginese ai vinti: l’emancipazione degli schiavi fu immediata, totale e senza indennità, e le classe dei piantatori, grandi e piccoli, si trovò non soltanto privata di colpo dell’intera forza-lavoro, ma anche espropriata completamente di quasi tutto il capitale. La parte di capitale investita nella terra aveva subito grandi distruzioni e confische nel corso della guerra. Contemporaneamente, con un tratto di penna, il debito pubblico e la moneta confederati furono azzerati.
Ma per il Nord capitalista la grande conquista fu la mano libera in campo economico: i meridionali avevano sempre costituito la barriera più valida contro un protezionismo economico ad oltranza che avrebbe fatto pagare alla gran massa dei consumatori, e soprattutto alle campagne, il costo della rivoluzione industriale. La tariffa di protezione fu così innalzata a limiti senza precedenti. Il Tarif Act del 1864 portò i dazi sul totale delle merci tassabili importate dal 19,67% del 1860 al 47,56% del 1865. Anche gli interessi finanziari l’ebbero vinta: una legge del 1864 istituì un poderoso sistema bancario centrale.
Il Sud era politicamente, militarmente ed economicamente a terra. Le distruzioni che aveva dovuto subire erano spaventose. A parte decine di città e di villaggi bruciati e rasi al suolo, migliaia di chilometri di ferrovie sradicate, centinaia di ponti, stazioni ferroviarie, edifici pubblici e privati incendiati o fatti saltare in aria, vi era il decadimento delle strade, delle opere irrigue, delle foreste, l’abbandono di immense distese di terreno coltivato, che si ridusse del 18%; il patrimonio zootecnico si ridusse a Sud del 31% per gli equini, del 35% per i bovini, del 20% per gli ovini e del 42% pei suini. E la grave mancanza di foraggio ne impediva la ricostituzione a livelli pre-guerra. Il Sud fu ridotto al rango di colonia, e le condizioni determinate dalla guerra lo mantennero in una posizione di sottosviluppo per molti decenni ancora. Questo vale naturalmente anche per l’industria manifatturiera, che era forse il punto più debole della Confederazione all’inizio della guerra.
Ma non si deve pensare che le condizioni sfavorevoli di partenza e lo stringersi del blocco abbiano fatto ricadere i sudisti in un fatalismo rassegnato. In realtà il compito più grave che il governo confederato dovette affrontare fu proprio quello di creare dal nulla un apparato produttivo per sopperire ai bisogni della guerra e, date le condizioni di partenza, vi era una sola via: la industrializzazione forzata. Siccome la strada capitalistica, fondata sulla libera iniziativa, non era possibile perché i capitali erano immobilizzati nelle campagne, in schiavi soprattutto, e non potevano arrivare dall’esterno, restava la strada basata sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione e sul risparmio forzato, quella che alcuni storici hanno definito “socialista”.
Ciò fu fatto principalmente attraverso tre strumenti: la
sottomissione
di tutte le manifatture esistenti al più ferreo controllo pubblico (il
governo forniva i piani di produzione, assegnava le materie prime, i
trasporti
ferroviari, la mano d’opera, e bloccava i profitti, tanto che il
proprietario
delle più importanti acciaierie ad un certo punto offrì di cedere anche
formalmente la sua impresa allo Stato); la statizzazione mediante
acquisto
di quanti più stabilimenti possibile; infine la creazione di un vero e
proprio imponente settore industriale di Stato che, verso la fine del
conflitto,
costituiva la struttura portante di tutto l’apparato industriale
confederato.
La guerra per il Nord
Se il Sud risultò devastato dalla guerra, per il Nord questa significò prosperità senza precedenti. Si arricchirono le ferrovie, per le commesse militari e la chiusura del Mississippi che deviava i flussi commerciali sull’asse Est-Ovest; si arricchirono i fabbricanti di carne in scatola: Chicago, la città della ferrovia e dei grandi macelli, conobbe una crescita prodigiosa in quegli anni. Ma la pacchia toccò tutti i settori legati alla guerra, come l’agricoltura, che compensava la manodopera perduta con una crescente meccanizzazione ed una ulteriore espansione ad Ovest; o come l’abbigliamento, col quale si arricchivano gli onesti ma che consentiva guadagni siderali ai disonesti, come quelli che fabbricavano i capi con lo shoddy, cioè la lana rigenerata fatta con i cascami e i filati vecchi rilavorati, spesso semplicemente compressi. Come ben presto appresero a loro spese i soldati dell’Unione, una divisa confezionata con questo materiale sembrava del tutto normale, ma sotto la pioggia letteralmente si scioglieva. Questo delle truffe ai danni dello Stato è un fenomeno d’altronde assai comune: è facile passare i controlli, magari con qualche bustarella agli impiegati, e poi tutto sarà macinato nel caos della guerra. Mentre si adopera per trasfondere nei proletari gli ideali patriottici, per la borghesia la guerra significa solo una ulteriore occasione di fare affari, leciti ed illeciti, con gli amici e con i nemici, l’importante è che ci sia profitto.
Il Paese risultò modificato in profondità dalle condizioni createsi
dopo la fine della guerra. L’emergente borghesia industriale era
fortemente
nazionalista e repubblicana; il Congresso adottò politiche economiche
fortemente espansive: nacque la moneta cartacea nazionale, un sistema
bancario
centrale, e un enorme debito pubblico. I fondi venivano reperiti con
nuove
tariffe e tasse su praticamente tutto quello che veniva prodotto e
consumato.
La manodopera distrutta dalla guerra era sostituita rapidamente grazie
a incentivi all’immigrazione. L’Homestead Act fornì terre gratuite
ai pionieri, scuole agrarie e tecniche furono fondate ovunque, ampie
superficie
di terra furono donate alle compagnie ferroviarie per costruire
ferrovie
che facilitassero la penetrazione del capitale verso l’Ovest.
Quest’ultima
misura suonava come una condanna per gli indiani delle praterie, ma se
si possono fermare gli eserciti non vi è forza sufficiente a fermare il
capitale nella sua fase di espansione. Mentre alla vigilia della guerra
il governo si trovava in una sorta di impotenza, ora che il capitalismo
industriale e finanziario faceva sentire la sua voce si manifestava un
attivismo senza precedenti, che rifletteva la vera nascita del moderno
Stato nord-americano.
L’atteggiamento di Marx e di Engels
I nostri maestri seguono la guerra con attenzione, e ne scrivono molto soprattutto nei primi due anni, quando Marx ne fa oggetto di corrispondenze per la stampa. Successivamente continuano a parlarne nella corrispondenza.
A parte i giudizi generali e militari che abbiamo citati, la prima cosa che si nota, soprattutto nelle lettere, è la partecipazione passionale alle sorti della guerra, nella quale parteggiano apertis verbis per il Nord. Il Sud non è la vittima del Nord, bensì aggressore ed espansionista: Marx dimostra che lo schiavismo non può accontentarsi di sopravvivere, le sue caratteristiche lo costringono ad espandersi (“guerra di conquista”) continuamente, mentre la stagnazione significa morte del suo sistema economico. Si tratta di un conflitto tra due sistemi sociali che non possono più convivere; Sud e Nord non sono e non possono essere due paesi autonomi: «Il Sud non è una nazione, è un grido di battaglia».
Entrambi lamentano scarsa energia rivoluzionaria da parte del Nord; il popolo non sente la guerra, dice Engels il 30 luglio 1862, il governo esita in tutto: coscrizione, misure finanziarie, attacchi allo schiavismo, reclutamento dei negri; se qualcosa passa viene reso praticamente inefficace da miriadi di clausole poste da Lincoln. E i generali sono tutti incapaci. Se non dà inizio a una guerra rivoluzionaria il Nord non può vincere. Marx è più ottimista: riconosce le debolezze politiche e militari del Nord, che il Sud non ha, ma sa che il tempo lavora a favore del Nord, e che la situazione cambierà. Anche dopo la seconda battaglia di Bull Run Marx avvisa Engels, il 10 settembre 1862, di non farsi troppo influenzare dall’aspetto militare. Certo, si dovrebbe passare dalla fase “costituzionale” a quella “rivoluzionaria”, che per i nostri consiste nell’uso di tutta la forza disponibile contro i rappresentanti del sistema economico arretrato. Ma quella fase rivoluzionaria intesa in modo esplicito e totale non verrà mai in Nordamerica: la borghesia vi nasce già reazionaria, come d’altronde anche in Europa nello stesso secolo; la paura del proletariato è già estrema, e i capitalisti si dibattono tra il desiderio di trasformare radicalmente la società e il timore di un’offensiva della classe operaia, e in questo caso anche del proletariato negro. Mettere in mano alle classi subalterne del Nord e anche del Sud strumenti politici e militari efficaci è troppo rischioso, e non sarà mai tentato, se non con cautele che ne riducono enormemente l’efficacia.
Se il Nord avesse fatto opera di agitazione tra i negri del Sud, e li avesse armati ove possibile, sia dietro le linee sia arruolando i negri fuggiti e quelli del Nord, la guerra sarebbe terminata in pochi mesi, e con perdite umane trascurabili. Ma chi avrebbe poi impedito a quelle schiere di armati di riorganizzare il loro mondo nella maniera che ritenevano migliore? La grande paura della borghesia, che si concretizzerà pochi anni dopo con la Comune di Parigi, percorre gli ultimi due secoli come una costante, dalla quale non si può prescindere; una paura, d’altronde, giustificata. Per lo Stato borghese, per tutti gli Stati borghesi, qualsiasi scontro tra gruppi di interessi, classi sociali, Stati sovrani, può avere luogo solo dopo che ci si è assicurati il controllo delle classi sociali subalterne e lavoratrici, o dopo che queste sono state saldamente aggiogate al carro dei contendenti, il che poi è la stessa cosa, e non sono in grado di combattere per sé stesse. Al proletariato negro non fu concesso di combattere in prima fila per la propria liberazione; gli fu concesso di far morire, agli ordini di ufficiali bianchi, diverse decine di migliaia di suoi figli, senza dare niente in cambio, se non vaghe prospettive di un benessere che non sarebbe arrivato, e una emancipazione che trasformava la loro condizione solo nominalmente, ma che non migliorava le loro condizioni di vita; al contrario, nei decenni a seguire queste sarebbero in realtà peggiorate.
Una guerra “rivoluzionaria” sarebbe quindi stata decisiva nelle prime fasi della Guerra Civile; ma nel 1863 la disparità delle forze in campo è ormai tale che è chiaro a tutti che la caduta del Sud è solo questione di tempo.
Anche in occasione delle elezioni legislative dell’autunno 1862, che vedono i repubblicani prendere una sonora batosta (ma mantenendo una maggioranza sufficiente, di 20 seggi), grazie a un diffuso spirito contrario alla guerra che premia i democratici, Engels si inalbera: «Per quanto sia anche opportuno che la repubblica borghese anche in America faccia una figura orrenda, sì che in avvenire non potrà mai venire esaltata on its own merits, ma invece soltanto come strumento e forma di passaggio alla rivoluzione sociale, tuttavia fa rabbia che una pidocchiosa oligarchia, con solo metà della popolazione, si dimostri altrettanto forte che la massiccia, grande, torpida democrazia»” (15 novembre 1862). Anche in questa occasione Marx rimane ottimista, ricordando i guai del Sud, e il fatto che la vittoria democratica è una reazione normale nei movimenti rivoluzionari. In realtà probabilmente i repubblicani salvarono la loro posizione soprattutto grazie all’intervento del governo: i democratici ebbero la maggioranza nelle assemblee dell’Illinois e dell’Indiana, e fu solo l’intervento dell’esercito dell’Unione – che procedette all’arresto di alcuni candidati del partito Democratico – a dare ai repubblicani la possibilità di rimanere al potere in Stati di confine come il Missouri, il Kentucky e il Maryland. Inoltre Lincoln fece prima arrestare, e poi esiliare nei territori del sud, Clement L. Vallandingham, un noto esponente del partito Democratico dell’Ohio, un probabile futuro avversario per le presidenziali. La borghesia non si scandalizza delle misure dittatoriali, aperte o mascherate, basta vadano nella direzione dei suoi interessi.
Marx ed Engels denunciano le mene degli Stati europei, che studiano di sfruttare a loro favore la guerra civile per un’impresa imperialistico-finanziaria in Messico; questo mentre la classe operaia britannica si batte generosamente per la causa del Nord. Infatti agli inizi del 1862 gli industriali cotonieri inglesi, prendendo come scusa l’incidente del Trent, imbastirono una campagna per l’intervento britannico a favore del Sud, al fine di spezzare il blocco navale. Gli operai inglesi, pur danneggiati dal blocco del cotone che aveva causato ampia disoccupazione nel settore tessile, generosamente dimostrarono a favore del Nord, fungendo così da deterrente per le tentazioni interventiste di parte della borghesia britannica.
La stessa Internazionale fece sentire la sua voce, prima
congratulandosi
con Lincoln per la sua rielezione nel 1864 (che l’interessato gradì),
poi invitando il successore di Lincoln, il suo vice Andrew Johnson, a
compiere
l’opera del primo – assassinato, si credeva allora, dal nemico giurato
sudista – a iniziare la nuova era dell’emancipazione del lavoro.
La “Ricostruzione” e il suo fallimento
La Guerra Civile fu la conseguenza del fatto che le classi dominanti della società americana erano nettamente spezzate in due tronconi.
Nelle grandi rivoluzioni borghesi la divisione all’interno delle classi dominanti consentì alle tendenze radicali degli strati inferiori di emergere, e questo assai di più nel caso della Rivoluzione francese che nel caso di quella inglese. Nella Guerra Civile americana non vi fu nessun sollevamento radicale di questo tipo. Almeno nelle grandi linee la ragione è facile da comprendersi: le città americane non brulicavano di artigiani tartassati e di potenziali sans-culottes. La coscienza di classe e la forza organizzata dei proletari erano quasi inesistenti, anche perché l’esistenza di terre nel West contribuiva a ridurre il potenziale esplosivo. Mancavano poi le condizioni per una rivolta contadina. Invece dei contadini, al fondo della piramide nel Sud v’erano soprattutto schiavi negri; e questi non erano nelle condizioni di ribellarsi, se non in modo sporadico e mai organizzato. Benché vi siano state insurrezioni di schiavi, non ebbero conseguenze politiche. Nessuna chiara spinta rivoluzionaria si manifestò da questa parte, anche perché la loro liberazione non era stata opera loro. Abbiamo visto con che timore e cautela i due belligeranti avessero acconsentito a mettere le armi in mano a un numero non eccessivo di neri. Un altro ostacolo alla lotta diretta e organizzata dei negri era anche la profonda ignoranza nella quale erano tenuti. Così gli ex schiavi furono spinti nel mondo esterno alle piantagioni a mani vuote, soli e indifesi.
Dopo la morte di Lincoln, Andrew Johnson, il Vicepresidente che prese il suo posto, ne continuò l’opera di riconciliazione, fatta di perdoni e di ricostituzione della classe dirigente del Sud con gran parte degli antichi dignitari. Johnson nominò i governatori degli Stati ex ribelli e li autorizzò a convocare le assemblee costituenti, ammettendo al voto chi avesse prestato il giuramento proposto da Lincoln: fedeltà agli Stati Uniti e accettazione del Proclama di emancipazione; i funzionari confederati di rango più elevato e i maggiori proprietari terrieri avrebbero dovuto essere perdonati individualmente dal Presidente. Completata questa procedura, gli Stati sarebbero rientrati nell’Unione.
Johnson era un ex senatore democratico del Tennessee, l’unico senatore del Sud a rimanere fedele all’Unione. Era stato contro l’aristocrazia terriera meridionale, e questo faceva pensare che sarebbe stato assai severo contro questa; ma era anche un virulento e aperto razzista, e ciò pesò quando dovette prendere certe decisioni. La sua scelta era stata fatta da Lincoln sia per motivi elettorali, sia per controbilanciare il peso dei radicali repubblicani; ovviamente l’attentato non era nelle previsioni. Johnson consentì ai governatori di circondarsi di prominenti ex secessionisti, da lui perdonati con estrema facilità, e di emanare leggi e regolamenti per restringere le libertà dei negri appena emancipati.
I cosiddetti black codes, i “codici dei negri” che
sostituivano
gli slave codes, le vecchie leggi sugli schiavi, cui
assomigliavano
in modo impressionante, miravano a tenere gli ex schiavi nelle
piantagioni
con forme di servitù appena velate. Questi codici limitavano il diritto
dei negri di affittare terre, acquistare armi, muoversi liberamente;
imposero
tasse proibitive a chiunque di loro volesse iniziare attività autonome,
soprattutto se non agricole; e consentirono ai padroni di prendere come
“apprendisti” i figli degli ex schiavi che si mostrassero “inadatti”
come genitori. I negri non potevano testimoniare in tribunale contro i
bianchi; se abbandonavano il lavoro potevano essere messi in prigione
per
non aver rispettato il contratto; chi era trovato senza lavoro poteva
essere
arrestato e multato per 50 dollari. Chi non poteva pagare veniva
affittato
a chiunque nella contea potesse pagare la multa. I negri potevano anche
essere multati per gesti ingiuriosi, mancato rispetto del coprifuoco,
possesso
di armi da fuoco. Si stabilì un controllo personale dei negri che non
si poteva distinguere dalla schiavitù. Nonostante il tredicesimo
emendamento,
che rendeva la schiavitù incostituzionale, il Sud tentava di ricrearla
nelle leggi pur senza nominarla. Alla fine del 1865 gli ex confederati
avevano ripreso il potere e stabilito le loro regole.
La mancata riforma agraria
L’unica spinta progressiva provenne dai capitalisti del Nord. Nel gruppo noto come dei Repubblicani Radicali gli ideali abolizionisti si mescolavano agli interessi industriali per dare vita ad una breve fiamma, che sfrigolò e presto si spense nel fango della corruzione.
Sebbene i Radicali rappresentassero per Lincoln durante la guerra una spina nel fianco, tuttavia riuscì a portare la guerra ad una conclusione militare vittoriosa sulla base del solo programma di salvaguardare l’esistenza dell’Unione, senza cioè condurre nessuna seria offensiva contro i diritti di proprietà al Sud. Ma per un breve periodo, circa tre anni dalla conclusione dei combattimenti, 1865-68, i Repubblicani Radicali detennero il potere nel Nord e condussero un’offensiva contro il sistema delle piantagioni e i resti della schiavitù.
I dirigenti del gruppo consideravano la guerra come una lotta tra il capitalismo progressivo del Nord ed una società agraria reazionaria basata sulla schiavitù. Se il conflitto tra Nord e Sud rivestì veramente questo carattere, le più importanti battaglie furono combattute dopo la fine della guerra. Ma si era ormai nella fase del capitalismo codardo e corrotto, incapace di condurre la sua stessa rivoluzione sino in fondo. Così fu in Italia e in Germania, così sarà per la gran parte delle rivoluzioni borghesi nel Terzo Mondo: la borghesia è costretta a subire le pressioni delle potenze esterne, mentre deve guardarsi in primis dalla propria classe operaia. Così è costretta a fermarsi a metà strada, o a cammuffarsi (come in Cina), a volte a fare marcia indietro.
Dagli ideologi dell’abolizionismo e dai radicali del gruppo di Free Soil, un piccolo nucleo di politici repubblicani interpretarono la Guerra come l’opportunità di sradicare un “residuo di un mondo morente di baroni e servi, nobili e schiavi” per ricostituire il Sud secondo l’immagine del Nord, “progressivo e democratico”, fondato sulla “libertà di parola, sulla libertà di lavoro, sulle scuole e le urne elettorali”. Il leader dei repubblicani radicali nella Camera dei rappresentanti, Thaddeus Stevens, che in pubblico si esprimeva più cautamente, in una lettera scriveva che ciò di cui il paese abbisognava era di un capo (cioè non Lincoln) «con sufficiente coraggio morale per fare di questa una rivoluzione radicale, e per rimodellare le nostre istituzioni (...) Ciò comporterebbe la distruzione della società sudista ed insieme la sua emancipazione, e il ripopolamento di metà del continente».
Ma ciò che diede vento alle vele di questo movimento e lo portò fuori dal regno delle pure chiacchiere fu la coincidenza dei suoi obiettivi con gli interessi di alcuni settori di vitale importanza della società del Nord: la nascente industria del ferro e dell’acciaio in Pennsylvania e un gruppo ferroviario. Stevens, come parlamentare, agiva da intermediario per entrambi questi gruppi, da ciascuno dei quali riceveva denaro. I repubblicani radicali ricevevano anche le simpatie di molti lavoratori del Nord, anche se questi si mostravano freddi nei confronti dell’abolizionismo, poiché temevano la concorrenza dei negri. Consideravano gli abolizionisti del New England i rappresentanti ipocriti dei proprietari delle fabbriche, mentre erano entusiasti del protezionismo dei radicali e del loro programma antideflazionista. La finanza e il commercio, invece, non nutrivano simpatie per i radicali. E dopo la guerra i radicali si volsero contro la “plutocrazia del Nord”.
L’offensiva dei radicali non rappresentò perciò un fronte unito dei capitalisti contro il sistema delle piantagioni, e questo ne spiega l’intrinseca debolezza. Al tempo del loro maggior potere fu una coalizione di industriali e di alcuni gruppi ferroviari, appoggiata da parte della classe operaia.
Nel discorso del 1865 Stevens presentò all’opinione pubblica e al Congresso la sua analisi della situazione e il suo programma d’azione. Il Sud doveva essere trattato come un paese conquistato, e non come una serie di Stati che, dopo avere lasciato l’Unione ,potessero essere riaccolti con favore. «Le fondamenta delle sue istituzioni politiche, municipali e sociali debbono essere infrante e ricostruite diversamente, o altrimenti tutto il nostro sangue e il nostro denaro saranno stati spesi invano. Questo si potrà fare solamente trattandolo da paese conquistato». Agli Stati del Sud non deve essere consentito il ritorno nell’Unione, affermò Stevens, «finché la Costituzione non sarà stata emendata in modo tale da renderla effettivamente quale i suoi creatori volevano che fosse: ed in modo da assicurare un perpetuo ascendente al partito dell’Unione», vale a dire al Partito Repubblicano. Se gli Stati del Sud non saranno “ricostruiti” – questo eufemismo è passato dall’uso di allora in tutte le storie scritte successivamente – essi potranno facilmente sommergere il Nord, affermava lo Stevens, e così il Sud avrebbe vinto la pace dopo avere perso la guerra.
Da queste considerazioni lo Stevens faceva discendere il programma per ricostituire la società del Sud da cima a fondo: spezzare il potere dei proprietari delle piantagioni confiscando i possedimenti superiori ai duecento acri, «anche se ciò dovesse spingere la nobiltà (del Sud) all’esilio». In questo modo il governo federale avrebbe ottenuto abbastanza terra per dare ad ogni famiglia negra circa quaranta acri. “Quaranta acri ed un mulo “ divenne lo slogan per screditare le speranze, ritenute utopistiche, dei negri appena liberati.
La richiesta di una vasta redistribuzione delle terre nasceva dalla
consapevolezza che solo questa misura avrebbe spezzato il potere dei
piantatori.
Questi infatti avevano già cominciato ad adoperarsi per ricuperare con
altri mezzi la sostanza del potere perduto, cosa che poterono ottenere
a causa della miseria economica dei negri. Vi sono elementi per
ritenere
che la divisione delle vecchie piantagioni per costituire una piccola
proprietà
negra fosse un’operazione fattibile. Le autorità militari del Nord
fecero
due esperimenti di questo tipo per risolvere il pressante problema di
migliaia
di negri privi di ogni risorsa. Trasferirono le terre confiscate ed
abbandonate
a più di 40.000 negri, che si ritiene riuscissero con successo a
lavorare
la terra come piccoli contadini, fino a che il presidente Johnson
restituì
le proprietà ai precedenti proprietari bianchi. L’esperienza della
schiavitù
non era certamente la più adatta per preparare i negri a gestire
un’azienda
come piccoli capitalisti rurali. I negri avrebbero potuto fare ben poco
per se stessi e a favore degli interessi del Nord, senza un minimo di
sicurezza
economica e un minimo di diritti politici, incluso il diritto di voto.
La “Ricostruzione” secondo i Radicali
I radicali si scagliarono contro l’indulgenza di Johnson, e il ritorno all’home rule. Si ebbe uno scontro al Congresso che arrivò al quasi impeachment del Presidente, il quale perse il suo ascendente, mentre il Congresso azzerava tutto e ripartiva con la Ricostruzione a modo suo. Il primo passo fu una inchiesta sulle reali condizioni del Sud. L’inchiesta documentò l’esistenza tra i negri di diffusa miseria, oppressione brutale da parte dei bianchi, intimidazione e discriminazione legale. Il comitato condusse un esame dettagliato dei disordini razziali che all’epoca si erano avuti a Memphis e a New Orleans, in cui si erano avuti molti morti; la conclusione fu che la ribellione di New Orleans era in realtà stata un massacro della polizia in cui dozzine di negri erano stati assassinati a sangue freddo.
Il Congresso abolì l’home rule negli Stati del Sud, e divise l’ex Confederazione in cinque distretti militari. Anche i cittadini del Sud che avevano già ottenuto il perdono dovettero prestare un giuramento più rigoroso prima di riottenere il diritto al voto, e gli ex funzionari sudisti ne furono esclusi. Le convenzioni statali dovettero redigere nuove Costituzioni.
Ridotto al nocciolo, il programma radicale di ricostruzione del Sud consisteva nel fare uso della forza militare del Nord per distruggere l’aristocrazia delle piantagioni e creare al suo posto una proprietà fondiaria capitalistica moderna, assicurando ai negri la proprietà della terra e il diritto di voto. Masse di lavoratori, inizialmente coinvolte nella produzione agricola estensiva, si sarebbero in breve, grazie alla dinamica economica stessa, rivolte verso le città industriali, fornendo quella manodopera a basso prezzo di cui la borghesia industriale sempre abbisogna, mentre il settore agricolo avrebbe subito l’evoluzione dettata dalle leggi del mercato. Si trattava di un programma rivoluzionario, in senso capitalistico.
Ma da questo punto di vista le cose non andavano così male per le industrie del Nord; anche tenendo conto del movimento verso Ovest, le forze di lavoro che venivano dall’Europa, molto più qualificate e colte dei negri, e con minori problemi di integrazione, erano, se non sufficienti, perlomeno tali da dividere la borghesia. Così anche i nordisti che professavano simpatia per la causa negra accusarono il colpo. Horace Greely, direttore del “New York Tribune”, scrisse in risposta al discorso di Stevens del 6 settembre 1865: «protestiamo contro l’idea di dare battaglia alla proprietà del Sud perché le classi più agiate del Sud, essendo piú illuminate ed umane degli strati ignoranti dei bianchi poveri, sono meno ostili verso i negri».
Ii timori del N.Y.Tribune ci danno un cenno di quello che sarebbe accaduto quando le classi agiate del Nord e del Sud avessero sepolto le loro divergenze e, con un altro famoso compromesso, avessero lasciato i negri a cercare da soli che cosa fare della loro libertà.
Non sorprende perciò che i radicali venissero rapidamente disfatti. O meglio, disfatti non furono i radicali in quanto tali, ma sconfitto risultò quanto vi era di radicale nel loro programma, non appena si scontrò con gli interessi dei proprietari del Nord. I radicali non riuscirono ad imporre, contro la volontà dei repubblicani più moderati, che nelle leggi sulla ricostruzione del 1867 fosse inserita la confisca delle terre. Alla Camera dei rappresentanti, la proposta dei “40 acri” di Stevens ricevette solamente 37 voti. Le classi più influenti del Nord non erano nello stato d’animo di tollerare un diretto attacco alla proprietà, neppure alla proprietà dei ribelli, e neppure in nome della democrazia capitalistica e dello sviluppo economico. La “Nation” ammoniva: «una divisione delle terre dei ricchi tra i senza terra significherebbe per il nostro sistema sociale e politico un trauma dal quale difficilmente si riprenderebbe senza la perdita della libertà». Il fallimento della riforma agraria rappresentò una sconfitta decisiva che eliminò la parte fondamentale del programma dei radicali. Senza la riforma agraria il resto del programma non costituiva che un insieme di misure palliative o irritanti, a seconda dei punti di vista.
Questo fallimento, che lasciava in piedi l’alleanza fra i proprietari bianchi del Sud con quelli del resto del Paese, rispecchiava i limiti della spinta rivoluzionaria nella società americana del tempo.
Poiché non vi furono la confisca e la redistribuzione delle terre, il sistema delle piantagioni si riprese grazie alla sostituzione del lavoro schiavistico con nuove forme di lavoro. All’inizio, si tentò col lavoro salariato, ma questo sistema fallì, in parte almeno perché i negri avevano la tendenza ad ingaggiarsi nei mesi fiacchi e a rendersi irreperibili al momento della raccolta del cotone. Ci si rivolse quindi largamente al sistema della mezzadria, che consentiva ai proprietari un maggior controllo sulla forza lavoro. Il mutamento fu significativo, in zone nelle quali non esisteva in precedenza una classe contadina.
Una caratteristica della situazione americana derivò dalla figura del commerciante di campagna, spesso un ricco piantatore. Dando a credito ai fittavoli e ai mezzadri generi di drogheria a prezzi assai più alti di quelli correnti, egli teneva sotto controllo la propria forza lavoro. I fittavoli e i mezzadri non potevano fare acquisti in nessun’altra bottega, poiché, scarseggiando di solito di denaro contante, dovevano acquistare a credito. La parte del proprietario era sempre talmente grande che il mezzadro viveva in debito perpetuo. Lo stesso accadeva anche per i fittavoli. In questo modo i legami economici sostituirono per molti negri quelli della soppressa schiavitù. È difficile dire di quanto migliorasse con questo mutamento la situazione dei negri, anche ammesso che un miglioramento vi sia effettivamente stato. Il quadro era completato dalle aziende che utilizzavano lavoro coatto di galeotti, guarda caso sempre negri, rinchiusi per le mancanze più insignificanti, naturalmente dopo regolare processo gestito da soli bianchi.
Lenin definisce il sud americano come «un ambiente chiuso, stagnante, senza aria fresca, una specie di prigione per i negri “affrancati”». Ancora nel 1915 afferma che «le sopravvivenze economiche dello schiavismo non differiscono assolutamente in nulla dalle sopravvivenze economiche del feudalesimo, e nella regione ex schiavista del sud queste sopravvivenze sono fortissime anche oggi».
L’effetto principale del mutamento sembra essere stato quello di
fare
dell’economia del Sud, ancor di più di quanto già non fosse,
un’economia
basata su un solo prodotto, poiché i banchieri facevano pressione sui
piantatori, e i piantatori sui mezzadri, affinché coltivassero prodotti
che potessero rapidamente essere convertiti in denaro.
La “Redenzione”
La ripresa politica procedette di pari passo con la ripresa economica, rafforzandosi l’un l’altra. Non v’è bisogno di riferire tutte le contorte e contraddittorie manovre politiche a cui si abbandonarono per acquistare influenza politica coloro che successero ai gruppi che avevano detenuto il potere nel Sud prima della guerra civile, sebbene valga la pena di osservare che gli scalawags, come vennero chiamati i sudisti che passarono al servizio del governo dell’Unione dopo la Guerra civile – o collaborazionisti bianchi, come potremmo chiamarli oggi – includevano numerosi piantatori, mercanti ed anche capitani d’industria.
Una grossa dose di violenza servì a rimettere i negri “al loro posto” e a ristabilire la supremazia dei bianchi (home rule). È di quest’epoca la nascita del Ku Klux Klan, che è solo una delle tante organizzazioni terroristiche che colpivano vigliaccamente i negri, quasi sempre disarmati e isolati, e che curavano di tenerli lontani dalle urne elettorali. Anche molti carpetbaggers (funzionari venuti da Nord, considerati in genere corrotti) furono “convinti” a tornarsene a casa.
Nel contempo, industriali e gruppi ferroviari stavano acquistando una crescente influenza nel Sud. In poche parole, i moderati e gli abbienti tornavano ad avere potere, autorità ed influenza nel Sud, come facevano anche nel Nord. Anche la pubblica opinione, non certo determinata dai negri, cominciava ad essere stanca del clima di tensione costante. I democratici del Sud riconquistarono (in quella che con gusto discutibile chiameranno “Redenzione”) uno Stato dopo l’altro fino a che, nel 1876, soltanto tre, Louisiana, Florida e Sud Carolina, rimanevano nelle mani dei radicali. Si andavano preparando le condizioni per un’alleanza tra questi due gruppi al di sopra della vecchia linea che li aveva divisi durante la guerra.
Le elezioni del 1876 furono tra le più combattute e violente della storia americana. Il candidato democratico Samuel J. Tilden di New York si affermò chiaramente con un largo voto popolare (anche se viziato dalle violenze sui negri negli Stati del Sud). Tuttavia i repubblicani misero in discussione i risultati di quattro Stati, venti voti elettorali; se tutti questi voti fossero andati al candidato repubblicano Rutherford B. Hayes, egli sarebbe stato eletto. La resistenza veniva soprattutto dai veterani dell’esercito, che non intendevano accettare quel risultato. Si arrivò persino a temere una nuova guerra. I pessimisti predicevano che quella sarebbe stata l’ultima elezione libera (e forse è stato proprio così!). Dopo mesi, un compromesso fu raggiunto. Il Sud avrebbe accettato la vittoria di Hayes, a condizione che questi, una volta al potere, avesse ritirato tutte le truppe federali dal Sud, nominato un uomo del Sud nel suo gabinetto e appoggiato sostanziosi stanziamenti per un programma di miglioramenti interni nel Sud. Hayes assunse la carica e le truppe federali furono debitamente ritirate. Era la fine della ricostruzione, ed era anche la fine di qualunque sforzo serio di proteggere i negri nei loro diritti costituzionali. Se ne riparlerà negli anni ‘60 del secolo successivo.
Il partito nordista della proprietà, della ricchezza e del privilegio abbandonò così le ultime pretese di farsi il sostenitore dei diritti della classe oppressa dei proletari negri. Quando gli “junkers” del Sud, non più proprietari di schiavi, ebbero accentuato in loro stessi i tratti della borghesia urbana, e quando gli industriali del Nord si trovarono a fronteggiare la protesta radicale del proprio proletariato, la classica coalizione conservatrice si rese possibile, e Termidoro venne a liquidare la “seconda Rivoluzione americana”.
La borghesia industriale e finanziaria del Nord non aveva bisogno
dei
negri, e li lasciò volentieri alle cure amorose degli ex schiavisti.
Essa,
dopo il tentativo di rivolgimento della società affinché tutta aderisse
al modello borghese liberal-democratico puro (anche se in questo mai
unita),
si era accontentata di avere raggiunto il fine principale della guerra
civile, quello di mantenere unita la federazione, condizione essenziale
a diversi scopi, tutti importanti: in primo luogo la borghesia si
garantiva
un mercato interno di rispettabili dimensioni, in tumultuosa crescita,
che avrebbe garantito uno sbocco per le merci che per ora non erano
ancora
competitive sul mercato mondiale; poi si assicurava un retroterra
pacificato
per poter arricchirsi e speculare con le immense possibilità aperte
dalla
conquista del West, ancora in corso; infine, poteva rivolgere la sua
attenzione,
forte di un paese sviluppato economicamente e posto in posizione
militarmente
favorita, a qualsiasi avventura imperialistica si fosse presentata. Già
nel 1865, a guerra appena conclusa, Grant, non ancora in gioco per la
carica
di Presidente, scalpitava per invadere il Messico, per sconfinare in
Canada,
per occupare Santo Domingo; fu lui a ordinare a Sherman di condurre la
campagna di vero e proprio genocidio nei confronti degli indiani, che
iniziò
proprio quell’anno.
A mò di conclusione
Soltanto la rivoluzione proletaria avrà coscienza di sé, e anch’essa nella coscienza collettiva del suo partito e non certo nella mente e nei desideri degli individui che vi parteciperanno. Tutti gli sconvolgimenti sociali, repentini o distribuiti su un lungo lasso di tempo, che hanno modificato in modo duraturo i rapporti economici tra gli uomini, e che noi chiamiamo rivoluzioni, hanno avuto luogo in virtù di una serie di azioni, di determinazioni, di condizionamenti che hanno spinto masse di uomini ad agire in un certo modo, in una certa direzione, tali da determinare il risultato rivoluzionario; determinazioni talvolta originatesi a grande distanza di tempo e di spazio, in modo che gli artefici dell’azione rivoluzionaria non si rendevano conto delle reali motivazioni del loro agire, e dei suoi reali risultati finali. Spesso chi aveva coscienza di parte delle motivazioni non partecipava all’azione, come nel caso dei grandi borghesi nella loro rivoluzione; questi però non mancavano di fornirne a chi doveva agire, rischiando magari la vita, di fasulle.
Anche la Guerra Civile Americana ha avuto bisogno di ideali, sia da una parte sia dall’altra; a Nord, si è combattuto anche per l’affrancamento degli schiavi negri, causa nobile se mai ve ne furono; e sicuramente ci sono stati degli uomini che hanno sinceramente voluto il bene dei negri. Eppure alla fine i negri americani si ritrovarono in condizioni di vita anche peggiori rispetto a quelle della schiavitù, se si fa eccezione per pochi fortunati.
L’abolizione della servitù sotto ogni forma, e la liberazione di tutte le forze produttive, è uno degli scopi principali della rivoluzione borghese. Eppure la borghesia nordamericana si fermò ad un certo stadio dell’impresa, anzi, fece qualche passo indietro, come abbiamo visto. Perché? Perché questa borghesia ritardataria e praticona non ha mai avuto la completa spinta rivoluzionaria tra le sue armi, e ha preferito accontentarsi di alcuni risultati vantaggiosi fondamentali: l’unità, una maggiore centralizzazione dello Stato, la mano libera nella politica commerciale e industriale, anche nella politica estera. Una scelta che, creando una situazione di potenziale scontro permanente, in altri casi avrebbe potuto costare cara, ma che in un paese come gli Stati Uniti è stata, come si dice oggi, vincente. Sì, si poteva forse fare la riforma agraria, ma con quali vantaggi? La riforma agraria ha come conseguenze, nella rivoluzione borghese, uno sviluppo delle produzioni e delle forze produttive, la creazione di nuovi strati sociali da contrapporre alle classi sconfitte che possono cercare di riprendersi il potere, la creazione di un forte mercato interno per la produzione industriale, un incremento della popolazione per accrescere il futuro esercito dei salariati (si sa che le terre distribuite passano presto di mano). Tutti vantaggi che erano già in buona parte garantiti dallo sviluppo all’Ovest, ove una classe di piccolo e medio contadiname era in rapido sviluppo in aree sempre più vaste, e dal tumultuoso afflusso di emigranti, che aveva ripreso forza alla cessazione delle ostilità.
Anche nei confronti della guerra la borghesia americana ha preferito seguire la strada più cruenta, il massacro di 700.000 giovani, in quattro anni di guerra, e distruzioni senza precedenti. Niente si fece per sollevare i negri del Sud; anzi, se si fosse profilata una mobilitazione dei negri la secessione non sarebbe nemmeno stata proclamata. Ciò avrebbe scatenato una massa di 4 milioni di disperati che avrebbe potuto prendere molte direzioni. Un esito anticapitalista era certo impossibile, ma la borghesia non ha mai inteso correre rischi ed è la paura che la domina sempre.
E non aveva torto: solo pochi mesi dopo la fine della Ricostruzione, segnata dall’insediamento di Hayes, il Paese avrebbe fronteggiato, nel luglio 1877, quello che prese il nome di “Grande Sciopero del 1877”. Messo a tacere per i successivi 80 anni il problema dei negri, si presentava sulla scena la questione sociale, del lavoro salariato, scatenata dalle conseguenze della grande crisi economica iniziata nel 1873, e le cui conseguenze si sarebbero fatte sentire per tutto il decennio. L’evento, che si potrebbe ribattezzare la “Grande Paura del 1877”, fu gestito con un generoso uso dell’esercito e della milizia, che non esitarono a compiere massacri di scioperanti, a sostituirsi agli operai nelle ferrovie, a proteggere i crumiri, a impedire con la forza raduni e comizi. La lotta, che in qualche caso prese l’aspetto insurrezionale, può essere considerata l’inizio della storia moderna del movimento operaio statunitense.
La sconfitta dei negri, della parte più debole del proletariato americano, fu la premessa della lotta all’ultimo sangue che il capitalismo di oltre oceano avrebbe sostenuto con la classe operaia delle città, soprattutto dell’Est e del Midwest, per la borghesia un avversario ben più pericoloso e agguerrito, anche se allora poco dotato di organizzazioni efficienti e decise. Il contenimento dei negri nel Sud, alla mercé dei loro ex padroni, li escluse nella stragrande maggioranza dalla classe operaia industriale; il loro posto fu preso dagli emigranti che arrivavano a frotte, spesso contadini analfabeti che parlavano una babele di lingue. I negri furono rinchiusi in quegli Stati che li avevano visti schiavi, e dai quali ben difficilmente potevano fuggire.
Alla fine, questa pagina di storia della borghesia che oggi comanda
il mondo si risolve in nient’altro che in un miserabile bilancio di
vantaggi
e svantaggi, di entrate e uscite monetarie e politiche; non è più la
borghesia che si immola sui campi di battaglia dietro la bandiera di
Cromwell,
o con le armate repubblicane della rivoluzione francese. Il risultato
finale
della guerra civile americana ben descrive la internazionale meschinità
oramai irreversibile della classe dominante, che ancora oggi impregna
di
sé, e contamina, la società umana.
––––––––––
Riproduciamo qui le più significative tavole esposte
ed illustrate, nelle due sedute, a completamento della relazione. Sono
state ricavate dalle opere: P.A.Toninelli,
Nascita
di una Nazione, 1993; D.B.Davis e D.H.Donald,Espansione e
Conflitto,
1987; Foner E., A short history of reconstruction,
1863-1877,
1990; Néré J.,
La guerre de sécession, 1992; Mitchell R., La
guerra civile americana, 2003; Testi A., La formazione degli
Stati
Uniti, 2003.
1. Espansione post coloniale.
2. L’avanzata della Frontiera.
3. Principali ferrovie al 1860.
4. Principali regioni del Sud secondo le caratteristiche fisiche del territorio e secondo le principali colture industriali al 1860.
5. Nord e Sud dopo il Compromesso del Missouri (1820).
6. La Secessione.
7. Le principali campagne della guerra civile.
Rapporto esposto alle riunioni a Firenze del gennaio e a Genova del
maggio 2004
I “Tripolini” del PSI
All’interno del Partito Socialista vi era una corrente, facente capo a Podrecca, Cabrini, De Felice, Trapanese, dichiaratamente favorevole alla conquista libica, conquista che avrebbe potuto contribuire a risolvere il problema dello sviluppo del meridione e la questione dell’emigrazione. In un telegramma inviato ai convenuti a Bologna, Podrecca non nascondeva quale fosse l’opinione di buona parte della destra del partito: «Constatai visitandola essere all’Africa riservato un grande avvenire. Sono favorevole in massima all’occupazione europea per ragioni di progresso, di civiltà, di umanità e nello stesso interesse del proletariato europeo e del proletariato indigeno. Esito a pronunciarmi nel caso specifico. Comunque io esorterei i lavoratori ad evitare manifestazioni impulsive in rispetto della serietà e complessità del problema, limitandosi ad esigere che in qualsiasi evento resti immutato l’indirizzo politico interno» (Riportato sul Corriere della Sera dell’11 settembre 1911).
Cabrini, senza mezzi termini non solo esplicitamente invitava i socialisti ad «augurare che la vittoria sorrida alle bandiere della nostra gente», ma, preso da eccitazione nazionalista, parlò della opportunità che «quando abbiamo notizia delle ingiustizie e delle infamie che si consumano in talune repubbliche sud-americane contro la nostra povera gente indifesa» intervenissero «mezzi sufficientemente energici come le corazzate» (Cabrini, Intervento al XII Congresso di Modena, 1911).
Un’altra corrente, di cui facevano parte Bissolati e Bonomi, pur avanzando riserve nei confronti della guerra italo-turca per ragioni di carattere internazionale, si dichiarava non contraria alle imprese coloniali. Nella prolusione tenuta all’Università di Roma il 30 novembre 1911, pubblicata a puntate su “Azione Socialista”, Gennaro Mondani, ordinario di storia coloniale e commerciale, affermava che la moderna lotta di classe non avveniva più, come nel passato, sul terreno della produzione, ma su quello della distribuzione, per cui interesse comune del proletariato e della borghesia sarebbe stato quello di promuovere tutte le iniziative atte ed incrementare la produzione, in particolare attraverso l’espansione coloniale. Il colonialismo veniva presentato come «fattore indispensabile dell’evoluzione economica dei paesi industriali». Partendo dal concetto di socialismo missionario di civiltà arrivava alla conclusione che il proletariato avrebbe dovuto aderire alla politica coloniale poiché vi era «contraddizione logica immane, non già fra socialismo e colonialismo, ma bensì fra socialismo ed anticolonialismo». Il colonialismo veniva inteso come tappa necessaria dello sviluppo capitalistico e come diritto della civiltà sulla barbarie. A conforto di questo concetto i bissolatiani si rifacevano ad una tradizione non estranea al socialismo italiano e risalente ad Antonio Labriola «che molti avevano la debolezza di presentare come teorico del marxismo in Italia» e che «in nome di una diffusione mondiale del capitalismo avanzato, base del socialismo, aveva difeso le conquiste coloniali» (Storia della sinistra, Vol.I).
Era l’anno 1902, il 13 aprile il Giornale d’Italia aveva pubblicato la famosa intervista rilasciata ad Andrea Torre dal Labriola, che iniziava la sua interlocuzione dichiarando: «Gli interessi dei socialisti non possono essere opposti agli interessi nazionali, anzi li debbono promuovere sotto tutte le forme. Gli Stati d’Europa sono in un continuo e complicato divenire, in ciò che ambiscono, conquistano, assoggettano e sfruttano in tutto il resto del mondo. L’Italia non può sottrarsi a questo svolgimento degli Stati che porta con sé uno svolgimento dei popoli. Se lo facesse, e potesse farlo, in realtà si sottrarrebbe alla circonlocuzione della vita moderna; e rimarrebbe arretrata in Europa. Il movimento espansionista delle nazioni ha le sue ragioni profonde nella concorrenza economica. Economia e politica non sono due cose separabili a volontà e artificialmente. La lotta tra gli Stati per quella che si dice sfera d’influenza o raggio d’azione viene dall’intima struttura degli Stati stessi, e il più delle volte è la condizione del loro progredire, e il modo di avverarsi della consistenza di loro (...) Da noi è frequente la declamazione contro la guerra, mentre abbiamo continuo il fermento della guerra civile a casa nostra: da noi si protesta sempre contro le espansioni, mentre mandiamo in tutto il mondo le forze vive dei nostri lavoratori in servizio del capitale straniero (...) Pochi vedono a fondo la gravità della situazione del nostro paese, che è come rinserrato ed assediato da tre potenze internazionali ad una volta. E dico dalla papale, che invalida i titoli della nostra unità; dalla capitalistica, che asporta dall’Italia i profitti commerciali ed industriali; e dall’operaia, che riduce in condizioni di inferiorità all’estero i nostri emigranti». Ad Andrea Torre che gli chiede se ritenesse “utile” la eventuale “impresa di Tripoli”, Labriola rispondeva: «Quanto all’utilità bisogna spiegarsi: certo che militarmente non ci compensa della minaccia che per l’Italia e sopra tutto per la Sicilia rappresenta la Tunisia armata dai francesi. La Tripolitania con tutta la Cirenaica è troppo in giù dalle grandi linee del Mediterraneo. Ma siccome non è ormai in poter nostro di togliere queste grandi linee né all’Inghilterra, né alla Germania, né alla Francia, non ci resta che accomodarci a Tripoli. Certo io sarei ben lieto che il nostro paese si trovasse nelle condizioni della Germania, che col suo capitale, con la sua industria, con le ferrovie che costruisce, senza colpo ferire e senza impiego d’un solo soldato, si sta economicamente impossessando della Turchia asiatica. Ma visto che non c’è di meglio...»
Nessuna meraviglia se l’intervista del Labriola, dieci anni più
tardi,
non solo venisse riportata alla luce ma addirittura fosse presentata
dai
socialisti filo-colonialisti come un vero e proprio programma politico.
Lo sciopero contro la guerra
Nel corso del precedente rapporto abbiamo messo in tutta evidenza come la risposta proletaria di fiera opposizione alla guerra di Libia nascesse del tutto spontanea e come il tricefalo Partito Socialista fosse stato costretto alla proclamazione dello sciopero generale al solo scopo di immobilizzare le masse lavoratrici. Il 25 settembre 1911 si erano riuniti a Bologna la Direzione del PSI, il Gruppo Parlamentare e la CGL. Tra chi dichiarava che il Partito non avrebbe dovuto prender parte al movimento antimilitarista, in quanto vedeva nelle agitazioni in atto solo uno stato convulsionario con il conseguente pericolo di una egemonia anarchica del movimento, e tra coloro che al movimento dichiaravano di dover partecipare per non perdere il contatto ed il controllo della base operaia, venne alfine trovata una soluzione accettata dalle tre componenti.
Il problema, in sintesi, era dunque quello di far sì che il proletariato non venisse fagocitato dall’anarchismo e nello stesso tempo non creasse grane al governo Giolitti. Il compromesso fu sancito dall’ordine del giorno Turati che, votato all’unanimità, esprimeva adesione allo sciopero generale contro la guerra, ma, nello stesso tempo, in anticipo minimizzava la portata dell’azione di classe: «Mentre consente al sentimento di protesta e di sdegno che anima oggi la manifestazione popolare, di fronte alla deliberazione presa dalla Confederazione Generale del Lavoro, invita i lavoratori organizzati a contenere nei confini della più severa disciplina e nei brevi limiti di tempo deliberati dalla Confederazione allo sciopero generale, il cui prolungarsi ed il cui trascendere a dispetto del sentimento dei suoi promotori non potrebbe oggi in Italia ottenere altro risultato che di rafforzare le correnti militaristiche e della reazione che conducono a Tripoli le nostre navi» (Avanti!, 26 settembre).
Date tali premesse, lo sciopero generale del 27 settembre non poteva che risolversi in una solenne sconfitta del proletariato. Senza una direzione ed organizzazione centralizzata; con la adesione di un Partito socialista e di una Confederazione Generale del Lavoro che si muovevano con lo scopo dichiarato di voler frenare le “intemperanze” proletarie; esposto, soprattutto nelle grandi città, alla pressione, non solo morale, di una opinione pubblica che la stampa aveva saputo orientare in senso filo-tripolino, lo sciopero fallì clamorosamente sia nei grandi centri industriali del centro–nord sia in tutto il mezzogiorno d’Italia.
Grande impegno alla manifestazione di protesta era stato prodigato dai quadri politici e sindacali periferici con buona riuscita nei centri provinciali e nelle campagne. In alcuni casi, come a Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Imola, Fornovo, Casalmaggiore, gli scioperanti impedirono il passaggio dei treni che trasportavano le truppe in partenza per l’Africa.
Mentre il Partito Socialista frenava il movimento operaio e la protesta di vasti strati popolari contro l’avventura militarista, gli anarchici, inneggiando al ribellismo individualista, di fatto lasciavano che la reazione statale si abbattesse sul proletariato in divisa che si trovava alla mercé del potere militare senza nessuna forma di organizzazione.
Alla vigilia della partenza per la Libia, alla caserma “Cialdini” di Bologna, il giovane muratore anarchico Augusto Masetti, al grido di “Viva l’anarchia! Abbasso la guerra!”, sparava al proprio comandante, colonnello Stoppa, ed incitava i commilitoni a fare altrettanto.
Nel manifesto diffuso dagli anarchici in cui veniva rivendicato il gesto di Masetti sono ben chiari tutti i limiti ideologici e l’impotenza pratica del movimento anarchico: si inneggia all’atto individuale che sublima l’eroismo del vendicatore dei torti subiti dalla classi oppresse e dalle popolazioni invase, ma è del tutto assente qualsiasi indicazione di organizzazione e di azione di classe. È l’elogio del martire che, a livello di classe, non serve a spronare all’azione, bensì a bloccarla.
Un cenno particolare merita la Federazione socialista di Forlì, all’interno della quale già allo scoppio della guerra italo-turca prevaleva la tendenza rivoluzionaria. Il 23 settembre, quando ormai fu chiaro che l’inizio delle operazioni militari sarebbe stato imminente, la Federazione socialista di Forlì pubblicò un manifesto di convocazione, per il giorno successivo, di un comizio contro la guerra. Gli oratori furono Benito Mussolini ed Umberto Bianchi, segretario della locale Camera del Lavoro. Malgrado la mobilitazione immediata e la richiesta di sciopero generale contro la guerra, dobbiamo però rilevare che gli argomenti toccati da Mussolini non erano stati tanto quelli dell’antimilitarismo rivoluzionario, quanto quelli classici del riformismo di sinistra: «Mussolini (...) provò, a base di cifre, che l’impresa tripolina può essere una millanteria nazionalista e guerrafondaia, ma costituisce un grande sperpero di capitali e di energie utilizzabili molto meglio a colonizzare i molti Tripoli dell’Italia contemporanea; esaminò quindi la questione dal punto di vista socialista e concluse con l’invitare gli astanti ad intensificare l’agitazione onde evitare la folle avventura» (citato in: R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario).
Il tema, tutto riformista, che «la civiltà” prima di essere esportata oltremare avrebbe dovuto essere portata nelle cento plaghe d’Italia era ricorrente in Mussolini. Uno tra i tanti esempi è l’articolo apparso su La Lotta di Classe il 10 settembre 1910 dove, in polemica con i nazionalisti, aveva scritto: «Noi avremmo compreso e forse guardato con simpatia un nazionalismo all’interno, un nazionalismo democratico-culturale di miglioramento, di raccoglimento e di rinnovamento del popolo italiano (...) Dovevano riflettere che prima di conquistare Trento e Trieste, c’è da portare l’acqua alle Puglie, le bonifiche sull’Agro Romano, la giustizia al Sud, l’alfabeto dovunque!».
Tuttavia, all’epoca della guerra di Libia, Mussolini, forse, rappresentava quanto di meglio il movimento rivoluzionario italiano era riuscito fino ad allora a selezionare. A questo proposito è illuminante quanto sta scritto nella nostra Storia della Sinistra: «Se ritorniamo per un momento al Partito Socialista Italiano, dovremo ripetere la constatazione negativa che, malgrado la lunga lotta della corrente rivoluzionaria per prevalere contro la destra, non si era mai giunti ad una formulazione completa della tattica del partito in caso di guerra, e soprattutto in caso di guerra europea generale. In materia di antimilitarismo, tali questioni erano state negli anni precedenti agitate sempre da anarchici e sindacalisti soreliani con indirizzi di falso estremismo, quali il rifiuto personale di obbedienza, l’obiezione di coscienza e simili, e nemmeno perfetto era stato il lavoro del movimento giovanile socialista, che pure per primo aveva saputo tenersi distinto dai libertari e combattere il riformismo quando ancora nel partito dominava». La sistemazione della teoria e della tattica marxista rivoluzionaria in un corpo dottrinario organico e compiuto avrebbe preso corpo definitivamente proprio in quegli anni cruciali. Non fu certo un caso che Mussolini ne sia rimasto fuori.
Ma torniamo ora al comizio del 24 settembre: esso si sciolse al grido di “Viva lo sciopero generale! Abbasso la guerra!”. Il giorno successivo si verificarono i primi scontri con le forze dell’ordine, la cavalleria caricò i partecipanti ad un comizio tenuto dal giovane repubblicano Pietro Nenni. Immediata fu la risposta con la proclamazione dello sciopero generale ad oltranza contro la guerra con relativo comizio nel corso del quale si alternarono oratori socialisti e repubblicani e con una partecipazione popolare alla manifestazione di circa 10/12 mila persone, secondo quanto riportato da La Lotta di Classe del 30 novembre 1911. Nel corso della giornata si verificarono altri vari scontri con la truppa e soprattutto a seguito del tentativo di impedire il transito dei treni militari. Il Prefetto di Forlì telegrafava al Ministro: «Verso ore 12 giunto questa stazione ferroviaria treno richiamati distretto Forlì, circa 3.000 dimostranti capitanati da noto repubblicano Pietro Nenni tentarono impedire loro presentazione locale distretto ostacolando il passaggio anche con scale ed attrezzi raccolti nei pressi: intervenuta truppa e cavalleria furono sbandati e chiamati poteronsi recare destinazione».
Il giorno 27 proseguì l’astensione dal lavoro, tanto più che per quel giorno la CGL aveva proclamato il famoso sciopero generale nazionale. Terminato lo sciopero generale, saggiamente anche la Camera del Lavoro di Forlì decise di porre fine all’astensione dal lavoro, salvo riprendere la lotta qualora fossero giunte notizie di “sanguinose repressioni”.
Mussolini, da eccellente polemista qual’era, scrisse un lungo articolo sull’andamento dello sciopero analizzando la manifestazione sia a scala nazionale sia a livello forlivese. Riaffermata la sua completa adesione alla pratica dello sciopero generale, «la più bella, la più intuitiva, la più terribile manifestazione della volontà operaia», e dopo aver tacciato i riformisti quali peggiori nemici del proletariato, passava ad esaminare le cause dell’insuccesso dello sciopero del 27 novembre. Queste venivano ravvisate sia nel ritardo con cui era stato proclamato, sia nella insincerità dei promotori definiti «ascari di Giolitti» e «fantocci impagliati». I riformisti venivano accusati di non avere proclamato lo sciopero generale ad oltranza («comica questa protesta con l’orologio alla mano») e di avere deprecato ogni atto di possibile violenza proletaria ancor prima che la lotta cominciasse, mentre le masse lavoratrici avrebbero dovuto essere incoraggiate e sostenute. «Nessuna meraviglia – quindi – se con questi ordini del giorno anodini, contraddittori, concorrenti, burocratici il fiasco dello sciopero generale politico ha assunto qua e là proporzioni colossali, sbalorditive, deprimenti». Passava quindi ad esaminare l’andamento della protesta nel territorio forlivese, dove lo sciopero era perfettamente riuscito rivelando «una nuova mentalità rivoluzionaria che va scrostando e spezzando il pacifismo riformista e calcolatore (...) Noi siamo stati i primi – continuava – a famigliarizzare gli operai con l’arma del sabotaggio (...) Gli operai hanno dimostrato con l’assoluta astensione dal lavoro e col sabotaggio ch’essi intendono tutta la portata rivoluzionaria dello sciopero generale (...) Anche i contadini hanno risposto meravigliosamente all’appello. Non uno ha mancato (...) Le giornate del 26 e 27 settembre resteranno impresse a caratteri di fuoco nella storia del proletariato forlivese» (La Lotta di Classe, 30 settembre 1911).
Per prevenire nuovi disordini e manifestazioni, che il prefetto di Forlì considerava inevitabili qualora vi fossero stati scacchi militari in Libia oppure un semplice richiamo alle armi di nuove classi, la polizia pensò bene di arrestare, il 14 ottobre, Mussolini assieme ai repubblicani Nenni e Lolli. Mussolini, oltre ad altri reati minori, venne accusato di istigazione alla violenza, resistenza alla forza pubblica, violazione della libertà delle reclute e degli esercenti, danneggiamento delle linee ferroviarie telefoniche e telegrafiche.
Il processo, celebrato presso il tribunale di Forlì, ebbe inizio il 18 novembre. Nel corso della prima udienza il rivoluzionario di Predappio pronunciò la sua autodifesa che si concludeva con la seguente “mussoliniana” dichiarazione: «Ebbene, io vi dico, signori del tribunale, che se mi assolverete, mi farete un piacere, perché mi restituirete al mio lavoro, alla società. Ma se mi condannerete mi farete onore, perché voi vi trovate in presenza non di un malfattore, di un delinquente volgare, ma di un assertore di idee, di un agitatore di coscienze, di un milite di una fede che s’impone al vostro rispetto perché reca in sé i presentimenti dell’avvenire e la forza grande della verità».
La sentenza, emessa il 23 novembre, condannava Pietro Nenni ad un anno e 15 giorni di reclusione e ad una multa di 500 lire; Benito Mussolini ad un anno di reclusione, Aurelio Lolli a sei mesi e 300 lire di multa. Le pene, a seguito dell’appello presso il tribunale di Bologna, vennero ridotte rispettivamente a sette mesi e mezzo; cinque mesi e mezzo; quattro mesi e mezzo.
Grazie a questa riduzione di pena Mussolini riacquistava la libertà il 12 marzo 1912, in tempo per preparare l’attacco contro l’ala ultradestra del partito che, al congresso di Reggio Emilia, sarebbe poi stata espulsa. Senza mezzi termini dichiarava: «Si tratta ora di amputare dal partito l’appendice radico-socialista già matura, anzi fradicia; si tratta di liberarci una volta per sempre dai tafani democratici che per un ventennio sono stati i nostri parassiti (la guerra di Tripoli ha rivelato ad oculos l’antitesi irriducibile fra democrazia e socialismo); si tratta di dare maggiore coesione morale e materiale ai nostri gruppi e alle nostre istituzioni (...) I giorni in cui il nostro partito dovrà mostrare la sua vitalità e le sue forze sono prossimi, prepariamoci dunque e gli avvenimenti non ci sorprenderanno (...) Chi contribuisce a valorizzare la sordida speculazione monarchica, chi segue Giolitti al Quirinale dev’essere eliminato dalle nostre file: bisogna avere il coraggio di squalificare pubblicamente e solennemente un pugno di uomini che prostituiscono il partito» (La Lotta di Classe, 23 marzo 1912)
L’ironia delle deterministiche situazioni materiali volle che,
quando
si presentò il preconizzato appuntamento con la storia, Mussolini si
trovasse
nella allegra compagnia di coloro che contribuivano a «valorizzare la
sordida speculazione monarchica.»
I giovani socialisti
Un apporto determinante alla sistemazione teorica dell’antimilitarismo nel quadro della tattica marxista rivoluzionaria venne senz’altro dato dai giovani socialisti che, già agli inizi del ‘900, avevano formato in numerose località italiane i loro circoli; circoli che a livello nazionale si erano organizzati in una confederazione la quale, a sua volta, fiancheggiava l’azione del Partito Socialista. Dopo la scissione della frazione sindacalista rivoluzionaria che, come conseguenza, provocò una spaccatura anche all’interno del movimento giovanile, la parte rimasta legata al Partito Socialista tenne il suo primo congresso nazionale a Bologna il 25 settembre 1907.
In questa occasione vennero, all’unanimità, stabilite alcune essenziali e caratteristiche linee di orientamento. Riguardo all’antimilitarismo «si affermò che si dovesse fare propaganda perché, nei conflitti fra capitale e lavoro, i soldati non eseguissero mai l’ordine di sparare sugli scioperanti, e circa l’azione internazionale ci si richiamò a quella dei partiti socialisti, pur invocando la possibilità di una simultanea azione dei soldati dei vari paesi belligeranti» (Storia della Sinistra, Vol.I)
Nell’agosto 1908, a Reggio Emilia, si svolse il II Congresso ed anche in questa occasione, sul tema dell’antimilitarismo venne enunciata la tesi della necessità di una «opera preparatoria del proletariato affinché sia pronto ad impedire le guerre ricorrendo a qualunque mezzo (...) in conformità ai deliberati del congresso di Stoccarda del 1907; richiamo tanto più notevole in quanto, al congresso del settembre dello stesso anno, il partito “adulto” non troverà neppure il tempo di discutere di “socialismo e antimilitarismo”, e Bacci dovrà quindi ritirare la sua mozione su questo tema, che d’altra parte non faceva cenno dei deliberati di Stoccarda, in cui non solo si chiamava il proletariato alla lotta contro la guerra, ma si legava indissolubilmente quest’ultima alla lotta per l’abbattimento della dominazione capitalista».
Al congresso di Firenze del 1910 i giovani socialisti tornarono ancora a precisare le loro posizioni sull’antimilitarismo: «La concezione borghese della patria altro non è che la giustificazione ufficiale dei delitti e delle nefandezze commesse dal militarismo attraverso la storia dei secoli», e ancora: «Intensificare maggiormente la propaganda antimilitarista e antipatriottica nelle famiglie, in modo che queste educhino i loro figli all’amore e non all’odio, in special modo fra i futuri coscritti, essendo infame e fratricida il figlio del popolo che spara sul popolo»; «combattere con tutti i mezzi la propaganda irredentista che cerca di spingere ad una guerra due grandi nazioni, e ricorrere a qualunque estremo pur di impedire l’assassinio legale di migliaia di esseri umani»; «far vive pressioni sul partito» per indurre il gruppo parlamentare «ad una attiva azione per la riduzione delle spese militari e a riaffermare le idealità antipatriottiche ed internazionaliste del partito socialista».
Il congresso di Bologna, del settembre 1912, seguiva quello socialista di Reggio Emilia. I giovani si schierarono all’unisono con l’estrema tendenza rivoluzionaria. Il congresso fu quasi totalmente assorbito dal dibattito sulla cultura, ma ciò non impedì che i voti antimilitaristi venissero confermati e che, all’unanimità, venisse espressa «l’avversione profonda alla nefasta impresa coloniale». Altro problema sollevato fu quello della propaganda socialista ed antimilitarista fra i proletari in divisa e, in modo particolare, «sulla costituzione del “Soldo al soldato” di cui tanto si sta preoccupando il governo, ma che funzionerà tra poco a dispetto di tutti gli ostacoli o delle minacce della borghesia militarista» (Avanti!, 28 settembre 1912).
È d’altra parte fuori di dubbio che senza l’aiuto del partito adulto i giovani socialisti poco avrebbero potuto fare sul piano pratico, anche e soprattutto in risposta alla guerra dichiarata. E quell’aiuto da parte del Partito Socialista non arrivò perché non poteva arrivare. Ormai da considerevole tempo il partito socialista aveva, quasi ovunque, attuato una tattica politica bloccarda i cui funesti effetti non mancarono di manifestarsi. Coalizzati con i partiti anticlericali borghesi, i socialisti non poterono battersi contro la guerra libica perché ciò avrebbe comportato la rottura di ogni alleanza con la borghesia imperialista.
L’amarezza di questo abbandono si può leggere in una lettera scritta dai compagni napoletani al giornale L’Internazionale di Parma: «Noi che contro la guerra, assieme ai giovani socialisti, abbiamo fatto quel poco che abbiamo potuto, non abbiamo mai trovato al nostro fianco né i sindacalisti né i socialisti “bissolatiani” di Napoli, i quali anzi ci hanno sempre attraversato la strada. Infatti finora a Napoli non si è fatta nessuna manifestazione contro la guerra, pubblica o privata, e quando si seppe che a Napoli sarebbe stata la sede del Corpo di spedizione, e i giovani socialisti convocarono alla Borsa del lavoro una riunione per un’intesa sull’azione da svolgere, il segretario della Borsa stessa, tra gli altri, ebbe a dichiarare che era inutile ogni manifestazione, poiché a Tripoli gli italiani erano attesi a braccia aperte, quali salvatori, dalla popolazione araba. I giovani rimasti soli, tentarono di tenere il comizio, ma tutto andò a monte e parecchi di essi furono arrestati» (23 marzo 1912). La lettera giungeva da Napoli ma rappresentava in maniera perfetta la politica di raffreddamento del conflitto sociale operata, a scala nazionale, dagli organi direttivi del PSI.
I giovani, da un capo all’altro del paese, intensificarono la loro azione antimilitarista ed antipatriottica con tutti i mezzi a loro disposizione e gruppi di propagandisti battevano cittadine e campagne per tenere, attraverso comizi e conferenze, alto e vivo il sentimento di avversione alla guerra, di mobilitazione e di agitazione per il ritiro dei soldati dall’Africa denunciando, tra l’altro, oltre alle morti dovute al combattimento quelle causate dalle spaventose condizioni della vita di trincea che facevano stragi di soldati. «Non si può restare indifferenti allo strazio di quei nostri fratelli le cui vite sono quotidianamente inghiottite dall’Africa maledetta. Perciò i giovani socialisti hanno il dovere di occuparsi di loro, nei loro comizi, a mezzo della stampa e con ogni altro mezzo che sia a loro disposizione» (L’Avanguardia, 2 giugno 1912). Veniva infatti lamentato che in larghi strati della classe lavoratrice non si fosse compreso il pericolo che la guerra costituiva per il proletariato. E tutto ciò si era verificato perché i socialisti non avevano «potuto o saputo renderla cosciente in tempo dei suoi veri interessi; e i proletari sono andati tranquillamente al macello. Noi avremmo dovuto dire alto e forte (...) che di partiti contrari alla guerra ce n’è uno: il nostro» (L’Avanguardia, 21 gennaio 1912).
Non venivano certo nascoste le enormi difficoltà e l’impossibilità di contrastare il monopolio del condizionamento delle opinioni attraverso la martellante e capillare azione dei mezzi di informazione, di propaganda, di persuasione e di controllo detenuti dalla borghesia. Questi dati di fatto erano ben noti e nessuno si illudeva di poter non tenerne conto. «Le basi della concezione rivoluzionaria riposano sul fatto che è impensabile nella società attuale, alla più gran parte degli uomini il formarsi una opinione politica. Sta formola della libertà di pensiero sarà un’ironia sanguinosa fin quando mancherà alla maggioranza degli uomini la libertà di sfamarsi. È perciò la classe degli individui ben pasciuti che può permettersi il lusso di pensare, e più ancora di far pensare agli altri a modo proprio. La terribile difficoltà della propaganda nostra sta in questo: noi dobbiamo ottenere che gli affamati pensino» (L’Avanguardia, 2 giugno 1912)
Altro fatto positivo fu il diffondersi di un orientamento di
rifiuto,
per ragioni dottrinali, della pratica di fusione con sindacalisti e
rivoluzionari
in genere, pur non rifiutando di intraprendere nella pratica azioni
comuni
di opposizione alla guerra.
Gli argomenti del pacifismo borghese
Precedentemente abbiamo messo in rilievo il fatto che Mussolini, pur chiamando il proletariato alla mobilitazione di classe ed incitandolo all’azione rivoluzionaria, nella esposizione delle motivazioni antibelliciste facesse largo uso delle argomentazioni tipiche del riformismo di sinistra. Questo era, in realtà, un tranello nel quale, specialmente nella foga oratoria e nella contrapposizione polemica con la propaganda nazionalista, era facile cascare. Inoltre c’è da dire che essendo concetti “facili” vengono immediatamente capiti e recepiti dalle masse e possono anche essere sufficienti ad accendere lo spirito di rivolta delle classi sfruttate. Ciò non toglie che l’uso di questi argomenti sia pericoloso e di questo pericolo si avvidero i giovani socialisti rivoluzionari che si sentirono in dovere di precisare quale uso, anche nella polemica, si dovesse fare di certe enunciazioni. «Quando noi diciamo che la guerra è dura e difficile, che la situazione diplomatica è oscura, che la colonizzazione tripolina è un mito, e che la conseguenza di tutto ciò sarà il danno e la rovina della politica e dell’economia italiana, non dobbiamo fare neanche supporre a chi ascolta che se la Turchia avesse ceduto in dieci giorni, e la Tripolitania fosse un Eden, questa guerra ci troverebbe meno avversi. Guai se questo si fosse verificato, per l’avvenire del proletariato in Italia!» (L’Avanguardia, 25 agosto 1912).
Un altro pericolo per il proletariato, e non meno grave della guerra, poteva essere costituito dalla “pace” successiva alla guerra. E, a questo proposito, la cosa migliore è di riprodurre in larga parte l’ottimo articolo intitolato "Tra Pace e Guerra":
«La borghesia è patriota per natura nella fase eroica della sua origine rivoluzionaria. Ed è patriota per calcolo nell’utilitarismo volgare della lotta per la sua conservazione contro il proletariato. In questa seconda fase la borghesia sfrutta abilmente le tradizioni della prima, per adescare il proletariato ad una tregua nella lotta di classe. Fa veramente male vedere dei socialisti cadere nel tranello. Sentire dei socialisti intellettuali andare a caccia del concetto marxista della nazione! Di fronte alla pace che i nazionalisti hanno definita vergognosa molti socialisti hanno esitato. Poi hanno riprese le staffe riconoscendo che non toccasse a noi piangere sul fallimento della bella gesta imperialistica, e che una pace gloriosa dopo una guerra fortunata avrebbe assestato un colpo terribile al movimento operaio.
«La nazione, nella realtà, è composta nella grande maggioranza dai proletari. Eppure l’interesse di essa (non l’interesse dei nazionalisti, ma l’interesse vero, reale della nazione) cozza con le aspirazioni del proletariato, non confondendo in questo nome qualche gretto miglioramento di categoria. È una contraddizione. Ma non è nostra, bensì di un assetto sociale in decadenza che ne presenta ben altre: il capitalismo.
«Ora i socialisti battono molto sul fatto che la borghesia deve pagare le spese della guerra. Ecco un’altra strada pericolosa. Supponiamo pure che si possa riescire ad ottenere qualche legge che aggravi un poco di più le classi abbienti nel sopperire alle spese di guerra. Sarà un magro risultato. Ma avremo fatto un gran male, generando un equivoco nella mente dei lavoratori. In realtà le spese della guerra le ha pagate e le pagherà il proletariato, che non è riuscito ad evitarla. Che cosa è la borghesia se non una minoranza improduttiva? E con che cosa “pagherà le spese” se non col ricavato dello sfruttamento sulla massa che produce? Sfruttamento che la rifioritura nazionalista le avrebbe permesso anche di intensificare, se la guerra fosse riescita secondo i suoi calcoli. Ora una campagna tendente ad ottenere che le spese di guerra siano prelevate dalle rendite dei capitalisti, anche ammettendo che nei risultati sposti di alcune decine di milioni il sacrificio proletario, avrà per conseguenza di compromettere quei sani concetti di antagonismo di classe, a tutto danno delle conquiste avvenire.
«Bisogna invece svolgere un’azione vivissima di propaganda, impostandola sul disagio economico del proletariato in conseguenza della guerra, per ottenere che “un’altra volta” esso sappia insorgere alla prima proclamazione della guerra. E battere in breccia il patriottismo vero e falso, affarista o romantico, sia che parli in nome delle forche di Tripoli che di quelle di Belfiore» (L’Avanguardia, 17 novembre 1912).
Sull’importanza, da parte dei socialisti, di non fare propri argomenti polemici comuni ad altre organizzazioni politiche il movimento dei giovani non si stancherà mai di ribattere:
«Troppo spesso avviene di sentire degli oratori, dei conferenzieri che si dicono socialisti e parlano a nome del socialismo, impostare le loro dimostrazioni su basi equivoche e che nulla hanno a fare coll’idea socialista, cercando di arrivare a questa per vie più o meno contorte, o tentare degli effetti coi motivi più accetti all’ambiente a cui parlano, anche se questi motivi sono al di fuori del pensiero socialista, facendo quasi sempre delle concessioni nella paura di urtare la folla con affermazioni troppo recise. La causa di questo comune errore non è in generale la mancanza di cultura, ma piuttosto il disordine di essa e l’influenza che esercitano sulla mentalità del propagandista teorie ed idee del pensiero borghese non bene confutate dalla stessa critica socialista. Ma il più delle volte la causa è, come abbiamo accennato, il timore di urtare il sentimento della massa, il desiderio di insinuarsi nell’animo degli ascoltatori, di vincerne le diffidenze; insomma, tutto un opportunismo che trasforma ciò che dovrebbe essere un apostolato in qualche cosa che ricorda troppo il mestiere del ciarlatano.
«Noi crediamo che il socialista non debba nascondere parte alcuna
del
suo pensiero, visto che egli sostiene che le sue teorie sono il
riflesso
delle condizioni reali di esistenza del proletariato. Se le cose che il
propagandista dice non trovano simpatia nella massa, vuol dire o che
egli
non ha la nozione esatta degli interessi di questa o che la massa è
stata
impressionata e imbevuta di idee antisocialiste dai partiti politici
borghesi.
Ebbene, noi diciamo che è un grave errore pratico rimediare
alla
propria inesperienza o all’ostilità dell’ambiente adattandosi a toccare
tasti simpatici a questo, attenuando la fisionomia del pensiero
socialista.
Il risultato immediato che così si ottiene dal facile consentimento
dell’ambiente
è sempre vano e passeggero, mentre un risultato duraturo non può aversi
che affermando schiettamente i principi del socialismo e cercando di
dimostrare
ai lavoratori il tranello in cui cadono ascoltando chi li spinge a
diffidarne»
(L’Avanguardia, 5 gennaio 1913).
Il Soldo al Soldato
Accennando al congresso di Bologna dei giovani socialisti ci siamo imbattuti sulla dichiarazione ufficiale della costituzione di una iniziativa dal nome un poco strano: Il Soldo al Soldato. Questa si rifaceva a quanto già sperimentato in Francia ai primi del ‘900 dalle Bourses du travail ed in Belgio dalle Giovani Guardie. In Italia questa iniziativa sembra sia da attribuirsi ai giovani socialisti piemontesi i quali, secondo un rapporto del Ministero dell’Interno, avrebbero operato «la prima concreta manifestazione a favore della cassa per il Soldo al Soldato» (Circolare del Ministero dell’Interno alle Prefetture del 18 gennaio 1913). L’iniziativa si riproponeva lo scopo di spezzare l’isolamento psicologico e politico dei militanti chiamati sotto le armi e di garantir loro continuità di informazione con l’invio di giornali, manifesti ed ogni altro tipo di pubblicazioni; inoltre, per quanto possibile, anche un’assistenza economica attraverso la costituzione di un fondo speciale al quale avrebbero dovuto concorrere tutti gli iscritti al Partito ed alle Camere del lavoro.
Il progetto doveva servire ad instaurare «una intensa comunione di idealità fra i rimasti ed i partiti, rapporti che dovranno spronare i coscritti a compiere un’altra opera: quella di penetrazione tra i soldati non socialisti, fra quelli che sono entrati nella caserma vergini da ogni idea politica, che non sanno cosa sia organizzazione, che ignorano la parola del socialismo, e peggio ancora che sono schiavi dei pregiudizi religiosi e patriottici» (Il Soldo al Soldato).
In un documento della Federazione giovanile del Piemonte si afferma: «Il giornale di classe che sarà spedito al compagno sotto le armi sarà l’amico, il consigliere, quello che gli ricorderà continuamente chi era e chi deve essere; il piccolo vaglia, poi, parlerà al suo cuore più di qualunque splendido articolo, la solidarietà personale, che sempre commuove e che non lascia dimenticare a chi si deve, lo farà considerare come un propagandista inviato in quel luogo per parlare ai camerati di quello che si svolge fuori della caserma, della lotta per la conquista dei diritti umani. L’azione demoralizzatrice della caserma verrà così neutralizzata e noi invece di perdere dei compagni ne acquisteremo altri» (Documento allegato a detta Circolare ministeriale).
Il Soldo al Soldato viene usato come opera di penetrazione permanente della propaganda antimilitarista all’interno delle caserme, e non più limitata a certe scadenze periodiche come succedeva per il passato. Questo perché «mentre imperversano su tutta l’Europa le follie bestiali del militarismo», ogni altro tipo di iniziativa avrebbe dovuto passare «in seconda linea di fronte alla necessità di resistere alla bufera che ci investe e che in Italia, con la guerra libica e con le repressioni poliziesche, ha celebrato i suoi peggiori saturnali» (L’Avanguardia, 14 settembre 1913).
Ai giovani socialisti in procinto di partire per il militare viene
consegnato
un piccolo vademecum:
«1. Il rivoluzionario che presta servizio militare deve anzitutto
cercare di suscitare lo spirito di critica e l’indisciplina tra i
commilitoni;
«2. Non bisogna rivelarsi rivoluzionario, anarchico, o sindacalista
o socialista: susciterebbe inutili diffidenze e paura. Bisogna agire,
operare
da rivoluzionario;
«3. Occorre partecipare alla vita di camerata, mescolarsi fraternamente
ai commilitoni, non trascurando mai di fare accortamente rilevare le
ingiustizie,
le incongruenze e le assurdità della disciplina e del regime di
caserma;
«4. Bisogna con prudenza studiare il carattere dei commilitoni,
propiziarsi
la simpatia e la fiducia di quelli che si dimostrano accessibili alle
idee
rivoluzionarie. È questo l’elemento da lavorare con la parola, con gli
opuscoli di propaganda, con la lettura dei giornali che si daranno
gratuitamente;
«5. Mantenersi in costanti relazioni con i militanti antimilitaristi
dell’organizzazione rivoluzionaria cui si appartiene prima di andar
soldato
e, se possibile, con infinita oculatezza, entrare in rapporto con i
compagni
sicuri della località ove s’è di guarnigione;
«6. A costoro rivolgersi quando occorre comunicare qualcosa al “soldo
per il soldato” e da loro far scrivere ciò che si vuole dai compagni
della “cassa del soldo”;
«7. Nel caso che non si possa fare diversamente, scrivere senza
firmarsi
e dirigere a qualche compagno poco conosciuto nel campo rivoluzionario
e in precedenza avvertito: costui si incaricherà di comunicare la
lettera
ai dirigenti del “soldo del soldato”» (Documento allegato alla
Relazione
della Prefettura di Bologna al Ministero dell’interno, 25 ottobre
1912).
Nel settembre 1913 viene pubblicato un breve opuscolo Il Soldo al Soldato edito per conto della Federazione giovanile socialista di Roma; in pochissimi giorni le 20 mila copie di tiratura vengono esaurite, in dicembre ne vengono stampate altre 15 mila, anch’esse distribuite in poche settimane. Il progetto viene sostenuto non solo dai circoli giovanili socialisti ma anche dai militanti anarchici e da altre organizzazioni antimilitariste rivoluzionarie; la stampa rivoluzionaria, L’Avanguardia, La Pace, il Rompete le File!, lo stesso Avanti! dedicano particolare attenzione alla situazione interna alle caserme, denunciano gli abusi commessi, lanciano campagne contro le compagnie di disciplina.
La diffusione e l’intensità delle iniziative antimilitariste suscitano allarme e preoccupazione presso le autorità militari e statali. Il Soldo al Soldato è ancora in fase di preparazione e già, a mezzo circolare (n. 21079 dell’11 luglio 1912) il Ministero dell’Interno dirama alle prefetture una prima, allarmata, segnalazione. Il 18 gennaio successivo è la volta di una seconda circolare, più specifica e circostanziata: «L’azione della cassa ‘per il soldo al soldato’ – vi si legge – si esplica mediante l’opera dei giovani socialisti chiamati a prestar servizio militare, i quali si incaricano della diffusione di giornali, opuscoli e fogli volanti di propaganda antimilitarista fra i commilitoni e portano il pensiero del partito nella vita quotidiana della caserma. Ad essi si corrispondono piccoli sussidi, per lo più quindicinali, con obbligo a ciascun sussidiato di diffondere lo spirito di critica e di indisciplina fra i soldati e specialmente fra le reclute».
Il Ministero cerca di correre ai ripari «seguendo, per via di confidenziali informatori, l’attività svolta in questo settore dalle varie sezioni socialiste» ed «eliminando il concorso della stampa sovversiva estera con i sequestri agli uffici postali di confine», ma si rammarica perché «il nuovo ingegnoso sistema escogitato dalla Federazione giovanile socialista sfugge in gran parte alle sanzioni del Codice penale, perché la distribuzione dei sussidi di per sé sola non riveste qualifica delittuosa» (citato in G. Oliva, Esercito Paese e Movimento Operaio). Alla vigilanza del Ministero dell’Interno si accompagna quella del Ministero della Guerra: il ministro Spingardi, con circolare riservatissima, sollecita i comandanti dei corpi d’armata affinché «all’interno delle caserme la vigilanza venga esplicata attiva, oculata, incessante e sia sempre integrata dalla più pronta azione repressiva, disciplinare e penale a carico di quanti si rendessero responsabili, e di provvedere in pari tempo perché fra gli stessi comandanti di corpo e le locali autorità politiche e di pubblica sicurezza siano scambiate tutte le segnalazioni che possano agevolare l’accertamento e l’identificazione dei colpevoli» (Circolare del Ministero della Guerra n. 300 del 6 febbraio 1913).
Con una successiva circolare il Ministero dell’interno torna sull’argomento ricordando ai prefetti che «i fatti sono di tale gravità da richiedere un più energico impulso all’azione» ed occorre pertanto «che con mezzi decisi, con attiva e oculata vigilanza e soprattutto senza discontinuità od esitazione siano interrotti i contatti fuori delle caserme tra le sezioni giovanili socialiste ed i soldati sussidiati» (Circolare del 20 gennaio 1913, n. 34696).
Il ministro Spingardi parla di «iniziativa che assume rapidamente proporzioni assai vaste e costituisce una grave, immanente minaccia alla compagine dell’esercito» (Circolare del Ministero della Guerra, 5 febbraio 1913). Gli fa eco il Ministero dell’Interno che denuncia «il rapido e sempre crescente sviluppo della propaganda antimilitarista che, nelle sue svariate forme, è davvero impressionante: le casse, i sussidiati, i propagandisti tra i soldati si moltiplicano ogni giorno, con effetto deleterio per lo spirito militare» (Circolare del 20 gennaio 1913, n. 34696).
Con il passare del tempo però, soprattutto per la mancanza di supporto del partito, si registra un certo abbassamento dell’entusiasmo iniziale, fanno seguito sempre più modesti risultati e le organizzazioni antimilitariste ammettono che le risposte sono inferiori alle attese.
Il Soldo al Soldato continua però a vivere ed a svolgere la
sua funzione praticamente fino allo scoppio della Prima Guerra
mondiale.
La guerra era già iniziata quando il Ministero dell’Interno segnalava
che «con i soldi tratti dalle casse per ‘il soldo del soldato’ i gruppi
giovanili socialisti, sindacalisti e anarchici intensificano ovunque la
propaganda antimilitarista» (Circolare del Ministero dell’Interno ai
Prefetti del 6 agosto 1914).
Sfegatato interventismo di intellettuali e studenti
«Il movimento comunista rivoluzionario – abbiamo scritto – annovera tra i suoi nemici peggiori con i borghesi i capitalisti i padroni, e con i funzionari e giannizzeri delle varie gerarchie, i “pensatori” e gli “intellettuali” indiscriminati, esponenti della “scienza” e della “cultura” della “letteratura” o dell’ “arte” accampate come movimenti e processi generali al di fuori e al di sopra delle determinazioni sociali e della lotta storica delle classi» (Battaglia Comunista, 4 maggio 1949).
Riguardo poi al periodo storico del quale ci stiamo ora interessando, in un altro nostro classico scritto affermammo: «Nel 1911, in Italia, fu celebrato il cinquantenario dell’unità nazionale attuata sotto la bandiera della borghesia sabauda. Il Partito Socialista, benché diretto in quel tempo da elementi di tutta destra, ebbe tuttavia il merito di invitare il proletariato a non considerare come proprie quelle manifestazioni che inneggiavano alla patria borghese, e in generale non inviò i propri rappresentanti. Gli studenti italiani, invece, più o meno inquadrati dai loro stessi maestri e professori, furono in prima fila in quelle manifestazioni tricolore. Del resto, essi negli anni precedenti e fino al tragico 1898, avevano plaudito alle deformi imprese coloniali contro cui invece il proletariato socialista seppe insorgere con moti coraggiosi anche di piazza. Nulla di comune ma solo termini di antitesi si pongono, a cavallo dei due secoli, fra studenti italiani e lavoratori italiani» (Il Programma Comunista, n. 8, 1968).
Proprio in quegli anni intenso si svolse il dibattito interno al partito, ma soprattutto all’interno della Federazione giovanile, fra “culturisti” ed “anticulturisti” dove i primi, facendo propria la concezione idealistica borghese, pretendevano che il proletario fosse sfruttato perché ignorante e che quindi la cultura rappresentasse un mezzo di liberazione e di avvicinamento al socialismo. A questa concezione piccolo-borghese si opposero tenacemente i giovani socialisti di sinistra e, in un articolo dal significativo titolo "Preparazione Culturale o Preparazione Rivoluzionaria?" si legge, tra l’altro: «La voce che si è levata dal nostro congresso è stata un’altra: venite a frotte, giovani figli del lavoro (...) venite a testa alta nonostante che i nostri e vostri avversari vi chiamino asini e straccioni, e mostriamo alla gioventù borghese degenerata nell’erotismo patriottico che la società nuova non sarà distillata dai loro cervelli corrosi dalla sifilide, ma edificata possentemente dalle nostre mani rudi e callose» (L’Avanguardia, 20 ottobre 1912).
Il capitoletto che qui segue si propone di mostrare la sifilide cerebrale della “classe intellettuale” italiana: studenti, professori...
La guerra di Libia fu l’occasione che diede al movimento studentesco ulteriore spunto e motivazione per esprimere il proprio patriottismo e la propria anima guerrafondaia.
Nell’imponente raduno di Roma del 1911, in occasione dello storico corteo del 20 settembre a Porta Pia, gli slogan che maggiormente vennero gridati non furono le tradizionali invettive contro il “papa re”, ma quelli di “Viva Tripoli italiana” e simili. A Roma anche gli studenti del Circolo universitario cattolico, appoggiati dall’episcopato e dalla stampa di ispirazione vaticana, festeggiarono «nel mese di novembre le ore grandi della storia, quando la patria celebra la vittoria e le aquile, di nuovo romane, garriscono ai venti d’Africa» (F. Malgeri, La Guerra Libica). A Milano gli studenti si scontrano con gli operai scesi in sciopero contro la guerra. A Napoli fra ottobre e novembre fanno ripetute manifestazioni contro la sede di redazione de La Propaganda (periodico di ispirazione sindacalista rivoluzionaria), ed a dicembre l’assaltano perché ritenuto colpevole di fare opposizione alla guerra.
A Palermo l’Associazione Monarchica Universitaria, L’Associazione Studentesca Cattolica e quella liberale organizzano concordemente comizi e manifestazioni di plauso al governo. A Siena gli universitari, assieme al professor Pietro Rossi, portano in trionfo fino alla stazione uno studente che parte per la Libia. Il giorno di Natale 1911 sbarca a Tripoli una delegazione universitaria che reca in omaggio alle truppe una pergamena con ventimila firme di studenti ed una colonna di marmo che dovrà esser posta a Sidi Messri per celebrare la vittoria del 26 novembre: la colonna portava incisa la seguente epigrafe: “Gli studenti delle università italiane agli eroi caduti per la gloria d’Italia” (P. Maltese, La Terra Promessa).
Dall’Università di Genova viene diramato l’invito agli studenti italiani di convenire, come già nel 1860, nella capitale ligure e da lì muovere assieme per celebrare, a Napoli, la “Nuova Italia” ed accogliere i confratelli reduci dalla Libia. Sono sempre gli studenti delle università di Napoli e di Messina che mandano a volteggiare sui turco-arabi due velivoli battezzati rispettivamente “Università di Napoli” e “Messina”.
Sono sempre gli studenti che cercano di trarre il massimo vantaggio dalla loro presunta condizione di eroi nazionali e non mancano di presentarsi alle sessioni di esame indossando la divisa del soldato. Questa pratica, che venne poi ampiamente sfruttata nel corso dei due successivi conflitti mondiali, fruttando esami e lauree di guerra, ebbe la sua inaugurazione al tempo dell’impresa di Tripoli. «Non è senza commozione – scriveva il rettore dell’università di Ferrara, Pietro Sitta – che in questi giorni di esami, noi assistiamo allo spettacolo di giovani che si presentano indossando l’onorata divisa del soldato» (citato in G. Cianferotti, Giuristi e Mondo Accademico di fronte all’Impresa di Tripoli).
Nemmeno a L’Avanguardia sfuggiva il fenomeno del patriottismo studentesco, ma, ovviamente, lo presentava con altri toni. Nell’articolo apparso con l’ironico titolo: "La Balda Gioventù Studentesca", si legge: «C’è una parte della nazione italiana che si è spontaneamente presa l’incarico della propaganda-réclame della grande gesta tripolina, portando la nota più istrionica nella gazzarra della solenne donchisciottata italica. Ed è la gioventù universitaria. Sono le “speranze della patria”; sono coloro che i borghesi ritengono l’avanguardia intellettuale della civiltà, l’oggetto di tanta retorica patriottica e... democratica. Non si sono assunti l’incarico più difficile né pericoloso. Gli altri versano il sangue, essi sprecano voce e fiato. Gli altri sono massacrati dal piombo dei turchi autentici, gli studenti si contentano di fare a cazzotti coi... turchi d’Italia». E dopo avere ricordato le eroiche gesta della goliardia, tra le quali vi era lo sport di rompere i vetri degli edifici universitari, l’articolo concludeva: «E sorridiamo di tali avversari. Non è su di essi che si regge la crollante società borghese. Non sono essi che fermeranno la rivoluzione sociale. Non sono neanche loro – purtroppo – che fanno la guerra. Sono i fratelli nostri, o lavoratori, che si fanno uccidere nell’interesse dei vostri veri nemici, i quali sbraitano: Viva la guerra! Perché la guerra è la prova che il proletariato non ha ancora aperto gli occhi alla luce della verità nuova: ma quando li aprirà, allora romperà qualche cosa di più alto dei vetri universitari» (L’Avanguardia, 26 maggio 1912).
In una successiva nota, riportata dallo stesso giornale viene espressa la protesta dei giovani socialisti «contro le chiassate indecenti degli studenti (...) che invece di gridare eroicamente: “Abbasso la pace!”, avrebbero potuto andare a rischiare la pelle in Libia, con assai lieve scapito della nostra coltura superiore. È utile rilevare – continuava la nota – che questi intellettualissimi giovani si lasciano trascinare come una mandria di pecore dalla stampa notoriamente venduta all’affarismo tripolino, ciò che prova una volta di più il valore meno che nullo, nella vita politica e sociale, di questa parte più colta della gioventù attuale. Invitiamo i giovani operai a reagire contro queste manifestazioni vergognose» (L’Avanguardia, 20 ottobre 1912).
Insomma, tra gli studenti l’entusiasmo per la guerra libica è generale; ma non dobbiamo dimenticare che una medesima esaltazione, e certamente più interessata, per la primavera di guerra e di potenza della nuova Italia commuove pure il cuore dei professori che in essa vedono i segni di quel tanto atteso rinnovamento intellettuale e morale di cui anelano essere i novelli banditori. Da un capo all’altro del Bel Paese «l’impresa libica riunisce intorno alla medesima funzione celebrativa docenti di tutte le università, cultori di tutte le discipline, adunati nello spazio unidimensionale della memoria storico-letteraria a ritrovare luoghi ed argomenti comuni (...) dalle odierne imprese alle gesta antiche e viceversa (...) Si ode ancora della romana letizia dei prodi che vanno incontro alla morte come se andassero ad una danza o ad uno splendido convito» (G. Cianferotti).
Quando nel 1911 si riapre l’Anno Accademico in tutte le università, dalle Alpi al Lilibeo, viene salutata la nascita della nuova Italia. Il 3 novembre 1911 è Francesco Ruffini, ordinario di diritto ecclesiastico nella facoltà giuridica di Torino a rivolgere riconoscente il pensiero ai «giovani che la volontà del paese ha strappato dai campi e dalle officine; ed ha avviati laggiù, fra le sabbie africane, con il compito immane di propugnarvi, di tutelarvi le fortune e l’onore dell’Italia»; a «quei giovani, i quali con la sola volonterosa e quasi gioconda disciplina con cui risposero al richiamo della patria, hanno già reso al nome dell’Italia un servigio di un pregio inestimabile».
Non da meno vuole essere il rettore dell’università di Padova, prof. Vittorio Rossi, che aprendo l’anno accademico augura «il ritorno dei trionfatori» alle «schiere che ancora combattono» per aprire «alla civiltà e alla vita della terza Italia (...) un nuovo lembo della terra africana». Quindi rivolge «ai prodi che di lor sangue gentile imporporano le barbare zolle, il tributo del dolore e del rimpianto fraterni, con l’animo dei forti che la sventura non abbatte, anzi esalta e sublima».
Il letterato Vittorio Cian, Professore dell’università di Pavia, deplora quegli ignavi studenti che «per amore del libro» disertano la spada nel momento in cui l’opera civilizzatrice dell’Italia si trova a contrastare da un lato l’«affaristica civiltà europea» e dall’altro «la delinquente irriducibile barbarie musulmana». E da dietro la sua cattedra invita la gioventù studentesca ad immergersi nel «salutare lavacro di sangue» per amore della «Patria, madre riconoscente, che assicura l’immortalità ai propri figli, votati al sacrificio per lei» (V. Cian, Patria e Guerra nella Letteratura Italiana, 1912).
Contemporaneamente, nel quadro delle celebrazioni per il cinquantenario dell’unità d’Italia, dal 12 al 18 ottobre 1911, si svolge a Roma il Congresso degli Scienziati Italiani. Tutti i discorsi di apertura non sono che un inno alla nuova espansione della «civiltà latina attraverso il mare».
Il prof. Luigi Credano, ordinario di pedagogia e Ministro della Pubblica Istruzione, orgogliosamente dichiara: «Noi oggidì possiamo affermare nel mondo la nostra dignità nazionale e chiedere un nuovo posto nella grande opera di incivilimento che le maggiori nazioni hanno assunto nelle terre fin qui non aperte alla luce del sapere, né partecipi degli innumeri benefici delle applicazioni scientifiche» (G. Cianferotti). Da parte sua lo storico Ettore Pais ricordava che «i mari in cui riecheggia il rombo dei nostri cannoni videro già le navi trionfatrici di Genova e Pisa. E contro le ancor barbare genti che si vorrebbero opporre alla rinnovata opera della nostra civiltà, lottò a lungo Venezia».
Ma colui che raggiunse le supreme vette della esaltazione della guerra fu il successore di Carducci alla cattedra di letteratura italiana presso l’Università di Bologna, Giovanni Pascoli. Nella sua famosa orazione tenuta al teatro di Barga il 26 novembre 1911, "La Grande Proletaria si è mossa", Pascoli, il socialisteggiante, sviluppa il classico concetto, comune a tutti i suoi colleghi, quello della romanità («O Tripoli, o Berenike, O Leptis Magna (...) voi rivedete dopo tanti secoli (...) le legioni romane») e dell’incivilimento («Ora l’Italia (...) dopo soli cinquant’anni ch’ella rivive, si è ripresentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all’aumento e incivilimento dei popoli»), ma, soprattutto, trasferendo il concetto di proletario dalla classe alla nazione, determina il punto di incontro tra le ideologie del sindacalismo rivoluzionario e del nazionalismo: «La nostra è guerra non offensiva ma difensiva»; per la difesa dei lavoratori italiani, per liberarli dallo sfruttamento e dall’ingiuria delle nazioni ricche del mondo («il mondo li aveva presi a opera i lavoratori d’Italia e più ne aveva bisogno più li trattava male (...) tanto che erano messi fuori dalla legge e dall’umanità»), per affermare il «suo diritto a non essere soffocata e bloccata nei suoi mari». In breve, nella dottrina del Pascoli la guerra serve pure ad abolire la lotta di classe, perché in guerra l’unica «lotta è a chi giunge prima allo stendardo nemico, a chi prima lo afferra, a chi prima muore. A questo modo là il popolo lotta con la nobiltà e la borghesia (...) Invero né là esistono classi, né qua».
Se i letterati e gli storici evocano le glorie imperiali di Roma, per non essere da meno i filosofi rammentano l’eterno vincolo che unisce la guerra alla vita («Una qualche forma di guerra continuerà sempre, perché la guerra è insita nella vita», B. Croce, Filosofia della Pratica).
I filosofi del diritto abbandonano le loro vecchie concezioni umanitarie e pacifiste ed abbracciano le teorie della guerra coloniale civilizzatrice facendo propria la tesi del repubblicano e filosofo del diritto Giovanni Bovio che, nel 1885, al tempo dei primi conati espansionistici italiani aveva esplicitamente dichiarato: «Per noi un diritto alla barbarie non esiste, come non esiste la libertà d’ignoranza, non la libertà di delinquere. Esiste un diritto fondamentale: quello che ha la civiltà di diffondere dovunque la sua potenza innovatrice come si diffondono la luce e il calore» (G. Bovio, Discorsi Parlamentari).
Igino Petrone, docente di filosofia morale all’università di Napoli, pubblicava, nel 1912, due lavori intitolati: Il Diritto di Guerra e La piccola Morale della Pace e la Grande Morale della Guerra. Nei suoi scritti il professore partenopeo si avvaleva dei principi di filosofia giuridica per giustificare il ricorso alla repressione più violenta e sfrenata per domare la resistenza indigena. Poiché, dice l’illustre professore, le orde turco-arabe «trasformano il pubblico e giuridico certame di guerra in un privato esercizio di brigantaggio e di depredazione», legittimano, da parte nostra, «il diritto di possanza, di violenza e di sterminio», espressione «della legge naturale della necessità e della difesa». I turchi e gli arabi non costituiscono uno Stato, ma un non-Stato, un’orda, non appartengono ai popoli «di civiltà e di cultura», sono «fuori del diritto internazionale, e non possono essere ammessi al trattamento giuridico che quello ha tentato d’instaurare nelle guerra fra gli Stati civili belligeranti».
Pian piano siamo finiti sul piano del diritto borghese. A Proposito di “Diritto”, il 26 ottobre 1911, a Roma, si era riunito il Congresso Giuridico Nazionale, vi presero parte più di 600 rappresentanti del Foro, della magistratura, dell’università. Gran parte di lavori vennero dedicati alla guerra di Tripolitania. Scrosci di applausi deliranti ed uditori che, in piedi, inneggiavano alle conquiste italiane facevano eco ai relatori che si alternavano alla tribuna. Carlo Ghirardini, dell’Università di Camerino, legittimava la conquista italiana argomentando la natura nullius di detti territori o, tutt’al più, soggetti alla sovranità di Stati nec pleni juris, come la Turchia che rimaneva sottoposta ai controlli delle potenze europee. La liceità dell’azione italiana sarebbe dunque derivata sia dalla imperfetta partecipazione dell’Impero ottomano alla società internazionale, sia dal riconoscimento delle potenze europee all’interesse italiano verso quei territori. Il senatore Adriano De Cupis propone un ordine del giorno, immediatamente approvato per acclamazione, con il quale il congresso «formula ardentissimo il voto che l’Italia, sorretta dal buon diritto, compia al più presto l’opera civilizzatrice intrapresa nella Tripolitania e nella Cirenaica sotto auspici tanto fausti e gloriosi».
Fin dall’inizio della guerra i giuristi italiani si erano interrogati sull’ordinamento da dare alla nuova colonia oltre al problema del futuro assetto fondiario, dal momento che la Libia avrebbe dovuto divenire una colonia di ripopolamento al fine di assorbire l’esuberanza della manodopera italiana. Tutti sembravano trovarsi d’accordo nella volontà e necessità di applicare e rispettare le leggi e le consuetudini locali.
A titolo di esempio valga tra tutti l’interpretazione datane da Francesco Filomusi Guelfi. Secondo il chiarissimo professore, in Libia non esistevano diritti di proprietà, mentre convivevano due tradizioni: la “romanista” e la “islamica”. Secondo le leges agrariae della Roma antica, tutto il territorio del nemico sconfitto apparteneva all’intero popolo romano ed il coltivatore era solo un usufruttuario che, in caso di cattiva conduzione, poteva venire sostituito, da parte dello Stato, con un altro che avesse adempiuto ai suoi doveri in modo migliore. Per il diritto musulmano la terra appartiene ad Allah e quindi al Sultano, suo rappresentante; anche in questo caso il coltivatore ha il semplice uso della terra che coltiva.
Nel rispetto di queste due tradizioni il Filomusi Guelfi dichiara che lo Stato italiano deve proclamare la proprietà di tutta quanta la terra libica ed affidare al Re d’Italia «successore legittimo del Sultano anche come capo ecclesiastico (...) la decisione su chi debba amministrare e coltivare i terreni». Dichiara poi che «essendo gli arabi per lo più pessimi coltivatori», dovranno essere sostituiti da contadini italiani. Nessuna preoccupazione avrebbe dovuto sorgere per le eventuali ribellioni dei nativi per questo modo di applicare “la tradizione islamica”, perché, come suggeriva il Prof. Francesco Ferrara, dell’Università di Siena, occorreva concentrare tutta l’attenzione «all’affermazione della nostra conquista, e la soggezione di quei popoli non potrà ottenersi che con la forza, con una ferrea ed inflessibile dominazione, non con bagoleggiamenti politici o diplomatici, con capi infidi per natura, per interesse, per religione. È questa una delle più pericolose illusioni, di cui dovrebbero spogliarsi i nostri governanti, se non si vuole che di quando in quando con inutile sacrificio, sgorghi sull’ara della patria sangue italiano».
Anche quando non si arriva, come il citato Igino Petrone, ad invocare «lo sterminio senza ritegno» delle «orde» turco-arabe, i giuristi italiani concordano tuttavia nel ritenere che le galere ed i lavori forzati siano la migliore cura per quelle popolazioni liberate dalla schiavitù e dalla ignoranza.
Mariano D’Amelio, già magistrato a Massaua, poi direttore generale del Ministero delle Colonie, parlava nei termini seguenti del «Regolamento carcerario libico», emanato il 22 giugno 1913 con decreto n. 841, e di cui, in buona parte, era autore: «La necessità del lavoro pel mantenimento e la rieducazione del detenuto e il risanamento del danno della parte lesa è il criterio fondamentale della “scienza penitenziaria” elaborata dalla scuola positiva e nelle carceri coloniali si impone comunque per le condizioni sociali ed economiche locali. Le prigioni italiane, coll’igiene indispensabile, col vitto regolamentare – una minestra e seicento grammi di pane di seconda qualità, bianco per i cittadini italiani e stranieri (art. 83) – le cure mediche e così via, sono dimora desiderabilissima pel beduino del deserto o pel troglodita del Garian o per l’abitatore della Sirte o del Fezzan. Chi conosce le condizioni incredibilmente povere di certe tribù (e costituiscono la maggior parte della popolazione libica), che vivono in una degenerazione fisica e morale abbiettissima, che sono ridotte a cibarsi dei grani d’orzo trovati nello sterco delle bestie, che non hanno vestimento e son piene di malanni, comprende la nessuna efficacia della pena del carcere applicata ai componenti delle stesse. Su ciò è inutile indugiarsi: col minacciare a gente simile la pena del carcere si diventa ridicoli (...) Ciò che caratterizza l’ordinamento coloniale – continua il nostro – è l’obbligo del lavoro imposto ai detenuti (artt. 63–70); lavori nell’interno del carcere o all’aperto, da svolgere per conto dell’Amministrazione o per conto di privati». Significativo è che il D’Amelio, parlando del lavoro forzato da applicarsi nelle carceri coloniali, puntualizzasse che questo avrebbe dovuto essere regolato da disposizioni tali da evitare «gli inconvenienti gravissimi cui lo stesso regime carcerario dà luogo in America», ossia quelle «disastrose condizioni dei detenuti americani» i quali, soprattutto se affittati all’industria privata, «si trovano in uno stato peggiore di ogni schiavitù» (G. Cianferotti).
Chiudere questa trattazione non vuol certo dire avere finito gli argomenti perché potremmo continuare all’infinito a citare il fior fiore della cultura italiana che si sdilinquiva sui valori della civiltà latina, sui lavacri di sangue, sulla rinascita dell’Italia, etc, etc.
Per onestà di ricerca abbiamo fatto anche una indagine in senso opposto, cioè abbiamo cercato quanti e chi furono gli intellettuali di una certa fama che non presero parte alla fiera del nazionalismo guerrafondaio. Siamo riusciti a trovarne quattro: Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Gaetano Mosca, Adolfo Omodeo. Può darsi che qualcun altro ci sia sfuggito, resta il fatto che fossero una esigua minoranza.
Gaetano Salvemini, in una serie d’articoli apparsi su La Voce e L’Unità svelò senza mezzi termini le falsificazioni dei suoi prezzolati colleghi, rivelando gli interessi economici che avevano spinto l’Italia in guerra e dissipando le illusioni di chi si aspettava di trovare nel “Bel suol d’amore” ricchezze e possibilità di lavoro per le masse affamate d’Italia. L’impostazione pacifista di Salvemini fu così chiara da non dare adito ad interpretazioni errate di sorta e ciò mandò in bestia l’ex sindacalista rivoluzionario, voltagabbana di professione, Arturo Labriola. Questi accusò il Salvemini di non comprendere l’importanza di questa guerra rivoluzionaria pedagoga di agguerriti proletari, condotta in nome della civiltà contro la barbarie, della libertà delle nazioni “minori” contro l’imperialismo “reazionario e plutocratico”. Ma, "Un Anno Dopo", questo è il titolo di un articolo scritto da Salvemini nel settembre 1912, il professore si scioglieva di fronte alla «bella prova di organizzazione e di valore data dall’esercito e dalla flotta»; di fronte al sentimento «del dovere e dell’onore nazionale» (L’Unità, 28 settembre 1912). Non più di una settimana dopo si rallegrava di nuovo della solidarietà di classe realizzata considerandola «un risultato benefico della impresa libica, di cui noi, che pur all’impresa siamo stati risolutamente avversi, abbiamo il diritto e il dovere di rallegrarci senza restrizioni» (L’Unità, 5 ottobre 1912).
Gaetano Mosca, in articoli pubblicati dal Corriere della Sera e da La Tribuna, aveva previsto le grandi difficoltà e gli immensi costi che gli italiani avrebbero dovuto sopportare in Libia per cui, diceva, «l’attivo non raggiungerà il passivo»; tuttavia ritenne che la guerra avrebbe rialzato il prestigio internazionale dell’Italia.
Anche Luigi Einaudi si dichiarò molto scettico su quanto lo Stato italiano avrebbe potuto ricavare dalla nuova conquista africana; però pure lui vi trovò aspetti nettamente positivi quali «il sentimento nuovo, severo, fatto di sacrifici e di sforzo» di solidarietà che determina «molti animi generosi ad una spedizione che è una altruistica opera di civiltà» (L. Einaudi, A proposito della Tripolitania).
Il pacifismo dell’Omodeo si basava, al contrario, su di un sentimento patriottico: «Il luogo comune del patriottismo nazionalistico, l’entusiasmo prorompente, smodato, offende questo mio amor patrio. Più che giubilo io provo angoscia per la mia Patria» (Lettera ad Eva Zona del 4 ottobre 1911). Ma un anno più tardi, in un’altra lettera, alla stessa persona, scriverà: «Ad ogni modo un grande lavoro s’è compiuto: un rassodamento della nostra unità, uno sviluppo della nostra potenza, un più onorevole posto nella politica estera si sono conseguiti» (A. Omodeo, Lettere 1919/1946).
L’articolo che di seguito ripubblichiamo apparve su “Critica Sociale” del 30 novembre 1891, un anno prima della fondazione del Partito Socialista.
La rivista, fondata da Filippo Turati, aveva visto la luce nel gennaio di quello stesso anno. Il vecchio Federico Engels, che riceveva regolarmente il periodico, in una lettera del 7 marzo, indirizzata a Turati, dichiara di non avere il tempo materiale per assicurare una collaborazione diretta, anche occasionale; stava infatti preparando delle nuove edizioni delle opere di Marx, “brochures” sue, ed aveva in cantiere il mastodontico lavoro di riordino dei manoscritti del Terzo Libro del Capitale. Declinava quindi il garbato invito rivoltogli, aggiungendo «Néanmoins je Vous souhaite le meilleur succès et je suis bien curieux de lire une bonne traduction italienne de notre Manifeste de 1847; et si vous trouviez qua tel ou tel autre de mes articles pourrait intéresser le public italien, je serais charmé de me relire dans votre bella e ricchissima lingua. E con stima La saluto. Federico Engels».
La lettura della rivista è semplicemente avvincente; al suo interno si svolge e prende forma, con un metodo dialettico che in un certo senso potrebbe rappresentare una prefigurazione del centralismo organico, un dibattito ideologico veramente improntato sui principi, sul metodo e l’azione di classe. Il lettore comunista rivive quell’epoca come se si trovasse all’interno della fucina del socialismo, dove, in un febbrile lavorio, ogni operaio è intento a forgiare parti diverse di quella unica macchina locomotiva che dall’anno successivo avrebbe avuto il compito di attraversare da un capo all’altro la penisola alla guida delle masse proletarie italiane: il Partito Socialista.
L’epoca storica dello sviluppo capitalista, come d’altra parte quella dell’organizzazione, delle rivendicazioni e delle conquiste proletarie, non pretendeva ancora la scissione tra l’anima rivoluzionaria e riformista del partito, anzi le due anime non esistevano affatto. Con la separazione dagli anarchici il partito risulterà unico ed unitario. La dissociazione avverrà in seguito, si effettuerà soltanto nel momento in cui il riformismo si trasformerà in collaborazionismo e rinnegherà il principio della lotta di classe per abbracciare quello della collaborazione interclassista.
L’articolo in quanto tale non ha bisogno di nessuna presentazione.
Il solo titolo è sufficiente a presentarlo. Senza mezzi termini
viene affermato che il problema della pace può essere posto e risolto
solo da un punto di vista di classe e viene ribadito con la massima
determinazione
e forza che esiste un unico metodo per opporsi e per scongiurare la
guerra:
quello di rafforzare l’organizzazione ed il partito socialista perché
il partito socialista è l’unico partito che si oppone alla guerra.
Tutto
il resto non sono altro che impotenti velleità dell’umanitarismo
borghese
condannate alla sconfitta o, meglio detto, che condannano il
proletariato
alla sconfitta.
“Critica Sociale”, 30 novembre 1891.
Non si tratta di volontà
(a proposito del Congresso nazionale operaio per la pace)
Che cosa sia uscito, o piuttosto non sia uscito, dai due Congressi per la pace già tenuti in Roma in queste ultime settimane – quello interparlamentare e quello delle Società per la pace – i nostri lettori lo sanno dai giornali quotidiani, ai quali noi non intendiamo fare concorrenza.
Ma ecco che le Società affratellate (mazziniane) convocarono in Roma pel 29 corrente un nuovo Congresso, il quale vorrebbe essere il complemento e un po’ anche il contraltare degli altri due. Il manifesto dice, fra l’altro, così:
«Inaugurandosi la conferenza interparlamentare per la pace e l’arbitrato, si affermò che il trionfo del nobile apostolato sarà conseguito allorché esso scenderà dall’altezza delle intelligenze privilegiate per farsi coscienza di popolo: noi crediamo invece che codesta coscienza sia formata, ma che abbia bisogno di organizzarsi per farsi volontà e diritto, sì da costringere i poteri pubblici ad uniformarvisi: per questa ragione – dopo la conferenza dei rappresentanti i diversi Parlamenti europei e dopo il Congresso dei delegati delle Società della pace, dove la discussione, per quanto feconda, era in parte paralizzata dai convenzionalismi tradizionali, dalle esigenze politiche e dagli interessi a cui sono legati la maggior parte dei loro membri – è più che mai necessario che il popolo si affermi. Vi invitiamo quindi a Congresso per discutere il problema della pace e l’arbitrato dal punto di vista militare, politico, educativo ed economico, colla certezza che le nostre discussioni e risoluzioni varranno ad organizzare in argomento l’affermazione di quella volontà popolare, il cui grido partì qualche mese fa anche dal Congresso operaio di Bruxelles, e che deve ripercuotersi ovunque, perché la pace fra i popoli possa diventare norma sicura della società».
E un nostro amico ci chiede: – perché non vi occupate un po’ più di proposito di queste belle e generose iniziative?
Il perché i nostri lettori lo possono indovinare fra le righe anche del nostro articolo Serietà innocua. A dir vero, non siamo così assoluti da escludere che un Congresso operaio, come quello annunciato, possa recare qualche utilità. Fra una società operaia che muove in processione a fare una bicchierata nel suburbio e una società operaia che va o manda al Congresso per la pace, preferiamo quest’ultima. Il moto, il fare qualche cosa, sia pure nel campo dell’ideale astratto, vale sempre più dell’apatia e della quiete supina. E non é detto che anche al Congresso delle Società affratellate qualche utile discussione non si faccia, qualche aspra verità non venga fuori; tutte cose che si risolvono in esercizio del pensiero e in educazione del sentimento.
Ma se noi non ci infiammiamo d’entusiasmo per coteste esercitazioni, e se non amiamo che il nostro giornale diventi il monitore ufficiale di cotesti movimenti, è perché siamo profondamente convinti – convinzione matura, figlia di esperienza e di riflessione – che le società operaie, per ora, abbiano davanti a sé qualche compito assai più necessario ed urgente.
Finché si tratta di “discutere” i vantaggi militari, politici, economici, ecc. della pace e dell’arbitrato, gli operai non potranno aggiungere verbo a quello che dottamente hanno già detto, scritto, predicato in proposito i professori, i deputati, gli avvocati, gli umanitari della borghesia. La loro non potrà che essere una traduzione – e forse una infelice traduzione – dei capitoli di un libro che è già alla sua centesima edizione.
Che la guerra, che il militarismo, che lo sciovinismo siano creazioni ed interessi borghesi, è cosa già detta e risaputa. Agli operai l’hanno insegnata già da un pezzo i borghesi medesimi. Non v’è nessuno, oggi, che metta in dubbio che, se la sorte dei popoli, invece che essere in mano dei principi, dei diplomatici, dei banchieri, dei politicanti, e in genere degli oziosi e vagabondi d’ogni grado e specie, fosse in mano del proletariato cosciente e militante, la guerra diverrebbe ipso facto impossibile e il disarmo la più pronta e la più facile cosa del mondo. Neppure le questioni più irritanti, la questione d’oriente, quella dell’Alsazia-Lorena, l’irredentismo italiano, ecc., ecc., conserverebbero alcuna potenza di minaccia seria. L’operaio non sente più quelle questioni, perché il suo bisogno e il suo ideale di emancipazione si sono di molto allargati e i confini nazionali, le barriere di razza e di lingua, nell’atlante geografico operaio, sono diventati punteggiature impercettibili.
Non si tratta dunque, secondo noi, di “organizzare le affermazioni della volontà popolare”. Si tratta più prosaicamente, ma più praticamente, di “organizzare le forze”.
Finché voi vi indugerete a riaffermare per la millesima volta che a tirarsi le fucilate si arrischia la pelle; che spendere miliardi negli armamenti è denaro buttato; che l’esercito è essenzialmente la difesa del privilegio economico contro i ribelli interiori; che il sacrificio della coscrizione, l’educazione della caserma sono cose immorali; che i popoli devono essere liberi dei loro destini; che alla difesa delle aggregazioni naturali e degli interessi reali delle masse basta il valore nativo degli interessati, educati ed istruiti da uomini e non sfruttati come bruti; sinché voi spenderete il vostro fiato a ripetere questi ed altri assiomi somiglianti, e il vostro inchiostro e i vostri francobolli a farli ristampare, voi mostrerete di fare un conto ben meschino della brevità della vita e del valore del tempo. Voi darete un’altra volta lo spettacolo dei cento, dei mila, che si affannano a dir di no, mentre c’è uno solo che s’industria a far di si e li volge in fuga tutti quanti.
Ma allorquando voi sarete organizzati in partito indipendente; allorquando conterete come classe, non solo nei certami dell’industria, ma eziandio nelle arene elettorali e legislative; quando insomma sarete veramente e in ogni senso una forza; allora il vostro voglio diverrà qualcosa più di una vana jattanza, allora sulla bilancia dei vostri politici destini porrete qualcosa più di un lieve scartafascio di sermoni e di ordini del giorno: vi porrete la spada di Brenno; darete, occorrendo, un buon pugno sul piatto dei vostri interessi. La bilancia traboccherà.
Fate l’ossa, fate i muscoli e i nervi nelle vostre battaglie: allora parlerete, e non ciarlerete, di pace.
Il Congresso di Bruxelles, alla cui autorità avete l’aria di domandare un passaporto, intese la questione della guerra propriamente così. Esso affermò che il problema della pace è un problema di classe, che le velleità umanitarie per sé sole sono condannate all’impotenza, che l’antidoto alla guerra è l’organizzazione socialista, che il partito socialista è il solo partito della pace. Quando gli operai tedeschi nel 1870-71 stesero la mano agli operai francesi protestando contro la conquista, essi non avevano bisogno che di essere un partito un po’ più numeroso, un po’ più potente, per vedere le due borghesie rinfoderare le spade.
Che se oggi il levarle del fodero è diventato un po’ più difficile a tutti i governi, è appunto perché sono cresciuti e di numero e di potenza quei partiti che potrebbero, e vi sono ben decisi, levarglierle dal pugno. La forza regge il mondo, non la sola forza materiale per fermo; ma l’idea, senza la forza, non riesce a organizzarsi a diritto. E il nemico interiore fa cercare le amicizie di fuori.
Finché non vi porrete ben di fronte ai vostri oppressori, finché essi potranno contare su di voi e voi dovrete cedere a loro, finché potranno tenervi legati mani e piedi al loro cocchio trionfale, non sperate che depongano le armi. Vi faranno essi stessi dei discorsi, vi lasceran fare dei Congressi a perfetta immagine e somiglianza dei loro: ben sanno quel che se ne cava. Ma le armi le terranno ben salde finché non gliele avrete strappate.
I primi che lo proclamarono non ebbero piena contezza di quanto
fosse
profondamente vero e suscettivo di nuove e diverse applicazioni
l’antico
ed oggi proverbiale aforisma: “Se volete veramente la pace,
preparate
la guerra!”
Il proletariato
italo-austroungarico
Quello che segue è un documento che, a quanto ci risulta, non è mai stato ristampato. Si tratta di un opuscolo redatto da "Battaglia Proletaria Socialista", Via S. Vittore al Teatro 5, Milano, stampato nel 1911, sempre a Milano, presso la Tipografia Coop. Operai. Oggi è visibile presso la Biblioteca Nazionale di Firenze.
Il testo era stato redatto in preparazione del Convegno Internazionale fra Socialisti d’Italia, Austria e Ungheria che si sarebbe dovuto tenere a Roma nel luglio di quell’anno, e che poi non ci fu.
Il documento non porta il nome dell’estensore o degli estensori e nemmeno si richiama al partito, a suoi organismi, comitati od altro.
Ma è ugualmente di grandissimo interesse perché, pure mostrando le debolezze dottrinarie dei documenti antimilitaristi dell’epoca, si pone lo scopo di analizzare in modo compiuto i vari aspetti e cause del militarismo borghese e dell’antimilitarismo proletario, senza niente concedere all’interclassismo.
Questo il sommario degli argomenti trattati:
La diplomazia del proletariato – Nazionalismo delinquente –
L’Austria
e l’Italia d’oggi – Il diversivo irredentista – Le aspirazioni
e la politica degli italiani in Austria – Il cancro che ci divora tutti
– L’affarismo, gli operai e l’opinione pubblica – I guadagni e
il patriottismo dei siderurgici – Se Italia piange Austria non ride –
l’Internazionale trionfa – I contrasti austro-italiani (Trieste, il
Trentino, l’Albania) – L’ipocrisia pacifista borghese e il proletariato
– Né guerra né pace armata.
"Battaglia Proletaria Socialista", 1911.
Strinse fratelli insieme
Slavi Alemanni ed Itali
Un duolo ed una speme.
(Goffredo Mameli, nell’Ode a Roma, 1847)
La diplomazia del Proletariato
I lavoratori socialisti d’Italia, Austria e Ungheria, che si raduneranno nel prossimo luglio a Roma, compiono il primo grande atto positivo di politica internazionale proletaria che registri la storia. È vero che noi abbiamo sempre sentito affermare dai nostri maestri che il partito socialista è internazionale nei suoi fini e nei suoi strumenti d’organizzazione; è vero che nei nostri programmi sta scritto l’abolizione dei confini e delle frontiere per l’affratellamento di tutte le genti del lavoro, ma è anche vero che contro di noi e vicino a noi si è spiegata dai partiti borghesi in tutti i paesi un’intensa propaganda per rendere sempre meno effettive e reali quelle intimità di rapporti tra socialisti delle varie nazioni che tutte le borghesie paventano come la maggiore loro disgrazia. E questa propaganda fatta col mezzo della grande stampa è riuscita per qualche tempo ad influire anche nel partito socialista diffondendo la persuasione che l’Internazionale socialista sia soltanto una bella chimera e che nella vita pratica d’ogni giorno ciascun partito socialista miri a fare entro i confini della propria nazione il proprio interesse senza affatto curarsi degli effetti e delle ripercussioni che ciò possa riprodurre negli altri stati. Ne è venuto che il partito socialista, costretto a vivere e a muoversi in un’atmosfera così falsa – si mostrasse sempre meno pronto e vigile ad intendere gli alti interessi dell’internazionale operaia, lasciando adito al convincimento che in effetto il grande ideale che sorrise ai maestri e agli apostoli della nuova rivoluzione operaia, fosse tramontato per sempre.
Orbene questo convegno italo-austroungarico, viene in buon punto a
dimostrare
che i sogni e le speranze di tutti coloro che hanno interesse a tener
divisi
i popoli e a rinfocolare gli odi tra le nazioni, sono fallaci. Il
proletariato
d’Italia e d’Austria-Ungheria è arrivato finalmente ad intendersi
e ad affratellarsi, vincendo gli ostacoli che gli erano creati dalla
stampa
e dai partiti militaristi e nazionalisti. Col convegno del prossimo
luglio
esso scrive la prima pagina di quella nuova diplomazia che pretende di
poter risolvere tutte le controversie che fossero per sorgere tra
nazione
e nazione, senza ricorrere alla guerra, senza fare assegnamento sulla
forza
armata.
Nazionalismo delinquente
Ma con quest’atto d’onestà e saggia politica i partiti d’Italia e d’Austria-Ungheria vengono altresì a porsi recisamente contro quel torbido e convulsionario nazionalismo che uno scrittore – G.A. Borghese – definiva un ostacolo per la civiltà, e che reca molestie e danni a tutte le nazioni. Perché il nazionalismo è un malanno di tutti gli stati moderni e dovunque ha recato i suoi malefici effetti. Esso è il presupposto necessario, l’alleato indefinibile del militarismo; la sua giustificazione politica, la sua spiegazione sentimentale. Perché è il nazionalismo che coltiva e attizza gli odi fra i popoli diversi di lingua e di razza; è il nazionalismo che fa balenare sempre il pericolo di rovine imminenti per la patria; è il nazionalismo che crea quello stato di morbosa esaltazione sciovinista, per questo un uomo non sa più amare il proprio paese senza nutrire livori, invidie, antipatie, sentimenti di dispregio, per i paesi vicini. È quindi questa multiforme azione del nazionalismo che sbocca necessariamente nei programmi di grandi armamenti, di flotte formidabili, di leve in massa, che costituiscono la vera e giusta rovina delle nazioni.
Contro dunque questa forma di delinquenza politica, che è il
nazionalismo,
si accampa la manifestazione internazionalista di Roma, a testimoniare
che una nuova concezione patriottica sorge dalle rovine del vecchio
ciarpame
retorico e declamatore: il proletariato dimostra coi fatti di sapere
tutelare
gli interessi ideali e le ragioni di tutte le nazionalità,
contemperandoli
e armonizzandoli nella fratellanza internazionale.
L’Austria e l’Italia d’oggi
Spieghiamo ora perché il Convegno si fa soltanto fra socialisti italiani e austro-ungheresi, anziché allargarsi ai socialisti di tutto Europa.
Ecco.
Mentre un congresso internazionale non avrebbe potuto che occuparsi di questioni generali e teoriche senza curarsi dei problemi più particolarmente interessanti i singoli gruppi di nazioni, un Convegno così limitato permette ai socialisti italiani ed austro-ungheresi di intendersi su quelle controversie che pei militaristi d’Italia e d’Austria sembrano destinate a risolversi a colpi di cannone.
Da qualche anno a questa parte in Italia come in Austria si parla
con
troppa insistenza dell’inevitabilità di una guerra. Nessuno non ha mai
saputo dire perché dovesse scoppiare, ma è incontestabile che se n’è
parlato e se ne parla ancora a bassa voce o a voce alta a seconda
consiglino
l’ambiente e le circostanze, tanto in Italia che in Austria. Beninteso
che sono sempre i partiti politici che esprimono e rappresentano
interessi
e ideali borghesi, perché il popolo tanto in Austria che in Italia si
è sempre mantenuto estraneo a codeste montature, ma è certo che di tale
febbrile preparazione guerresca il popolo ne sopporta e ne sopporterà
le conseguenze: oggi con le opprimenti spese militari, domani col
sacrificio
dei migliori suoi figli quando il conflitto fosse scoppiato.
Il diversivo irredentista
Tutti avranno osservato che le dimostrazioni irredentiste scoppiano in Italia a periodi fissi.
Si lasciano passare i mesi e gli anni nel più assoluto silenzio, e nella più strafottente indifferenza per la condizione dei nostri connazionali, cosiddetti irredenti, eppoi, a certi momenti, si vedono i giovanetti della borghesia disertare le scuole, raccogliersi per le strade, schiamazzare evviva ed abbasso di cui non si vedono sempre la ragion logica e la spiegazione politica. Noi abbiamo connazionali e fratelli di lavoro sparsi per tutto il mondo. Sono la ricchezza d’Italia, gli emigranti laboriosi e coraggiosi che si sono avventurati per terre sconosciute, per paesi di diversa lingua, a cercare lavoro meglio rimunerato che non in patria.
E lavorano talvolta in condizioni penose e tristissime, sopportando come in Argentina ogni sorta d’angherie. Ma a nessun irredentista è mai passato per la mente di promuovere in patria manifestazioni stradaiole di solidarietà e di difesa per quei nostri fratelli abbandonati all’avidità sfruttatrice dei capitalisti.
Noi abbiamo anche, attorno all’Italia, oltre ai connazionali
soggetti
all’Austria, gente che parla la nostra favella, come nel Ticino, nelle
province di Nizza e di Savoia, in Corsica, a Malta, ma non è mai
successo
di vedere dimostrazioni irredentiste a favore di quei nostri
connazionali.
Come si spiega questo fatto?
Prima di tutto perché verso l’Austria riesce più facile suscitare i sentimenti d’odio tradizionale che vivono sempre nell’animo di tutti gli italiani che ricordano le sofferenze patite dai nostri avi prima del riscatto nazionale. Ma l’intermittente scenata austrofoba prende più specialmente di mira l’Austria per ragioni d’indole essenzialmente economiche.
Con la Svizzera, con la Francia, con l’Inghilterra, l’Italia non ha né potrà mai avere ragioni di conflitti economici, perché mentre la piccola Confederazione elvetica non ha soverchia importanza di concorrente nel mercato mondiale, la Francia e l’Inghilterra dispongono di vasti continenti aperti all’esportazione dei loro prodotti, l’Italia e l’Austria si trovano invece spesso a contendersi i mercati dell’Oriente, dalla penisola Balcanica fino al mar Egeo e i gruppi capitalistici dei due paesi hanno interesse a lottare per sbarazzarsi l’un l’altro il passo. Questi disegni di una parte del capitalismo austriaco ed italiano combaciano magnificamente con gli scopi del militarismo di qua e di là dell’Isonzo.
L’irredentismo diventa così l’ingrediente migliore per le cupide e losche imprese che si combinano in Borsa e nei circoli militari, tra una partita di bigliardo e uno scambio di lettere galanti...
Né basta. Che l’irredentismo è anche un magnifico diversivo, che
serve ai fini della politica di classe seguita dai partiti borghesi e
dalle
cricche affaristiche d’entrambi i paesi. Mentre infatti il popolo si
accende per i fratelli irredenti che gemono e spasimano sotto il
bastone
dei croati (questo è il cliché di tutte le pagliacciate
oratorie
dell’irredentismo) dimentica di lottare, qui in patria, per redimersi
dalla condizione di servaggio in cui lo tengono preti, soldati e
padroni,
che rinnovano e continuano con l’altra forma le gesta maledette dei
croati
dei tempi passati.
Le aspirazioni e la politica degli italiani in Austria
E almeno l’irredentismo esprimesse davvero i sentimenti e le aspirazioni della maggioranza degli italiani che vivono in Austria, potremmo giustificarlo pur sentendo di doverlo ugualmente combattere. Ma nessuno ignora che tutta la gazzarra che si fa dalla studentesca spensierata quando grida: Guerra all’Austria, non trova alcuna vibrazione di consenso e di solidarietà presso gli italiani dell’altra riva. I quali hanno tante opinioni e seguono tante bandiere quante sono le diverse classi sociali cui appartengono. Ci sono anche là i ricchi, i poveri, i ceti medi, che trovano l’espressione dei loro bisogni d’ordine economico, politico e morale, nei vari partiti politici. Ci sono i clericali, i conservatori, i liberali, i socialisti, gli anarchici, i repubblicani, e ciascuno di questi gruppi segue le direttive politiche del proprio partito. Ma nessuno di costoro – se ne togliamo qualche scarso gruppetto di repubblicani, giovani sincerissimi senza dubbio specialmente nell’odiare i socialisti – vuole sinceramente annettere la regione Giulia all’Italia.
Non i clericali che sono fedelissimi e devotissimi sudditi del Governo imperiale e venerano nel vecchio imperatore l’unico monarca cattolico e bigotto, pronto sempre ad aiutare il clericalismo e il papato; non i liberali e i conservatori rappresentanti delle classi ricche, dei ceti industriali e commerciali che fanno a Trieste e in tutta la regione adriatica i loro affari valendosi della posizione privilegiata in cui trovansi rispetto al mare, e considererebbero come la più grande iattura il vedere il loro porto, oggi affollato da merci e mercanti del nord, compreso entro i nuovi confini dell’Italia, quindi costretto a lottare in concorrenza con Fiume e Venezia che trarrebbero vantaggio dal mutamento; non i socialisti e gli anarchici pei quali le frontiere non corrispondono alle divisioni statali volute dai popoli, bensì imposte dalla violenza soldatesca, né trovano ragione per cui si debba provocare un cataclisma europeo solo per consentire agli italiani dell’Austria di cambiare padrone, passando dalla monarchia asburghese a quella di Savoia.
Che se si volesse chiedere a questo proposito un’opinione ai tanti italiani – operai e contadini che sono fuori dei partiti politici, e uniformano i loro atteggiamenti solo alle loro condizioni economiche e sociali, noi li sentiremmo rispondere che preferiscono rimanere dove sono e come sono, perché tutto sommato, in un cambiamento avrebbero più da perdere che da guadagnare.
Intanto va notato che in tutte le campagne, del Trentino, come dell’Istria e del Friuli orientale, il clero è potentissimo e fa eleggere in quasi tutti i collegi politici i suoi rappresentanti. E il clero, si sa, ubbidisce al papa; pratica la sua internazionale nera e vede nell’Italia monarchica d’oggi, l’usurpatrice del potere papale. I contadini italiani ubbidiscono ai preti, e appunto per ciò sono selvaggiamente anti-italiani, come chi scrive ha più volte potuto constatare.
Ma oltre questo, le masse che vivono fuori dei partiti, sanno d’essere meglio assistite e difese dalla legislazione di Stato. Da più di un quarto di secolo, frequentano la scuola fino a 14 anni (i mamalucchi dell’irredentismo non sanno che la percentuale degli analfabeti tra i barbari sloveni è di poco superiore a quella del nostro Piemonte!) [In Carniola , provincia esclusivamente slovena, è del 23 per cento!] hanno un’amministrazione di Stato che funziona bene, pur s’intende ubbidendo ai criteri politici di chi la dirige; quando sono ammalati c’è la tassa distrettuale che li cura, li assiste e li sussidia, hanno i loro tribunali industriali che funzionano davvero – contrariamente di ciò che avviene pei nostri probiviri – e risolvono ogni genere di controversie tra padroni ed operai; adesso per gli impiegati c’è l’assicurazione obbligatoria per la pensione ai vecchi e agli invalidi, c’è il suffragio universale per le elezioni politiche, l’indennità ai deputati, ai sindaci, agli assessori comunali, vivono insomma in un ordinamento politico e sociale che, confrontato con quello vigente ora in Italia, fa esulare ogni proposito... irredentista.
Tuttavia gli italiani di tutti i partiti e di tutte le classi sociali viventi in Austria, hanno un interesse comune da difendere: ed è la diffusione e l’incremento della coltura italiana, che elevi il livello intellettuale di tutti i figli della stirpe, e fortifichi la loro posizione in confronto delle altre insieme con la quale sono costretti dalla natura a vivere.
Ma per soddisfare questi superiori bisogni di coltura e di forza morale, provvedono egregiamente le lotte economiche che migliorano la posizione materiale specialmente degli italiani poveri, e quelle scuole superiori culminanti nelle Università, che tutti gli italiani – almeno a parole – sono d’accordo nel volere.
Per chi dunque e a vantaggio di chi s’improvvisano ogni qual tanto
le parate irredentiste? L’abbiamo già detto: Per le borghesie
capitalistiche
– fino ad un certo punto – e per le cricche militari e affariste
prosperanti
all’ombra del cosiddetto amor patrio, e dell’idealismo nazionale.
Il cancro che ci divora tutti
Valgano alcune cifre a dimostrarlo.
In questi ultimi cinque anni le spese militari – navali e terrestri – sono salite ad altezze vertiginose in tutti i paesi del mondo.
Ma in ogni nazione si trova un pretesto... patriottico per imporle al pubblico. In Inghilterra si dice: Bisogna difenderci dalla Germania. In Germania si dice: Difendiamoci dall’Inghilterra. In Francia si agita il pretesto tedesco, e tra i tedeschi s’insiste sui propositi revanchisti dei francesi.
E altrettanto dicasi per l’Italia e per l’Austria.
Ciò non toglie poi che tutti i governi si dichiarino pacifisti, e facciano buon’accoglienza ai platonici voti per la pace.
Restringendo dunque il campo delle nostre osservazioni alle due nazioni che sono poste di fronte – Austria e Italia – noi troviamo delle cifre spaventevoli.
In cinque anni, dal 1905 al 1910, le spese militari sono quasi raddoppiate.
Mentre nel 1905 in Italia il bilancio della Guerra superava di poco
i 200 milioni, e quello della marina i 150, oggi si hanno le seguenti
cifre:
| Guerra. Bilancio 1911-12 | £. | 396.066.200 |
| Consumo rendite patrimoniali (capitolo 66) | “ | 539.000 |
| Consumo di patrimonio (allegato 7) | “ | 6.000.000 |
| Contributo del bilancio interni (capitolo 32) | “ | 15.370.000 |
| Progetto 695. Miglioramenti a personale | “ | 134.200 |
| Progetto 735. Pei carabinieri raffermati | “ | 1.090.160 |
| Progetto 749. Miglioramenti ai carabinieri | “ | 2.839.250 |
| A carico bilancio esteri per l’Africa, circa | “ | 8.000.000 |
| ––––––––––––– | ||
| Guerra totale | £. | 430.038.810 |
| ============= | ||
| Marina. Bilancio 1911-12 | £. | 192.345.000 |
| Spese per Cina e Mar Rosso | “ | 2.050.000 |
| Progetto 749. Miglioramenti a personali | “ | 67.700 |
| Progetto 734. Riduzione di ferma a 3 anni | “ | 1.060.000 |
| Progetto 750. Miglioramenti a sottufficiali | “ | 1.250.000 |
| Progetto 746. Nuove spese generali | “ | 7.000.0000 |
| Progetto 746. Nuove spese per costruzioni navali | “ | 10.000.0000 |
| ––––––––––––– | ||
| Marina totale | £. | 213.772.700 |
| Guerra | “ | 430.038.810 |
| ––––––––––––– | ||
| Insieme | £. | 643.811.510 |
| ============= |
Se calcoliamo che le spese generali dello Stato sono previste dalla recentissima relazione del ministro Tedesco in 2 miliardi e 410 milioni, crediamo che per l’Esercito e per la Marina, noi diamo il 26,50 per cento, vale a dire che per ogni cento lire spese dallo Stato italiano, all’esercito e alla marina vanno lire 26,50. Più del quarto. E non è finito. Che si sono già chiesti altri 50 milioni da iscriversi nei due bilanci successivi al 1911-1912 per rifabbricare la batterie d’artiglieria che si vollero costruire pochi anni fa sebbene i competenti in materia avessero avvertito il Governo che commetteva un errore. E ai 50 milioni per le artiglierie bisognerà aggiungere altri 319 milioni domandati dal ministro della Marina il 24 gennaio u.s. da consumarsi, 41 subito e gli altri negli anni successivi al 1912. Questa spesa non è stata ancora approvata, ma è certo che il Governo – comunque sia composto – non oserà contraddire alle richieste dell’Esercito e della Marina se non si troverà contro una fortissima opposizione nel parlamento e nel paese.
E da chi dunque sono goduti, tutti questi milioni, che pur costano al popolo italiano tanti sacrifici, tanta nutrizione di meno, tante rinunce forzate?
Prima di tutto bisogna ricordare che attorno ai bilanci militari
vive
tutta una folla d’ufficiali di vario grado, che in questi ultimi anni
è anche riuscita a migliorare sensibilmente la propria condizione come
risulta da questo prospetto:
| STIPENDI | Nel 1904 |
Nel 1911 |
| Generale | 15000 | 15000 |
| Tenente generale | 12000 | 12000 |
| Maggior generale | 9000 | 10000 |
| Colonnello | 7000 | 8000 |
| Colonnello dopo sei anni di grado | 7700 | --- |
| Tenente colonnello | 5200 | 6000 |
| Idem dopo sei anni di grado | 5720 | --- |
| Idem dopo cinque anni di grado | --- | 7000 |
| Maggiore | 4400 | 5000 |
| Idem dopo sei anni di grado | 4840 | --- |
| Idem dopo cinque anni di grado | --- | 5500 |
| Capitano | 3200 | 4000 |
| Idem dopo sei anni di grado | 3520 | --- |
| Idem dopo dodici anni di grado | 3872 | --- |
| Idem dopo cinque anni di grado | --- | 4400 |
| Idem dopo dieci anni di grado | --- | 4800 |
| Tenente | 2200 | 2400 |
| Idem dopo sei anni di grado | 2420 | --- |
| Idem dopo dodici anni di grado | 2662 | --- |
| Idem dopo cinque anni di grado | --- | 2800 |
| Idem dopo dieci anni di grado | --- | 3500 |
| Sottotenente | 1800 | 2000 |
Ricordiamo che il numero degli ufficiali delle varie armi di terra e di mare ascende in Italia a circa 20 mila, pensiamo che ogni ufficiale ha una famiglia, e delle relazioni d’interesse e noi subito comprenderemo come attorno a questo famoso idealismo patriottico si sia formata una rete vastissima d’interessi materiali che costituiscono il nucleo centrale del partito che vuol i grandi eserciti, la nazione forte e temuta.
Ma attorno a questa fittissima trama di tornaconti e di lucri, si muovono e si agitano i divoratori più veri e maggiori del danaro dello Stato. Sono i grandi costruttori di navi, i proprietari ed azionisti dei grandi stabilimenti metallurgici che si dividono in porzioni esatte la grossa torta della forniture militari e delle costruzioni navali.
E sarà interessante dar rilievo alla circostanza che la maggior parte dei milioni stanziati per l’Esercito e per la Marina sono spesi nell’Alta Italia, dove appunto notiamo con maggiore frequenza le esplosioni d’irredentismo.
Dove sono spesi infatti i milioni per l’esercito e per la flotta?
Ecco:
Ci sono in Italia 9 cantieri privati e 5 di Stato.
I cantieri privati sono i seguenti: Ansaldo, Odero, Fiat San Giorgio, Riva Trigoso, Muggiano (tutti nella riviera ligure) Orlando (Livorno) Pattison (Napoli) Cantieri Riuniti (Palermo) Acciaierie (Terni). I cantieri dello Stato sono a Spezia, Castellammare di Stabia, Taranto, e Venezia.
Ad eccezione del cantiere di Riva Trigoso che è inoperoso, tutti gli altri sono riusciti ad ottenere in questi ultimi anni commissioni per grasse forniture.
Ora, come non vedere che questo blocco d’interessi costituisce la
forza maligna che turberà sempre la pace e la serenità dei rapporti
internazionali
per giustificare le richieste di nuovi armamenti?
L’affarismo, gli operai e l’opinione pubblica
Comprendi bene, o mio lettore, come attorno ad ognuno di questi arsenali e cantieri si agiti tutto uno sciame d’appetiti, di voracità, di cupidigie, che ha bisogno di somme spaventevoli per essere soddisfatto.
Il militarismo, e la politica dei grandi armamenti, diventeranno così i preziosi alleati delle industrie siderurgiche che in loro troveranno alimento e nutrizione. Gli azionisti degli stabilimenti e dei cantieri privati; i fornitori delle materie prime degli arsenali di Stato, sono tutti ugualmente interessati a far vedere che è necessario battere la strada dei grandi armamenti e delle mostruose costruzioni navali. Ma siccome non potrebbero andare in piazza o al Parlamento a dire brutalmente: Vogliamo che la Nazione si armi per dar lavoro ai nostri stabilimenti, così ricorrono alle manovre subdole che si compiono per mezzo della grande stampa che è quasi tutta in mano dei grossi sindacati industriali, per gettare nel pubblico notizie sensazionali ed allarmanti, e talvolta si servono anche degli operai e delle loro organizzazioni. Sicuro. Poiché nei cantieri statali e privati lavorano migliaia d’operai, così è frequente il caso di vedere gli operai di Terni, di Spezia, di Livorno, di Venezia, di Palermo, di Napoli e degli altri luoghi nei quali sorgono stabilimenti siderurgici, inscenare dimostrazioni e proteste, abilmente sfruttate dai loro padroni, per strappare allo Stato sempre nuove concessioni e favori.
Il concetto che lo Stato abbia obbligo di offrir sempre nuovi piatti ghiotti ai signori patriottissimi costruttori di nave e fabbricanti di corazze è così entrato nei nostri costumi politici che anche recentemente, presentando alla Camera il progetto di legge che domanda nuovi crediti navali, il ministro Leonardi-Cattolica metteva avanti come uno dei motivi principali la necessità di assicurare un continuo e ben distribuito lavoro alle nostre industrie siderurgiche!
Ma c’è niente di più iniquo di ciò? Ma non è evidente tutta l’ingiustizia di questo concetto? Se allo Stato spetta l’obbligo di far lavorare gli operai, perché non si fa organizzatore anche delle altre industrie, dell’agricoltura, delle miniere, di tutte insomma le grandi intraprese? Se riconosce necessario far lavorare gli stabilimenti e i cantieri che creano gli ordigni maledetti di rovina e di strage, buoni solo a far del male, incapaci a rendere il benché menomo servigio civile alla società, perché non provvede a disciplinare le industrie che rendono servizi utili e benefici inestimabili a tutti? Egli è che lo Stato e il suo Governo non si propongono di servire gli interessi generali della maggioranza della popolazione, ma solo di piccoli gruppi audaci e potenti che sanno imporre i loro criteri di favoritismo e di protezione, servendosi talvolta delle stesse miserie degli operai.
Ma il più umile dei lavoratori, purché non sia un imbecille o un
corrotto,
comprenderà facilmente che questa voluta assistenza a favore delle
industrie
siderurgiche, lungi dal far del bene agli operai, è una delle cause di
maggior rovina, perché siccome è lo Stato che paga, come vedemmo, le
somme favolose per dar lavoro agli stabilimenti e ai cantieri
navali,
e gli operai che lavorano in questi stabilimenti e cantieri non
ricevono
niente più del loro meschino salario quotidiano, che potrebbero del
resto
benissimo guadagnare anche in altre industrie, è evidente che coi
milioni
e coi miliardi carpiti soldo per soldo al popolo italiano sotto forma
di
dazi doganali e d’imposte dirette e indirette, si garantiscono gli alti
stipendi agli ufficiali superiori e i grossi dividendi delle aziende
industriali.
I guadagni e il patriottismo dei siderurgici
E che i signori siderurgici italiani facciano degli ottimi affari, lo dicono i bilanci delle rispettive Società che sono esaminati da Luigi Einaudi in un articolo uscito nel fascicolo 2° di febbraio de La Riforma Sociale. Negli ultimi quattro anni l’Elba ha dato rispettivamente il 7,10, il 10, il 12 e l’8%; le Ferriere Italiane l’8, il 10, il 10 e il 6%; la Savona l’11, il 12, il 12 e il 12%; finalmente la Terni il 24, il 18, il 13 e il 13%.
Ma i bilanci delle Società siderurgiche sono poi giusti? Chi non sa che ogni Società capitalistica fa risultare quegli utili che vuole per sottrarli alle unghie del fisco?
Certo i guadagni ci sono e lauti, perché a nessuna industria accorrono i capitali quando questa sia disastrosa. E in questi ultimi anni l’industria siderurgica italiana ha allargato la sua sfera d’azione, specialmente dedicandosi alle costruzioni navali e militari. E badate che l’industriale costruttore non si ferma entro i confini della Nazione. Egli cerca lavoro dove ne trova, e accetta ordinazioni da qualunque parte vengano. Infatti, nella relazione presentata al Consiglio della Società Anonima Ansaldo-Armstrong nell’Assemblea degli azionisti tenutasi nel marzo u.s., si leggono questi interessanti periodi:
«L’impresa da noi assunta di costruire per la R. Marina la corazzata Giulio Cesare e di consegnarla, completamente allestita con le corazze e le artiglierie che ci saranno fornite dalla R. Marina, promosse, in specie nella seconda metà dello scorso esercizio, sufficiente lavoro nel Cantiere di Sestri. Alla costruzione di questa nave ci siamo dedicati colla maggior sollecitudine e con tutto l’impegno per corrispondere alla fiducia che il Governo ha in noi riposto assegnandocene la fornitura. In quest’anno procederemo al varo, e nel 1912 termineremo la nave. Altri lavori sono pure in corso a Sestri Ponente. Il Cantiere, coadiuvato dagli altri Stabilimenti ha continuato a costruire l’incrociatore per l’Impero Ottomano, la nave cisterna Eridano ed il rimorchiatore Titano, che vareremo tutti nell’anno in corso, insieme a sette torpediniere ordinateci dalla R. Marina. Sul finire del 1910, abbiamo assunto dal Governo Cinese la fornitura di un cacciatorpediniere: la costruzione è già iniziata. La conclusione di questo contratto vi dimostri che noi continuamente ci occupiamo per ottenere lavoro dall’estero.
«La lotta contro i grandi cantieri esteri è forte: ma noi confidiamo che con l’aumento dei nostri mezzi di produzione, mettendoci in condizione di non dover più dipendere da altri per la fornitura di navi da guerra complete, potremo raggiungere sempre migliori risultati.
I nostri tre stabilimenti di Cornigliano, Elettrotecnico, Fonderie ed Acciaierie e Metallurgico Delta, hanno avuto sufficiente lavoro e discreto fu altresì il lavoro in locomotive nello stabilimento di Sampierdarena, che ne consegnò 63 nel corso del 1910 e ne ha in lavorazione altre 58. L’Italia, festeggiando il cinquantesimo anno della sua unità, dimostrerà, con l’Esposizione di Torino, i progressi fatti dalla sua industria. Noi stiamo preparando la Mostra della nostra Società ed abbiamo fiducia che resterete soddisfatti della prova che daremo alla Patria, della potenzialità dei nostri mezzi, della varietà ed importanza dei nostri prodotti».
Vedete dunque che il patriottismo dei nostri industriali siderurgici non conosce confini o barriere. Dà le navi e gli incrociatori così all’Italia come alla Turchia e alla Cina, come domani li darebbe alla Germania e all’Austria senza affatto preoccuparsi se con quelle costruzioni militaresche le nazioni committenti possano un giorno muovere in guerra contro di noi.
E come fa l’Ansaldo-Armstrong, così fanno l’Orlando, l’Odero, il Raggio, le Terni, il Muggiano, la Pattison; e il Krupp dalla Germania non manda cannoni, corazze e obici a tutte le potenze che comprano e pagano? E così fanno in Francia le officine del Creuzot e le industrie inglesi; e l’Ungheria manda da Weiss all’Italia i forni in ferro e i carri da campagna; e la Skoda austriaca fabbrica e vende all’Italia macchinari, caldaie ed altri strumenti accessori per l’armatura delle navi, e ancora la stessa Austria ci dà il legname per i grandi scafi, i cavalli e i foraggi per i nostri reggimenti di cavalleria e d’artiglieria, senza preoccuparsi di sapere se quei cavalli galopperanno un giorno contro i suoi soldati nelle pianure friulane, e se le nostre navi completate co’ suoi macchinari bombarderanno le sue coste...
Il capitalismo non ha ritegni e scrupoli patriottici. Esso fabbrica,
vende e compera, seguendo l’unica legge del suo interesse. E le fisime
idealistiche le lascia ai poeti e ai letterati. E va più là ancora:
perché
mentre esso non conosce tenerezze e riguardi di sorta e mette senza
scrupoli
le navi ch’esso costruisce in mano agli eventuali nemici della patria,
domanda poi al sentimento patriottico dei popoli, di condannarsi a
vivere
nella miseria, nell’abbrutimento, nella quotidiana rinuncia, per dare
a lui i milioni e i miliardi da divorare…
Se Italia piange, Austria non ride
Che il militarismo e il capitalismo – trafficanti sulla dabbenaggine e sulle ingenue dimostrazioni studentesche, siano un cancro che divora e rovina tutti i paesi, è cosa ormai accettata da tutti. Ma a noi deve premere di vedere quali disastrosi effetti produca questa delittuosa politica, nei due paesi che si vorrebbero spingere alle mani e cioè: Italia e Austria. E poiché sappiamo già a quale misura ascendano i malanni che procura il militarismo a noi in Italia, diamo un’occhiata all’Austria, e ci persuaderemo che se qui si piange di là non si ride.
Cominciamo dal numero di persone che compongono l’esercito e la marina da guerra e che l’Austria-Ungheria deve pagare, vestire e mantenere.
Le cifre e le notizie che seguono sono tolte dalla Relazione sul Preventivo Comune discussa alle Delegazioni nella seduta del 2 marzo 1911 a Budapest.
L’ordinario dell’esercito austro-ungarico per l’anno 1911 comprende: 22.915 graduati, 2.087 ufficiali ed aspiranti impiegati, 278.975 uomini di bassa forza, 5.940 allievi ed accademici militari, 62.116 cavalli ed animali da soma. In confronto al 1910 si nota un di più di 493 graduati e 1.484 cavalli ed animali da soma, ed un di meno di 340 ufficiali ed aspiranti e 1.266 uomini.
Lo straordinario contempla: 26 graduati, 4.365 uomini, 540 animali da soma. Per i comandi della Bosnia-Erzegovina sono previsti poi: 590 graduati, 28 ufficiali ed aspiranti, 4.423 uomini e 2.375 cavalli. Il numero complessivo dell’esercito austro-ungarico viene ad essere, di 314.773 persone e 62.216 cavalli, senza gli allievi, gli accademici e le truppe bosniache.
Tenendo conto che la milizia territoriale della sola Ungheria ammonterebbe a 3.910 graduati, 27.945 uomini, 4.891 cavalli, la forza complessiva di difesa, viene ad essere di 32.440 graduati, 368.892 ufficiali e sottufficiali, il resto bassa forza, fino un complessivo di 401.392 persone, su piede di pace.
Questo per l’esercito. L’ordinamento della Marina da guerra, sempre in tempo di pace, dà le seguenti cifre: Stato maggiore e ufficiali superiori 732, sacerdoti, medici e impiegati 735, bassa forza 13.776, servi 106, totale 15.319 persone, che unite al personale dell’esercito terrestre ci dà un complessivo di 416.681 persone.
Cosa costa questo immenso stuolo di militari alle finanze della monarchia? Pel solo esercito di terra l’Austria-Ungheria spendeva nel 1900 milioni di corone 375.900 mila, nel 1908 saliva a milioni 426.800 mila, nel 1909 cresceva ancora a milioni 454.300 mila, nel 1910 arrivava a milioni 463.600 mila.
In dieci anni dal 1900 al 1911, l’Austria-Ungheria spendeva pel suo esercito corone 4.283.666.425, ai quali bisogna aggiungere corone 862.964.010 per le truppe dislocate in Bosnia.
E con gli ultimi progetti, il Governo Austro-Ungarico domandava
altri
crediti militari così ripartiti:
| Aumenti al bilancio ordinario, Corone | 64.162.410 |
| Straordinario | 4.094.800 |
| Per trasformare la flotta | 55.000.000 |
| ––––––––– | |
| Totale, Corone | 123.257.210 |
Queste ultime richieste furono naturalmente accordate dalle Delegazioni, che sono composte per una metà di senatori e per l’altra metà di rappresentanti delle varie nazionalità e dei vari partiti che difficilmente riescono a mettersi d’accordo. Però non sono ancora state approvate dalle rispettive Camere – di Vienna e di Budapest – ed è fortissima l’opposizione che tali proposte incontrano presso di tutti i partiti.
Non è detto che non possano per ciò soltanto essere ugualmente spese le maggiori somme richieste, perché si sa che il Governo austriaco, quando le Camere non funzionano va avanti a furia di decreti imperiali, ma è sintomatico che siano sorti a combatterle oltreché i socialisti, anche molti uomini dei partiti conservatori e liberali.
Certo anche in Austria come dappertutto, premono gli interessi particolari dei gruppi capitalistici dei cantieri privati (a Trieste c’è uno stabilimento Tecnico che lavora anche per la marina da guerra – e come! – pur avendo a presidente un notissimo rappresentante di quel partito nazionalista che recita sempre la commedia del martirio e dell’impaziente attesa di redenzione) che si coalizzano naturalmente, magari inconsapevolmente con le caste militari per spingere lo Stato sulla via delle criminose pazzie guerresche!
Anche in Austria dunque come in Italia, avvertiamo lo stesso fenomeno con le medesime, precise conseguenze.
Una piccola minoranza di patrioti affaristi, di militari di professione e giornalisti pesca nel torbido che crea false situazioni nei rapporti internazionali, che ha interesse a conservare sempre attorno ai governi quella falsa atmosfera di sospetti, di diffidenze, d’allarmi, dalla quale scaturisce poi con logica tutta artificiosa la necessità degli armamenti formidabili che consentono alla minoranza capitalistico-militarista di fare i propri interessi.
E anche là avvertiamo lo stesso fenomeno d’impoverimento e di depressione delle condizioni economiche del proletariato delle campagne e delle città. Tutti i prezzi delle derrate sono aumentate, e i salari rimangono stazionari, benché ci siano delle formidabili organizzazioni operaie.
Una statistica che mette in raffronto la quantità di derrate
consumate
in Germania ed in Austro-Ungheria dà le seguenti cifre:
| Consumo per ogni abitante e per anno | ||||
| Germania | Austro-Ungheria | |||
| Frumento | Kg. | 247,6 | Kg. | 174,0 |
| Orzo | “ | 77,9 | “ | 45,0 |
| Avena | “ | 120,6 | “ | 54,0 |
| Patate | “ | 635,7 | “ | 258,3 |
| Mais | “ | 15,8 | “ | 72,2 |
Solo dunque nel consumo del mais, che serve, come ognun sa, per la polenta, il popolo d’Austria-Ungheria è superiore al popolo di Germania. Rinunciamo a mettere in confronto di questi due paesi le condizioni alimentari del popolo italiano per risparmiarci una nuova mortificazione.
È dunque certo che il maggior sacrificio per sostenere gli enormi
dispendi
di forze negli armamenti è imposto alla povera gente di tutte le
Nazioni.
È il popolo che sopporta tutte le disastrose conseguenze di questa
delittuosa
politica, mentre il suo interesse materiale e le sue stesse aspirazioni
ideali lo portano sulla via della fratellanza internazionale.
L’internazionale trionfa
Né si dica che queste sono frasi fatte ormai superate dalla realtà. Al contrario, solo in questi tempi si vede quanto esse siano vere, sicure, fondate. Chi vorrà negare, infatti, che mai come in quest’inizio di secolo nuovo, i rapporti tra nazione e nazione si sono fatti sempre più intimamente stretti, per lo svolgimento naturale di tutte le forme di civiltà?
Non parliamo della scienza, dell’arte, dell’economia, che travalicano confini e barriere, accomunando tutti gli uomini, tutti i popoli, tutte le razze. Ma la stessa opera politica delle singole nazioni è sospinta, volenti o nolenti i governanti, verso le forme dell’internazionale. Quanti atti internazionali non si compiono da tutti i Governi per la miglior tutela dei loro interessi? Convenzioni, conferenze, congressi, tribunali arbitrali permanenti, intese di vario genere, è tutto insomma un tenace e spontaneo lavorio di forze sociali che agiscono nel seno di ciascuna nazione incalzandola, cercare appoggi e contatti con le altre.
Dagli orari ferroviari alla tutela dei diritti artistici; dalle convenzioni protettive dei lavoratori addetti a certe industrie, alla difesa sanitaria dei territori dai contagi epidemici, è tutto un continuo succedersi d’atti positivi compiuti da tutte le nazioni nel senso di rendere più intimi i legami di solidarietà mondiale.
È insomma l’internazionale che trionfa, malgrado e contro di tutte le facili scomuniche ed irrisioni, perché ciò risponde ad una naturale evoluzione della società moderna, nella quale l’uomo cerca sempre un più vasto campo d’azione per le sue attività che non sia quello della propria patria, e sente spegnersi adagio, adagio tutti gli odi selvaggi, e le basse passioni che seminarono di lutti e di rovine la terra e la storia.
E maggiormente sentiamo il bisogno di accostare a codesti concetti
gli
animi dei lavoratori che sono continuamente esposti alla dolorosa
necessità
di trasmigrare da un paese all’altro in cerca di lavori, di guadagni,
di fortune, ponendosi quindi a contatto con uomini d’altra lingua e
razza,
coi quali devono dividere le lotte e le sofferenze della vita.
I contrasti austro-italiani
Trieste – Il Trentino – l’Albania
Sennonché i mestatori spregevoli e vili – spregevoli perché sono mossi da fini obliqui e calcolati – vili perché non essi andranno ad esporre la pelle ai rischi del combattimento, ma ci manderanno i poveri diavoli d’operai e contadini – del nazionalismo guerrafondaio d’Italia e d’Austria, dicono che tra queste due nazioni ci sono ancora delle controversie aperte da risolvere, per cui è necessario tener sempre le armi in pugno. È vero ciò? Noi lo neghiamo. In Italia non c’è alcuna seria e profonda corrente d’idee che voglia spingere il Governo a muover guerra all’Austria per toglierle il Trentino, Trieste e l’Istria. Anche quelli che sbraitano facilmente per le strade ad intermittenza evviva ed abbasso, non sanno bene dire in che cosa consista il loro irredentismo. Perché ormai si comincia a riflettere e a capire. Si sa in Italia che la regione adriatica non è abitata esclusivamente da italiani. Ci sono anche gli slavi coi quali convivono da secoli, e coi quali hanno interesse a vivere in tranquillo accordo anche pei secoli avvenire. E si sa anche, in Italia, che la grandissima maggioranza degli italiani d’Austria non pensa neanche lontanamente di voler l’annessione al Regno.
Quanto al Trentino, è noto che esso aspira alla sua autonomia amministrativa che gli permetterebbe d’avere più intimi rapporti economici con l’Italia, mentre tra di noi vi ha alcun sincero entusiasmo per tirarci in casa i vescovi, i preti e i frati che spadroneggiano tra i monti di quella regione, perché di codesta gente n’abbiamo già abbastanza entro i confini attuali.
Queste nude e crude verità devono essere dette anche se faranno strillare qualcuno, perché è sulla fragile arena delle fantasticherie che s’erigono quasi sempre le delittuose macchinazioni del militarismo istigatore. Perché, infatti, si tennero l’anno scorso le grandi manovre terrestri nelle pianure mantovane; proprio su quegli stessi campi, ciascuna zolla dei quali può dirsi umida ancora di tanto sangue versato dalle migliaia di poveri soldati d’ogni nazionalità? E perché le manovre navali ebbero per tema l’assalto e il bombardamento di Venezia? Evidentemente perché si vuol dare al pubblico l’impressione che esista sempre un pericolo, una minaccia, contro la quale sia necessario premunirci.
Noi vogliamo dunque stabilire ben chiaro, che tutto il subdolo armeggiare del militarismo è, in Italia, in perfetto antagonismo con le aspirazioni e coi voti del popolo e del proletariato; che le velleità irredentiste non trovano qui alcun seguito, perché si è compreso finalmente che è necessario consacrare alla redenzione di tutte le plebi misere e tristi di casa nostra, le energie materiali e ideali della Nazione.
E siamo lieti di costatare come anche i ceti commerciali d’Italia e d’Austria vadano sempre più convincendosi della necessità di stabilire rapporti sempre più intimi tra i due paesi. La Federazione delle Camere di Commercio italiane, ha preso l’iniziativa per un Convegno italo-austro-ungarico di Commercianti, cui rispose aderendo entusiasticamente la consorella di Vienna, tosto seguita dai viaggiatori e da altre categorie di cittadini. Del resto, bastano poche cifre a dimostrare quanto siano immediati e strettissimi i rapporti economici tra i due paesi.
L’Italia esportava in Austria tante merci per milioni 135 nel 1909
e 144 nel 1910; l’Austria importava in Italia per 286 milioni di merci
nel 1909, e 272 nel 1910.
| Noi prendemmo dall’Austria-Ungheria: | ||
| Nel 1909 | Nel 1910 | |
| Legname | mil. di lire 98,9 | mil. di lire 99,5 |
| Cavalli | nr. 36.593 | nr. 24.439 |
| Bovini | mil. di lire 11 | mil. di lire 5 |
| E mandammo in Austria-Ungheria: | ||
| Nel 1909 | Nel 1910 | |
| Seta e cascami | mil. di lire 20 | mil. di lire 19 |
| Frutta secca | mil. di lire 11 | mil. di lire 17 |
| Agrumi | quint. 902,6 | quint. 939,9 |
| Olio d’oliva | mil. di lire 1 | mil. di lire 3 |
Esportiamo altresì essenze di frutta, burro, formaggio, cappelli, ecc., ecc.
Ordunque, sarà necessario all’Italia di stabilire negoziati doganali per cui vada sempre più intensificandosi la nostra esportazione (quanto bene, ad esempio, arrecherebbe ai nostri vignaioli l’abolizione della clausola concordata nel 1903 per cui i nostri vini sono soggetti a tariffe addirittura proibitive!) non mai vagheggiare chimere e propositi guerreschi.
Ma vi ha chi crede che il conflitto austro-italiano sarà reso inevitabile dalla posizione che le due potenze vengono ad assumere nei Balcani e specialmente in Albania.
Ora, anche a questo riguardo è facile a noi il dimostrare che tale rivalità d’appetiti, posto che esista, è limitata soltanto ai gruppi capitalistici che pretendono di farsi proteggere sempre dallo Stato, all’interno coi dazi doganali e all’esterno coi grandi armamenti che impongono con la violenza delle armi condizioni di favore ai loro prodotti. Il popolo anche qui non c’entra. Né quello d’Austria né quello d’Italia. Che se poi si volessero davvero prendere a cuore le condizioni politiche dell’Albania e aiutare la sua emancipazione nazionale, dalla dominazione ottomana, non vi è altro da fare che aiutare lo sviluppo intellettuale ed economico di quel paese che vive ancora in condizioni semifeudali. Basta pensare che esso è completamente in mano dei preti delle due religioni dominanti: la cattolica e la maomettana.
Parlando della principale città dell’Albania, scrive Battista Pellegrini (Verso la Guerra? Edit. Voghera, 1907) che visitò minutamente quel paese ed ha gran dimestichezza in codest’ordine di problemi, pur esaminandoli da un punto di vista tutto patriottico e nazionalistico:
«In quale altro paese d’Europa che non sia Scutari, le donne cattoliche, nascondono l’eleganza delle forme sotto larghissimi dolman ed i larghissimi calzoni? In quale altro paese che non sia Scutari, le donne cattoliche escono col volto quasi completamente coperto? In quale altro paese d’Europa le ragazze, fino all’epoca del matrimonio, sono soggette ad una clausura quasi completa?
«In un solo sito possono recarsi libere, le donne: in chiesa. Quindi il fascino psicologico della chiesa e della religione si converte anche in una forma di passatempo che ricrea; la chiesa diviene un’aspirazione, una mèta ed una soddisfazione; le processioni assumono l’importanza d’uno spettacolo e la voce maschile che perora e predica dal pergamo assume, in circostanze siffatte, un gran valore, ed esercita una suggestione straordinaria, acuita dal fatto che nella stessa città vi è un rivale di quella religione e quella chiesa – l’islamismo.
«Le due grandi forze dominanti a Scutari sono l’islamismo e il cattolicismo; il primo che fa capo al Sultano e il secondo a chi tanto sostiene e protegge quel culto, a chi ne sussidia i ministeri: all’Austria, cioè, più che al Vaticano.
«Cattolici e musulmani parleranno insieme e discuteranno d’affari, sì; non di politica, anche per la ragione che nessuno dei due vuol compromettersi di faccia all’altro. La politica la fa il sacerdote cattolico, la potrebbe fare l’holgia; ma quest’ultimo certo a Scutari, non può fare che una politica profondamente turca, come il primo è costretto a farla austriaca.
«In tali condizioni di cose non vi è bisogno di dilungarsi per dimostrare quanto difficile e seminata di triboli sia la politica italiana a Scutari, politica la quale non può trarre vantaggio che da due fattori: la lingua e il commercio».
Chi vorrà ora sostenere che per favorire la nostra lingua e i nostri commerci in Oriente possa esserci utile una politica di grandi armamenti e di spacconate militari e navali? Lo stesso Battista Pellegrini, che non è certo un socialista né internazionalista, né pacifista, dopo aver lamentata la mancanza di scuole, di banche, d’ospedali, d’uffici postali, e di tante altre istituzioni nei paesi della Bassa Albania e in tutto l’Oriente fino a Salonicco, che aiutino la positiva penetrazione dell’elemento italiano, scrive ad un certo punto:
«Io stesso che sono diventato, per considerazione d’ordine
elevato,
fautore della necessità di completi armamenti, mi chiedo poi se la
somma
che potrà essere impiegata nella costruzione di qualche forte, al
confine
orientale, purtroppo aperto da tutte le parti, non potrebbe forse
essere
utilizzata meglio col contribuire al rinnovamento marittimo commerciale
italiano nell’Adriatico, col sovvenzionare nuove linee marittime di
carattere commerciale, linee che si dovrebbero però sovvenzionare non
in base al tonnellaggio trasportato, ma in base alla concorrenza
esercitata».
L’ipocrisia pacifista borghese e il proletariato
Anche, dunque, esaminando i rapporti tra i due paesi alla stregua dei materiali interessi economici, noi pensiamo che la peggiore politica che possa consigliarsi è quella dei grandi armamenti. E del resto, sembrano accostarsi a questa concezione anche gli stessi ceti borghesi d’Italia e d’Austria, quando accolgono con dimostrazioni di simpatia ogni atto che segni un ravvicinamento tra i due paesi. Sennonché noi non dobbiamo prestar molta fede ai pronunciamenti e alle verbali dichiarazioni dei gruppi borghesi d’Italia e d’Austria. I loro amori sono poco sinceri, come sono artificiosi ed effimeri i loro odi. Come oggi trovano le ragioni in favore dell’amicizia e della pace, così domani troveranno pretesti e motivi per resuscitare gli odi provvisoriamente messi in disparte. Noi non dobbiamo inseguire le chimere di una pace che non potrà mai esistere tra capitalisti concorrenti, ma dobbiamo invece mirare a scrivere il patto sincero e indissolubile d’alleanza tra i due proletariati.
E gridare alto, forte e solenne, che i lavoratori d’Austria e d’Italia non hanno ragione alcuna per guardarsi in cagnesco, per nutrire reciproci rancori. Quando poi noi lavoratori italiani sappiamo che fra i vari partiti politici d’Austria, il solo partito socialista, che comprende uomini d’ogni nazionalità, fu sempre pronto a riconoscere e a difendere per primo nel Parlamento e nei Comizi i diritti della nostra nazionalità al suo sviluppo civile, alla sua cultura, non possiamo non stendere con entusiasmo le mani ai compagni nostri dell’Austria, per rinsaldare i vincoli di solidarietà internazionale.
E saremo noi che tradurremo in pratica il vaticinio del Grande poeta nostro che fin dal 1846, quando ancora tutta Italia gemeva nel servaggio, intravide i fati dei tempi nuovi quando scriveva il canto che fu vaticinio:
E quest’odio che mai non avvicina
Il popolo lombardo all’alemanno,
Giova a chi regna dividendo, e teme
Popoli avversi affratellati insieme.
Né guerra né pace armata
Ragioni economiche, considerazioni politiche, affinità etniche e interessi morali, consigliano dunque ai popoli dei due paesi di intendersi, di comprendersi, di amarsi.
Ma contro i popoli, stanno, ben lo sappiamo, le cricche dinastiche e militari, i gruppi affaristici del capitalismo. E se questi presumendo d’essere più forti di noi vorranno fiaccare le nostre resistenze, e paralizzare i nostri propositi per spingere entrambi i paesi alla rovina? Che faremo noi lavoratori socialisti d’Italia e d’Austria?
Rispondere a questa domanda, è uno dei compiti del Convegno che si terrà in Roma nel prossimo luglio.
Edmondo De Amicis, che per aver esaltata la vita militare, non rinunciava mai a combattere quel patriottismo che istiga agli odi i popoli e li eccita alle violenze, scriveva nell’Avanti! di Primo Maggio 1906 – e fu quello l’ultimo suo scritto dettato per la stampa del suo partito:
«Troppo è manifesto che è la forza crescente del socialismo la principale ragione per cui non scoppiò in Europa dopo il 1870 la tanto temuta guerra, benché tante volte ci siano state propizie le occasioni politiche e se ne sia predicata l’imminenza. Monarchi governi, oligarchie interessate trattenne la coscienza che il terreno è mal fido per il gran duello e che la lama è mal ferma nell’impugnatura».
Ricordiamo oggi il monito severo del Grande nostro scomparso e gridiamolo in faccia all’Europa militare, ai maledetti affaristi che speculano sulle disgrazie delle nazioni, in Italia come in Austria:
Il proletariato odia la guerra perché vede in essa il suo martirio e la sua rovina; odia la politica dei grandi armamenti perché vede sciupati per questa via i milioni che dovrebbero prodigarsi alla sua redenzione civile, e domanda alle nazioni di rispettarsi a vicenda, di aiutarsi.
Che se, ciò malgrado, i ceti dirigenti e la politica dei due paesi, vorranno avventurarsi negli abissi della guerra o rimanere sotto il peso schiacciante dei bilanci militari, il proletariato d’Italia e d’Austria, avendo compiuto tutto il suo dovere, sarà pronto a padroneggiare gli avvenimenti, per salvare se stesso e schiudersi la via alle conquiste avvenire.