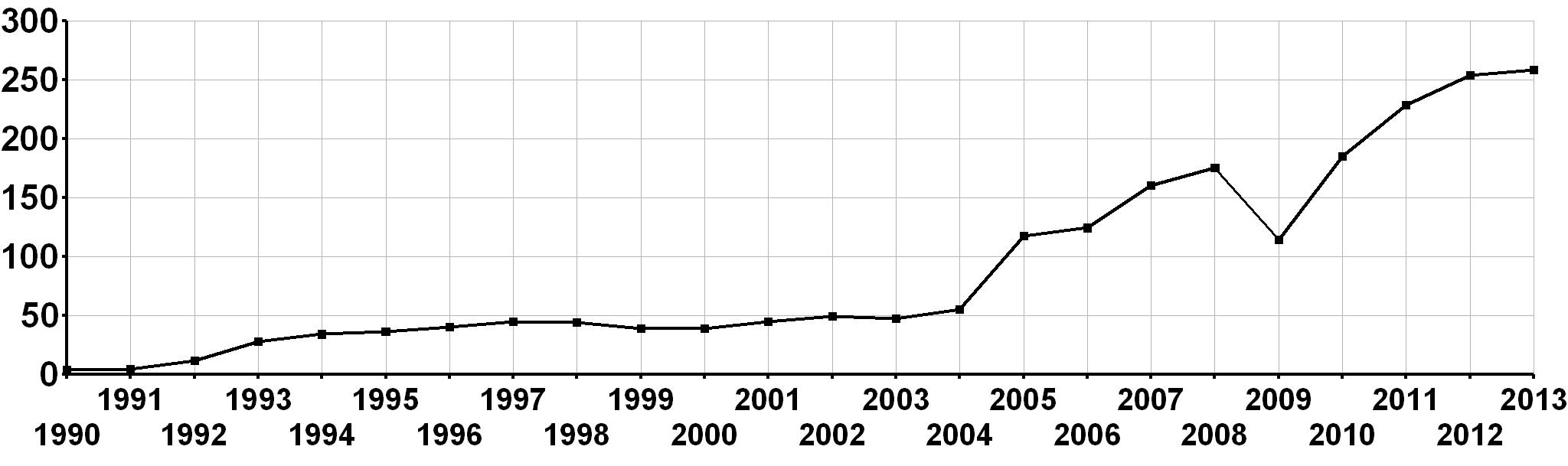
|
|||||||
|
|||||||
|
Necessità della guerra, necessità della rivoluzione
Può destare sconcerto, al lettore democratico-progressista che malgrado tutto spera e crede nella razionalità dell’umano agire e nelle sue sorti, un certo articolo comparso nel luglio di quest’anno sul New York Times, “The lack of major wars may be hurting economic growth”, La mancanza di grandi guerre può essere di danno alla crescita economica, che descrive la guerra come un destino, terribile e disastroso, ma in fondo fattore di progresso, di evoluzione e di rinnovato sviluppo economico.
A corredo, c’è un interessante grafico che correla nel tempo, a far base dagli anni ’50 fino al 2010, i morti ammazzati, militari e civili. Grafico che, rigoroso, non include i morti per malattia o fame e mostra il “rapido declino” almeno fino al 2010, fatto salvo un picco nei periodi 1970-1975 e 1980-1990, della contabilità del macellaio.
Te guarda, anche oltreoceano si fa strada l’idea che questo evento possa essere un fattore produttivo la cui assenza, alla lunga, riduce le possibilità o le prospettive di un miglioramento della condizione umana; almeno per quelli che potranno avere una ragionevole probabilità o la fortuna di sopravvivere.
Ma di guerre, dopo il secondo conflitto mondiale, ce ne sono state a iosa; e quelle non dovrebbero forse contare, anche se i morti paiono “in decisa diminuzione” ? Anzi in questi ultimi decenni c’è stata una forte accelerazione di conflitti, e neppure più semplicemente locali, ma via via più larghi e duraturi. E allora? Il titolo dell’articolo, nella sua semplicità, è chiarissimo, Major wars, che, senza troppo forzare ci vien da leggere Guerre mondiali. Questa è la chiave. La guerra deve essere ampia, più ampia possibile, deve sconvolgere e rompere lo stagnante sviluppo del 1-2%, quando va davvero bene, deve accelerare la messa in campo di risorse tecniche e produttive. Per... una crescita del 4%, figurarsi. Morti, lutti, rovine, un sottoprodotto sgradevole, ma dolorosamente necessario.
Non invano simili articoli compaiono ad un punto avanzatissimo della peggiore crisi capitalistica dal secondo dopoguerra, dopo che tutte le riprese “dietro l’angolo” che avrebbero dovuto verificarsi “da un momento all’altro” si sono dimostrate inconsistenti e alla lunga fallaci.
Fino a ieri le guerre erano condotte per ragioni di sicurezza, per il controllo su risorse o zone di influenza, e via di questo passo. Ora simili giustificazioni, valide indubbiamente per una certa fase dello sviluppo capitalistico e della sua crisi, non bastano più. La teorizzazione sale di tono, e per certo verso diventa più precisa – e più tragica. La sua crudezza mostra il cinismo delle classi dominanti e dei loro teorici, in primis gli economisti del capitalismo che fanno degno paio con gli Stati maggiori militari e non si vergognano, anzi si compiacciono della correttezza e del “coraggio scientifico” con cui manifestano all’universo mondo la “loro” verità, pur truculenta che sia.
Non ci interessa seguire le contorsioni ideologiche dell’articolista, forse preoccupato dello sconcerto che simile tesi estrema può suscitare nei lettori meno smaliziati. Il coraggio di affermare chiaramente che l’uscita dalla Grande Depressione è stata realizzata con il ricorso allo spaventoso macello della Seconda Guerra Mondiale non c’è, ma si leggono ben chiare le indicazioni che l’evento in sé è stato un potentissimo motore di sviluppo in una condizione di profonda crisi economica mondiale. E non soltanto perché la guerra faccia aumentare la spesa pubblica e metta a lavoro quanti erano disoccupati nella crisi, tesi keynesiana classica, ma soprattutto perché costringe i governi a prendere decisioni fondamentali sull’economia, liberalizzandola da ogni precedente vincolo.
Più di questo la pletora dei teorici dello sviluppo ininterrotto del capitale non può dire, non riesce ad andare.
Oltre può andare soltanto la scienza di un modo di vita associata che dovrà superare i limiti della produzione per il profitto, che non avrà a paradigma la necessità intrinseca al meccanismo di accumulazione capitalistico, di crescita continua e costante, senza la quale c’è solo la crisi. Crescita continua ed ossessiva che è la dannazione dell’umanità lavoratrice, che per essere di nuovo ritrovata quando diminuisce fino all’arresto, impone la distruzione periodica di quanto è stato accumulato.
Il mondo classico antico, strutturato su altro modo di produzione, aveva raggiunto un suo culmine di scienza politica nella celebre massima del si vis pacem para bellum; al suo imporsi come modo di produzione moderno all’inizio del 19° secolo il capitalismo aveva letto la guerra come prosecuzione della politica con altri mezzi; oggi nella sua fase più avanzata di putrescenza, proclama che la recente diffusione della pace è incompatibile con la riproduzione del profitto. È lo “sviluppo” finale del pensiero economico e politico borghese costretto dalla forza dei fatti a denunciare l’unica via di uscita che sia disponibile, all’interno del capitalismo stesso.
Naturalmente lo stesore di tanta scienza non è solo nelle sue considerazioni finali. E con serietà e correttezza scientifica ci offre ampia dovizia e citazioni di altri illustri maitres-a-penser che hanno raggiunto, dopo studi storici ed economici, dall’antichità classica ai tempi odierni, le stesse conclusioni, sulle quali noi stessi, seguaci di una dottrina a questa opposta, non possiamo che dirci d’accordo, salvo il piccolo distinguo di quale sia però la necessità fondamentale della guerra per il capitalismo.
E allora di tanta impudente franchezza dobbiamo essere grati a questi signori, che danno, loro malgrado, conferma e validità alla nostra visione del mondo: la guerra è una necessità imprescindibile per il mondo del capitalismo, che si rivela anche in questo supremo aspetto anti-umano.
Ma i comunisti non hanno paura della guerra in nome di un pacifismo impotente che ha per sola aspirazione il mantenimento delle condizioni esistenti, dello sfruttamento del lavoro morto sul lavoro vivo, magari in un modo meno ossessivo, più equilibrato, più giusto; senza sangue e violenza. Alla guerra del Capitale, per il suo perpetuarsi, la Rivoluzione deve contrapporre la sua guerra per cessare alla fine, questa mostruosità che ormai solo opera contro la specie umana.
CORSO DELL’IMPERIALISMO MONDIALE
Riunione di Genova, 24-25 maggio 2014
Attestiamo questa parte dello studio sull’avvitarsi della generale crisi economica a precedenti indagini del partito. In particolare al rapporto pubblicato nel numero 22 del 1957 de Il Programma Comunista, nel quale appariva la tabella “Distribuzione percentuale della produzione industriale nel mondo”. Dopo 18 anni, nel 1975, ne pubblicavamo ne Il Partito Comunista un aggiornamento, e ne commentavamo il significato. Infine nel 1991, passati altri 16 anni, nella ripubblicazione in volume del “Corso dell’economia mondiale” potevamo aggiornare quei dati al 1985, ripartiti in Popolazione, Produzione industriale, Intensità dell’industrializzazione. Qui infine, trascorsi altri 13 anni di nera controrivoluzione sociale ma di travolgente e massimamente rivoluzionario sviluppo, e inviluppo, mondiale del capitalismo, torniamo a misurarne il passo e le proporzioni. Un mondo che è molto cambiato da allora.
Cerchiamo quindi di dare qui una visione di insieme del corso dell’imperialismo dopo la grande crisi del 1974-75 e di spiegare l’andamento della crisi di sovrapproduzione nella quale il capitalismo mondiale si trova ad affondare dalla metà del 2008.
Due contraddizioni fondamentali strangolano il capitalismo: la caduta tendenziale del tasso del profitto e l’impossibilità di trovare un equilibrio tra la produzione, che si presenta come una immensa accumulazione di merci, ed il mercato, che ne dovrebbe assorbire una quantità sempre crescente al fine di permettere all’accumulazione del capitale di cominciare un nuovo ciclo. La caduta tendenziale del tasso di profitto condanna a morte il capitalismo negando il suo fondamento, l’accumulazione di valore. L’intersecarsi di queste due contraddizioni conduce alle crisi periodiche di sovrapproduzione. Crisi che mostrano l’angustia del modo di produzione capitalista che non riesce più a permettere il libero sviluppo delle forze produttive e precipita in periodiche crisi di sovrapproduzione sempre più gravi e catastrofiche. La legge del valore, fondamento dell’accumulazione del capitale, è divenuto un ostacolo allo sviluppo delle forze vitali dell’umanità.
Questa contraddizione non si può risolvere che nella rivoluzione comunista – che abolirà i rapporti di produzioni fondati sulla legge del valore, il capitale e il salariato, e la legge del valore stessa, passando ad una gestione sociale della produzione, le cui basi ha gettato il capitalismo stesso – o da una terza guerra imperialista mondiale.
La caduta del saggio del profitto si traduce in un rallentamento dell’accumulazione e quindi della crescita delle produzioni. Il che non vuol dire che la crescita si arresti o che la produzione diminuisca, ma che da un ciclo all’altro cresce in percentuale, relativamente alla sua massa, sempre meno, per tendere a zero.
Ogni ciclo ha per punto di partenza il massimo raggiunto prima della crisi, poi si ha una caduta della produzione per alcuni anni, di una gravità che varia in profondità e durata, e per punto di arrivo il nuovo massimo raggiunto dopo la ripresa delle produzioni, giusto avanti la nuova recessione. Così il capitalismo passa da sempre da un ciclo all’altro e da una crisi di sovrapproduzione all’altra.
A questi cicli “dell’industria” si sovrappongono i cicli intermedi e lunghi delimitati delle crisi che hanno segnato le svolte nella storia del capitale mondiale.
Prendiamo a rappresentazione dell’insieme della produzione capitalistica solo quella della “industria”, della quale sola disponiamo dei dati storici di tutti i paesi, nella presunzione che rispecchi abbastanza bene anche gli altri importanti suoi settori, primo fra tutti l’agricoltura.
Nella tabella qui sotto gli indici della produzione industriale del periodo 1900-2007 sono divisi in 5 cicli di accumulazione. Gli anni di partenza e di arrivo di ogni ciclo possono variare da un paese all’altro, e ne abbiamo tenuto conto nel calcolo degli incrementi. Tutto il calcolo parte dagli indici fornitici a partire dal 1937 dall’Onu, per gli anni precedenti dalla Società delle Nazioni e da grandi economisti, come il Kuscinsky, che si richiamano alla scuola marxista.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il quarto ciclo, qui lo conteggiamo, invece che dal 1937, dal 1950, anno in cui il massimo di anteguerra è raggiunto e superato. Termina nel 1973, anno che segna la fine del ciclo di robusta accumulazione e quasi senza recessioni, almeno nei paesi che hanno conosciuto le grandi distruzioni della guerra, come la Germania e il Giappone, ed annuncia la prima grande crisi mondiale di questo dopoguerra.
È utile partire dal 1950 invece che dal 1937 per mettere in evidenza il ringiovanimento del capitalismo a causa della guerra, che gli ha permesso di ritrovare dei ritmi di accumulazione sconosciuti dal tempo della sua giovinezza.
La tabella è ordinata secondo il tasso medio annuo di crescita della produzione, che, vediamo, coincide con il classamento per età, in ordine ascendente, da tassi di crescita più bassi ai più altri. La Gran Bretagna, terra ove è apparso il capitalismo industriale, ha il tasso più basso. Seguono cronologicamente Francia, poi Germania, Stati Uniti, Italia, Russia – che ha visto una rinascita del capitalismo negli anni Venti, dopo le terribili distruzioni della guerra civile – poi Giappone, Cina e infine Corea del Sud. Come si vede il paesi di vecchio capitalismo hanno ritmo di crescita più lento, al contrario i paesi di capitalismo giovane ritmi più elevati.
La tabella si legge in verticale, ma anche in orizzontale: da un ciclo all’altro è evidente il forte rallentamento della crescita.
La Prima Guerra mondiale, interrotta dalla rivoluzione russa e dalla guerra civile in Germania, non adempì appieno al ringiovanimento del capitale, che presto cadde in una grave recessione mondiale. Alla depressione seguì un leggero recupero degli incrementi nel ciclo 1929-’37. Poi di nuovo brusco crollo, seguito da una forte ripresa nei paesi che si preparavano alla guerra: Gran Bretagna, Germania, Italia. Il Giappone, che si stava alacremente armando per la guerra, non avrà inversioni e manterrà ritmi sostenuti. Negli Stati Uniti lo sforzo di guerra, immane, si farà sentire a partire dal 1940, durante la guerra. In Francia invece gli incrementi dal 1930 al ‘37 resteranno negativi.
I tassi del ciclo 1950-1973 dimostrano il ringiovanimento capitale, cioè del suo apparato produttivo, per effetto della guerra. Nei paesi sconfitti abbiamo ritmi di crescita sconosciuti nei cicli precedenti, superiori anche al 1900-1913! Gran Bretagna 3,0% contro 2,3%; Francia 6,2% contro 3,6%; Germania 7,2% contro 4,0%; Italia 7,2% contro 2,7% e 2,3% nei due cicli precedenti. Ed il Giappone 8,8% contro 7,6% e 6,0%. Anche gli Stati Uniti, grandi vincitori della Seconda Guerra, ma che non hanno conosciuto distruzioni, ne trarranno un effetto benefico rispetto al ciclo 1929-1937, ma l’incremento resterà sensibilmente inferiore a quello dei due primi cicli in tabella.
La cesura del 1973
Il 1973 segna una rottura, la fine di un ciclo di accumulazione euforica e quasi senza interruzioni. Benché questa ritrovata vitalità dal capitale sia fondata sulle distruzioni massicce e sull’immane massacro della Seconda Guerra mondiale, proseguita nella cosiddetta guerra fredda e in guerre continue fra i blocchi imperiali nei continenti africano ed asiatico, questa frenetica accumulazione ha creato l’illusione nella possibilità di un progresso continuo, sul piano scientifico, tecnico e sociale, ed anche la classe operaia cadeva in uno stato di superstizione e smarrimento comparabile ai periodi più oscuri della storia umana.
Se oggi, 2014, il proletariato non è ancora uscito da questo stato di paralisi, i suoi miti, mutuati dalla piccola borghesia, sono in parte caduti, e la disillusione ha preso il posto della vana euforia del dopoguerra.
Il grande ciclo di 34 anni dal 1973 al 2007 si caratterizza quindi con un netto rallentamento dell’accumulazione del capitale, la cui crescita tende a zero. Si nota anche un rovesciamento nell’ordine dei diversi paesi secondo il tasso di crescita. Nel ciclo 1950-1973 si saliva dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, all’Italia, al Giappone fino alla Corea del Sud, con il record del 17,6%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ora fuori ordine sono Russia ed Italia, troppo in basso, e Stati Uniti, troppo in alto.
Infatti la Russia, dopo il disfacimento dello Stato e dell’impero e la gravissima recessione degli anni ‘90, con una caduta della produzione del 56%, cioè superiore anche a quella degli anni Trenta negli Stati Uniti, si trova nel periodo in fondo alla lista con un rinculo medio annuo di 1,2% !
L’Italia, un capitalismo più giovane di quello tedesco, ed a maggior ragione francese, si ritrova in terz’ultima posizione. Una delle ragioni della debolezza dell’imperialismo italiano si fa risalire allo scarso numero di multinazionali con base nel Paese: nel 2010 su un totale nel mondo di 500 ne conta 10, contro più di 30 per la Germania, la Gran Bretagna e la Francia. Questo è indice di una debole concentrazione del capitale produttivo, commerciale e bancario che, nell’era dell’imperialismo, è necessario per vincere la concorrenza globale.
Per contro gli Stati Uniti fanno meglio degli altri vecchi imperialismi, con un tasso di incremento del 2,4%.
La Corea del Sud ha visto l’incremento medio cadere dal 17,6% all’8%.
La Cina, al primo posto, fa anche meglio della Corea coll’11%, ma contro il precedente 12,7%. Tuttavia sappiamo che la Cina per il calcolo degli indici della produzione industriale non parte dal valore aggiunto nella produzione, ma dal fatturato, che ovviamente contiene i valore aggiunto nelle produzioni a monte, il che gonfia gli indici, tanto più quanto il ramo industriale si trova a valle dell’insieme del processo produttivo. Per esempio, nell’indice della produzione di elettronica di consumo, che monta telefonini o televisioni, i cinesi sommano anche il valore dei componenti elettronici già conteggiato in altri settori, magari prodotti in Giappone, Germania o Stati Uniti. Sarebbe da indagare l’effetto di questo errore dell’indice assoluto sui suoi incrementi relativi annui, ma possiamo azzardare che l’incremento percentuale reale sia più basso di 2 o 3 punti.
Il grande ciclo 1973-2007 è suddiviso nella successiva tabella in
quattro cicli brevi da cinque crisi internazionali di sovrapproduzione.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In una lettura orizzontale, da un ciclo all’altro si vede nettamente la tendenza irresistibile ad un forte rallentamento, compreso per i capitalismi giovani come la Corea del Sud. Nel periodo 2000-2007 si hanno anche incrementi negativi per tre paesi, la Gran Bretagna, l’Italia e la Russia. Quanto al Giappone e alla Francia, l’incremento non è lontano dallo zero: 0,47% e 0,50% rispettivamente.
Abbiamo aggiunto il periodo 2007-2013, benché non sia un ciclo poiché il 2013 non corrisponde ad un massimo che preceda una nuova recessione. Infatti i grandi paesi imperialisti, a parte gli Stati Uniti, non sono ancora usciti dalla recessione. Il suo interesse è dimostrare il forte rallentamento della produzione industriale della Corea, che vi annuncia una prossima grave recessione. Questo rallentamento di ciclo in ciclo è confrontabile a quello segnato dall’Unione Sovietica prima della sua implosione e la terribile recessione degli anni Novanta.
Tutti gli attacchi della borghesia alla classe operaia successivi alla crisi del 1974-75, la cosiddetta politica economica liberale iniziata dalla Thatcher e da Reagan, non hanno permesso di invertire la tendenza. La leggera ripresa nel ciclo 1989-2000 per Stati Uniti, Francia e Italia ricade pesantemente nel ciclo seguente: 1% di crescita media per gli Stati Uniti, 0,5% per la Francia, e -0,2% per l’Italia. La Gran Bretagna si è mantenuta al modesto 0,9% durante i due cicli del 1979-1989 e 1989-2000: ben poco, nonostante le grandi sofferenze per la classe operaia inglese. Ma la classe dominante per salvare i suoi privilegi di classe è pronta ad ogni ignominia. E non siamo che all’inizio!
Il capitalismo tedesco ha conosciuto una ripresa nel ciclo 2000-2007 con una risalita dell’indice al 2,30% contro l’1,4% del ciclo precedente. Questa ripresa è il risultato della politica economica dal cancelliere Gerhard Schröder nei primi anni Duemila, che ha condotto ad un immiserimento e al precariato una parte della popolazione e dei salariati: in Germania il 20% della popolazione attiva è povera e precaria e, nel 2010, quasi 4 milioni lavoravano per un salario orario lordo di meno di 7 euro. Tuttavia si può prevedere che l’incremento annuo medio per il ciclo in corso sarà vicino a zero e che il capitalismo tedesco andrà diritto verso una recessione che sarà ben peggiore di quelle recenti della Spagna e della Grecia.
Ascesa e declino dei capitalismi
Per seguire il corso dell’insieme del capitalismo abbiamo cercato di calcolare un indice della produzione industriale mondiale, anche al fine di confrontare i grandi centri industriali ed imperialisti fra di loro, tanto dal punto di vista del ritmo della crescita quanto del peso relativo degli uni rispetto agli altri.
Se è possibile rintracciare gli indici dalle produzione mondiale, più difficile è calcolare i coefficienti di ponderazione di ogni paese, che variano di ciclo in ciclo.
Per aggirare la difficoltà siamo partiti dalla produzione di elettricità, che è utilizzata tanto nei diversi settori produttivi quanto nei commerci e nell’insieme della società. Produrre e distribuire questo tipo di energia richiede più di un ramo di industria, la costruzione e il mantenimento delle centrali termiche, nucleari, le dighe e i bacini, con ricorso alla siderurgia, l’edilizia, le costruzioni meccaniche, elettriche, etc., il che ne fa un buon indicatore del grado di sviluppo del capitalismo di un paese e del volume del capitale che vi si riproduce. La costruzione degli indici, partendo da un dato fisico, è inoltre più immediata e affidabile e facile derivare considerazioni sulla sua variazione da un anno all’altro, sulla ripartizione fra paesi, sulla produzione pro-capite.
I risultati cui siamo qui pervenuti non differiscono sostanzialmente da quelli dei precedenti nostri studi, al contrario vi si collegano assai bene. I valori sono un po’ più elevati per la produzione di elettricità. Perché il lettore possa rendersene conto ripubblichiamo qui la tabella del 1975 (qui corretti pochi errori del tipografo).
| I CICLI DI ACCUMULAZIONE E DI CRISI DEL
CAPITALISMO MONDIALE Il Partito Comunista, n. 15, 1975 |
||||||||||
| Periodi | Gran Bret. |
Fran- cia |
Ger- ma- nia |
Usa | Italia | Rus- sia |
Giap- pone |
Altri | Mondo | |
| RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | In- di- ci ba- se 19- 29 |
|||||||||
| 1870 | 31,8 | 10,3 | 13,2 | 23,3 | 2,4 | 3,7 | - | 15,3 | 100 | |
| 1881-85 | 26,6 | 8,6 | 13,9 | 28,6 | 2,4 | 3,4 | - | 16,5 | 100 | |
| 1896-00 | 19,5 | 7,1 | 16,6 | 30,1 | 2,7 | 5,0 | 0,6 | 18,4 | 100 | |
| 1906-10 | 14,7 | 6,4 | 15,9 | 35,3 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 18,6 | 100 | |
| 1913 | 14,0 | 6,4 | 15,7 | 35,8 | 2,7 | 5,5 | 1,2 | 18,7 | 100 | |
| 1913 | 14,1 | 7,0 | 14,3 | 35,8 | 2,7 | 4,4 | 1,2 | 20,5 | 100 | 75 |
| 1926-29 | 9,4 | 6,6 | 11,6 | 42,2 | 3,3 | 5,1 | 2,5 | 19,3 | 100 | 100 |
| 1936-38 | 9,2 | 4,5 | 10,7 | 32,2 | 2,7 | 7,0 | 3,5 | 30,2 | 100 | 130 |
| 1956 | 5,7 | 3,2 | 8,4 | 36,4 | 2,5 | 13,3 | 2,5 | 28,0 | 100 | 316 |
| 1971 | 3,6 | 3,2 | 8,2 | 25,6 | 2,9 | 20,5 | 6,8 | 29,2 | 100 | 748 |
| 1974 | 3,2 | 3,1 | 7,3 | 24,7 | 2,8 | 20,9 | 6,9 | 31,1 | 100 | 914 |
| RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE | mlrd | |||||||||
| 1929 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 6,2 | 2,0 | 8,0 | 3,2 | 72,9 | 100 | 1,97 |
| 1937 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 5,9 | 2,0 | 7,7 | 3,2 | 74,5 | 100 | 2,30 |
| 1956 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 6,2 | 1,9 | 7,4 | 3,3 | 75,7 | 100 | 2,74 |
| 1971 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 5,5 | 1,5 | 6,7 | 2,9 | 78,8 | 100 | 3,68 |
| 1974 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 5,4 | 1,4 | 6,7 | 2,8 | 79,3 | 100 | 3,89 |
| INDICI DI RAPPORTO | ||||||||||
| 1929 | 409 | 314 | 352 | 681 | 165 | 64 | 78 | 26 | 100 | 100 |
| 1937 | 418 | 237 | 412 | 546 | 135 | 91 | 109 | 41 | 100 | 111 |
| 1956 | 300 | 200 | 420 | 587 | 132 | 180 | 76 | 37 | 100 | 227 |
| 1971 | 240 | 229 | 482 | 465 | 193 | 306 | 234 | 37 | 100 | 400 |
| 1974 | 213 | 238 | 456 | 457 | 200 | 312 | 246 | 39 | 100 | 462 |
| QUOTA PARTE PERCENTUALE DEL COMMERCIO MONDIALE | ||||||||||
| 1929 | 13,0 | 6,2 | 9,3 | 13,8 | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 50,6 | 100 | |
| 1938 | 13,6 | 4,5 | - | 10,7 | 2,4 | 1,1 | 4,5 | - | 100 | |
| 1956 | 9,9 | 5,2 | 7,2 | 16,4 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 51,8 | 100 | |
| 1971 | 7,2 | 6,5 | 11,6 | 13,9 | 4,8 | 4,1 | 6,8 | 45,1 | 100 | |
| 1974 | 6,0 | 6,3 | 10,5 | 13,3 | 4,6 | 3,4 | 7,7 | 48,2 | 100 | |
Nella tabella che ora aggiungiamo, “Incrementi della produzione di
elettricità”, abbiamo una prima linea divisa in due lunghi cicli che
riguardano la produzione di elettricità alla scala mondiale. Si vede
chiaramente la caduta degli incrementi medi, che passano da 8,3% nel
ciclo 1950-1973 a 3,5% nel successivo 1973-2007 e questo malgrado lo
spettacolare sviluppo del capitalismo in Asia del Sud ed in particolare
in Cina negli ultimi 34 anni. Il rallentamento è innegabile. Quel che
qui direttamente è dimostrato è la decrescita del tasso di incremento
delle produzioni, il che matematicamente indica la decrescita del tasso
medio del profitto, essendo il profitto ciò che, ad ogni ciclo del
capitale, viene reinvestito per rendere possibile l’aumento delle
produzioni.
| INCREMENTI DELLA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ (fonte Onu) |
||||||
| 1950- 1973 |
1973- 1979 |
1979- 1989 |
1989- 2000 |
2000- 2007 |
2007- 2013 |
|
| Mondo | 8,3% | 3,5% | ||||
| 4,6% | 3,7% | 2,5% | 4,0% | |||
| Europa, Stati Uniti e
Giappone |
3,3% | 2,7% | 2,2% | 1,2% | ||
| Cina | 9,1% | 7,6% | 7,9% | 12,9% | 8,4% | |
| Mondo senza Europa, Stati Uniti e Giappone | 6,4% | 4,8% | 2,9% | 6,2% | ||
| Mondo senza Europa,
Stati Uniti, Giappone e Cina |
6,2% | 4,5% | 2,1% | 4,4% | ||
La parte inferiore della tabella dal 1973 è divisa in 4 cicli corti, ai quali abbiamo aggiunto il periodo 2007-2013 per la Cina, benché il ciclo non sia terminato.
La prima linea riguarda il mondo: si deve notare che se si ha una decrescita regolare e netta della produzione nei primi tre cicli, si ha una inversione nell’ultimo. E vedremo perché.
La riga successiva rappresenta i vecchi centri imperialisti mondiali, cioè gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone. La decrescita e l’invecchiamento del capitalismo e la sua prossima fine vi scaturiscono nettamente. Questa decrescita è regolare ed irreversibile, a meno di una terza guerra imperialista mondiale che, se riuscisse ad arrivare al suo termine, potrebbe apportare al capitalismo un vero bagno di giovinezza e resuscitarne il cadavere.
Viene poi la Cina: nel secondo ciclo ha un rallentamento, con una leggera ripresa nel terzo ciclo, 1989-2000, che arriva al parossismo nel ciclo 2000-2007 con il 12,9%. Il periodo successivo annuncia un netto rallentamento, che è qui solo al suo inizio. Il forte riposizionamento della Cina nel secondo e terzo ciclo è confrontabili agli incrementi dei vecchi paesi industrializzati nello stesso periodo.
Mentre che i vecchi centri rallentano, poi a ritmi di accumulazione asmatici, 2,2% e 1,2%, la Cina vede risalire i suoi a 7,9% poi a 12,9%.
Abbiamo aggiunto due altre righe molto importanti. La prima rappresenta il mondo senza gli Stati Uniti, l’Europa ed il Giappone. Come prevedibile gli incrementi sono tutti qui più elevati, i capitalismi essendo più giovani. Tuttavia questo non impedisce la decrescita degli incrementi, espressione del rallentamento relativo dell’accumulazione del capitale alla scala mondiale. Si ha così per i tre primi cicli: 6,4%, 4,8% e 2,9%. Ma interessante è l’inversione del ciclo 2000-2007: 6,2%.
Infine l’ultima riga, che riprende la precedente ma togliendovi la Cina. Gli incrementi sono un po’ più bassi, ma più elevati nei primi due cicli rispetto a quelli del mondo comprendente tutti i paesi ed in particolare i vecchi centri imperialisti: si ha 6,2% e 4,6% contro 4,5% e 3,7%. Ma la decrescita si è manifestata ugualmente e la ripresa nel 2000-2007 è più debole. Invece nel terzo ciclo (1989-2000) l’incremento è più debole – 2,1% contro 2,5% – ciò che si spiega per l’assenza della Cina e per il fatto che un certo numero di questi paesi hanno subito una grave crisi negli anni 1998-1999.
È indubbio il peso crescente nel ciclo 2000-2007 di molti nuovi grandi paesi entrati appieno nel girone del capitalismo come Brasile, India e numerosi paesi dell’Asia del Sud e dell’Est, Indonesia, Filippine, Vietnam, ecc. ecc.
Ma il capitalismo mondiale è tirato soprattutto dalla Cina. Risulta, e lo confermeranno le tabelle seguenti, il peso crescente del capitalismo cinese ed il declino inesorabile dei vecchi centri imperialisti.
Più un capitalismo è giovane più il tasso del profitto vi è elevato. È per questo che i capitali, dalle vecchie metropoli dell’imperialismo, nella loro lotta contro la caduta del tasso del profitto, tendono ad investirsi in regioni e in paesi, come in Cina, ove il capitalismo di origine recente dimostra un impetuoso sviluppo.
Questo fenomeno si osserva, in misura e con determinazioni diverse, anche all’interno dei paesi di antico industrialismo. Negli Stati Uniti, che per la loro dimensione costituiscono un continente, il declino delle vecchie regioni industrializzate dell’Est e del Nord si è accompagnato ad un certo sviluppo al Sud e sulla costa Ovest, di fronte all’Asia, attratto dal centro di gravità economico del mondo che si è spostato, come previsto già da Engels, dall’Atlantico al Pacifico.
Nella terza tabella “La cesura del 1973” abbiamo osservato che gli Stati Uniti nel lungo ciclo 1973-2007 hanno tenuto un tasso di incremento più elevato (2,4%) di tutti gli altri vecchi paesi, sorpassando anche la Germania e il Giappone, che già avevano segnato un tasso di crescita eccezionale nei “30 gloriosi”.
A livello mondiale il fenomeno si ripete ma a scala più grande: tanto più le forze produttive sono sviluppate più è impetuosa la diffusione del capitalismo nelle nuove regioni ed in queste elevato il tasso di crescita. La rapida accumulazione del capitale impone la proletarizzazione sempre maggiore di strati di contadini e di artigiani la quale, per lo sviluppo attuale delle forze produttive, si diffonde ad una velocità ben maggiore che nei decenni e nei secoli passati. Di conseguenza la mondiale società borghese invecchia molto più velocemente e si avvicina più rapidamente alla sua fine e al passaggio necessario alla società comunista.
È la lotta contro la caduta del tasso del profitto che spiega perché la grande borghesia industriale e finanziaria e i suoi propagandisti non hanno che una parola: “mondializzazione”! Bisogna aprire le frontiere affinché le merci ed i capitali circolino liberamente in tutti i paesi e continenti. I mercati nazionali dei maggiori imperialismi sono divenuti troppo stretti per gli apparati produttivi nazionali ed il capitalismo cerca una sua ultima speranza di vita non più in Europa o in America del Nord ma in Asia e in Africa. Da qui la frenesia di investimenti verso questi continenti ove si spostano alcune produzioni già monopolio dell’Occidente. I capitali che non trovano impiego in Europa o in America del Nord si investono nei “Brics” (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), e soprattutto in Cina.
Riproduciamo qui un grafico che mostra la folgorante ascesa degli investimenti diretti in Cina dal 1992, e soprattutto dal 2004. Si confronti l’aumento degli incrementi degli ultimi due cicli: 7,9% e 12,9%! L’Ocde non indica la parte dei capitali che vanno nell’industria e quella investita nei servizi, sicuramente perché la Cina non glieli fornisce, ma si può ritenere che la parte del leone vada all’industria.
INVESTIMENTI DIRETTI STRANIERI IN CINA
Miliardi di dollari - Fonte Ocde
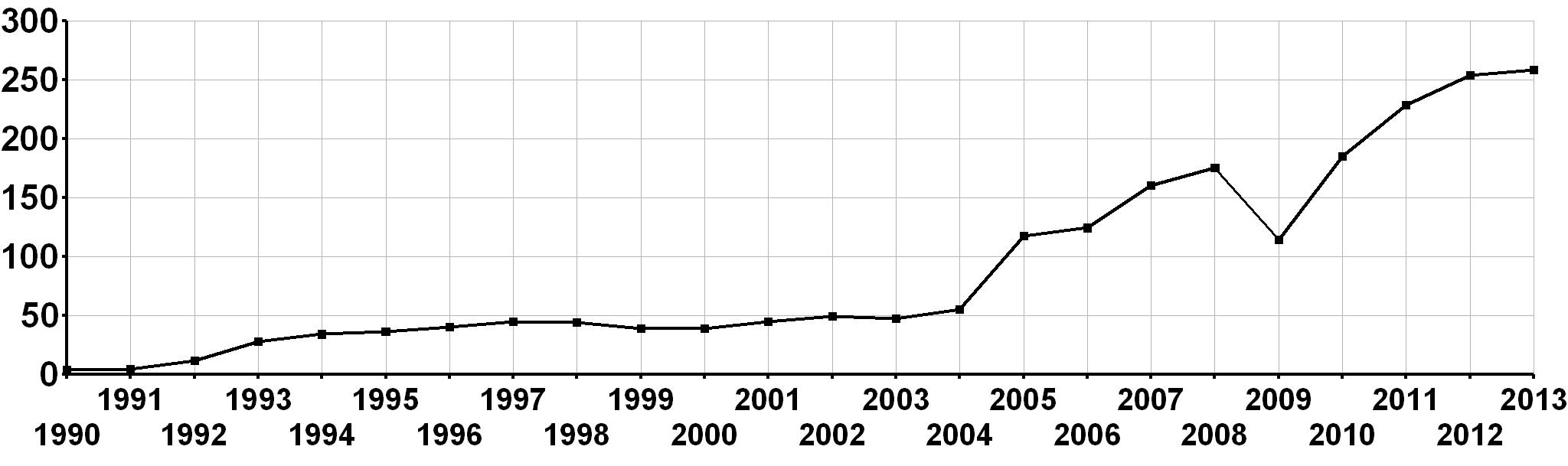
Nella prospettiva di favolosi profitti le multinazionali hanno investito massicciamente in Cina, contribuendo a fare di questo paese la nuova “fabbrica del mondo”. La esplosiva crescita cinese ha contribuito a rallentare il declino del capitalismo mondiale e a rimandato nel tempo la inevitabile crisi di sovrapproduzione e deflazione che noi attendiamo e che sappiamo inevitabile, e che farà uscire il proletariato dal suo stato di abbrutimento e lo ricondurrà sulla via obbligata della lotta di classe.
Nuovi rapporti di forza
Sempre basandoci sulla produzione di elettricità abbiamo impostato un’altra tabella che riporta il peso industriale in percentuale dei principali paesi, insieme al peso percentuale della popolazione. Combinando i due dati, cioè dividendo il peso industriale per il peso della popolazione e moltiplicandolo per 100 abbiamo calcolato la “intensità industriale relativa”, indice dello sviluppo della forma capitalista di un paese dato rispetto alla media mondiale. Gli anni in testa alle colonne corrispondono a quelli di fine dei cicli di accumulazione.
Abbiamo qui predisposto due versioni della tabella, una dove i paesi sono in ordine per anzianità decrescente del capitalismo, l’altro, sulla base dell’anno 2007, sono ordinati in funzione del peso industriale e dell’intensità qualitativa.
| DISTRIBUZIONE DELLA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la riga rappresentante Urss/Russia, fino al 1979 si tratta della prima, poi, a partire dal 1989, della seconda.
Quando si legge la tabella orizzontalmente, si constata il declino inesorabile dei vecchi capitalismi, mentre i paesi di capitalismo giovane vedono il loro peso aumentare regolarmente, soprattutto la Cina.
La Gran Bretagna, che pesava ancora circa il 7% negli anni ‘60, è caduta al 2% nel 2007. La Francia, che faceva 3,8%, non pesa più che il 2,8%. E la Germania con il suo 6,1% nel 1973, non è che al 3,2%. La Russia dal 9,2% nel 1989 è caduta al 5,1% ed il declino continua. La grande potenza americana, che si accaparrava il 40% della produzione industriale mondiale nel 1960, vede la sua parte ridotta circa alla metà: 21,7%. Il che è ancora enorme e nessun paese la raggiunge. Solo la Cina vi si avvicina: è passata dal 2,7% nel 1973 al l’8,9% nel 2000, e poi in solo 7 anni ha quasi raddoppiato il suo peso industriale, il che è davvero considerevole!
L’imperialismo cinese conta sul tempo per raggiungere, poi superare gli Stati Uniti: il perso industriale degli Stati Uniti declina, mentre quello della Cina cresce ancora. Nei suoi calcoli la borghesia cinese sa che arriverà il momento in cui l’industria cinese sarà capace di produrre più armi di quanto non possano fare gli Stati Uniti.
Ciò che dimentica, come tutte le borghesie del mondo, è la crisi! Nei calcoli dei borghesi, qualunque sia la loro nazionalità, le crisi non appaiono mai. Invece oggi il capitalismo cinese, proprio come i concorrenti giapponesi, americani ed europei, è sull’orlo di una spaventosa crisi di sovrapproduzione, la cui ampiezza supererà ogni precedente di Cina e di fuori. Ed è possibile che, travolto dalla crisi economica, della quale già si scorgono le nere nuvole all’orizzonte, il regime stesso sprofondi, proprio come per la Unione falsamente denominata Sovietica nel 1991; o che questa crisi dia il via alla preparazione della terza guerra mondiale.
Ma l’imperialismo cinese non attende di aver numericamente “sorpassato” quello americano per già allungare le mani e mostrare i denti. Forte della montante potenza industriale, per mettere al sicuro le sue vie di approvvigionamento marittimo si sbriga a darsi una flotta militare e basi navali in acque profonde, in Pakistan e nello Sri Lanka, avanzando rivendicazioni a detrimento dei vicini sul Mar della Cina.
Due sono dunque oggi i pesi massimi: gli Stati Uniti e la Cina. Segue l’Europa col 12,2%, ma questa non costituisce una unità politica e militare; è al contrario divisa in una moltitudine di Stati con interessi divergenti. Viene in quarta posizione il Giappone (5,7%), poi la Russia (5,1%), seguita dall’India (4,0%).
Sappiamo che la Cina, col 20,8%, e l’India, col 17,8%, concentrano gran parte della popolazione mondiale. L’Europa e gli Stati Uniti sono quasi uguali con rispettivamente il 5,4% e il 4,8%. La Russia e il Giappone sono alla pari col 2,2% e il 2,0%.
Altra parte importante della tabella, per apprezzare non il rapporto di forza fra i diversi Stati ma il loro grado di sviluppo, e la Intensità industriale relativa.
Se avessimo calcolato la produzione pro-capite di elettricità, chilowattora diviso popolazione, un indice di intensità industriale assoluto invece che relativo, avremmo rilevato che questa non regredisce mai in alcun paese: la storia può camminare, più o meno velocemente, ma in una sola direzione e, salvo catastrofi temporanee, l’apparato tecnico-materiale-sociale-culturale resta acquisito. Insomma, i vecchi e marcescenti capitalismi non sono e non saranno mai meno capitalistici e virulenti di ieri: la, infame, civiltà capitalista rallenta, non torna addietro. A vantaggio dei rivoluzionari.
Questa permanente vitalità e turbolento rivoluzionamento del capitalismo in Occidente lo dimostra anche il fenomeno, interno ai vecchi centri imperiali, del trasferirsi delle fabbriche dalle tradizionali regioni di impianto a regioni già dedite all’agricoltura. È quel che sta accadendo, per esempio, in Belgio dove la Vallonia, antica sua regione industriale, cede il posto alle Fiandre, che mostrano da decenni un forte sviluppo industriale; lo stesso in Germania con la Baviera che accoglie nuove industrie piuttosto che il tradizionale Nord, o in Francia dove il Nord-Est si è trasformato in un deserto industriale, con gran numero di disoccupati, a vantaggio delle regioni dell’Ovest, o della Gran Bretagna con il Sud che prende il posto del Nord.
Relativamente invece tutte le vecchie metropoli regrediscono, pur ancora restando nel mondo alla testa della intensità industriale. Gli Stati Uniti, che nel 1960 erano quasi a tre volte gli europei, si sono oggi ridimensionati al doppio, ancora quindi sorpassano ampiamente tutti gli altri ma confermano il loro declino relativo. Ogni capitalismo, dopo aver raggiunto un massimo, avendo accumulato a velocità superiore alla media mondiale, poi rallenta sotto quella media e, relativamente, regredisce. Questa regressione dei vecchi esprime l’utile diffondersi del capitalismo a tutto il pianeta, certo fertile e necessaria premessa della rivoluzione comunista, anche se ai piccolo borghesi occidentali tutto questo appare un “decadimento” sul piano sociale, economico, culturale e morale.
All’altro estremo abbiamo la Cina e l’India che presentano una intensità qualitativa molto debole, il che indica che larghi settori della società vi sono ancora allo stadio precapitalista. Da segnalare la differenza fra la Cina con 77 e l’India con 23: lo sviluppo capitalista è nettamente maggiore o diffuso sul territorio in Cina. Benché la loro intensità industriale sia debole, questo non toglie che questi Stati dispongano, in assoluto e potenzialmente, di risorse gigantesche e che sono capaci di mobilitare energie ben superiori a quanto può fare la Germania, la Francia o anche la Russia.
La Corea continua a vedere il suo peso industriale e la sua intensità qualitativa progredire, ma non per lungo tempo, pare, visti gli incrementi della produzione industriale in forte rallentamento, annunciando una crisi prossima (vedi la tabella sui cicli).
Negli ultimi 34 anni, dopo la crisi internazionale del 1974, la situazione mondiale è quindi enormemente cambiata. Fino alla fine degli anni Ottanta il mondo si è trovato diviso fra il blocco occidentale – Giappone, Europa – dietro agli Stati Uniti e il blocco russo. La Cina negli anni Sessanta non aveva alcun peso e solo nel 1973 sorpassava appena l’Italia. Poi il blocco russo è rovinato. La Cina rappresenta il 16% della produzione industriale mondiale, mentre la Russia non è che al 5,1%.
Tutti gli Stati finiranno per schierarsi dietro gli Stati Uniti o dietro la Cina. La Russia, che come tutti gli Stati ha i suoi interessi da difendere, vorrebbe giocare alla pari con i grandi e ritrovare lo splendore di un tempo, ma è una illusione.
Capitolo esposto a Genova nel gennaio 2013 [RG115]
Verso il partito marxista
Il 16 luglio 1876, sotto la direzione di Andrea Costa, si era riunito a Bologna il congresso regionale. Le sezioni rappresentate erano 24, risorte nel giro di un mese.
Venne presentato ed approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno: «Forti della nostra forza, noi ci proponiamo fermamente di combattere per l’attuazione delle idee che Michele Bakunin con noi professava». Allo stesso tempo fu approvata la proposta di mettere gli Statuti generali dell’Internazionale in testa al programma, poiché essi «rappresentano il terreno comune sul quale i lavoratori di tutti i paesi, quali ch’esse siano le loro opinioni politiche o religiose, s’incontrano [... e ...] in essi e per essi noi tutti ci sentiamo solidali e fraternamente vincolati». Ad un quesito sull’atteggiamento da tenere verso il governo e gli altri partiti era data la direttiva per «un’attiva propaganda di principii [... per ...] la formazione di una nuova coscienza popolare» e di «approfittare della disgregazione de’ partiti borghesi per costituire il grande partito socialista rivoluzionario».
Rimaniamo quindi nel campo dell’anarchia mentre, però, cominciano a penetrarvi concetti a questa estranei, soprattutto il riconoscimento della necessità del partito.
Nella stessa estate si tennero i congressi delle federazioni marchigiana-umbra, toscana e romana. Fu poi indetto il congresso nazionale, che si sarebbe tenuto ad ottobre. Da Bari fu posto il quesito «se sia utile e decoroso all’Associazione Internazionale prender parte alla lotta per le elezioni politiche, affinché da puri socialisti siano affermati e propugnati i principii della grande Associazione in faccia alla borghesia risiedente in parlamento». Altro importante quesito venne da Firenze: «Al socialismo sono indifferenti le forme politiche o gli giova promuovere l’istituzione di una repubblica possibile?». Come si vede il socialismo italiano comincia a prendere le distanze dalla impostazione anarchica, anche se in un modo timido e contraddittorio.
Intanto, in stretta sintonia con il giornale La Plebe era nata la Federazione Lombarda dell’Associazione Internazionale degli Operai. Come si ricorderà La Plebe era stato l’unico giornale socialista italiano che non aveva aderito al bakuninismo mantenendo un atteggiamento favorevole alle posizioni del Consiglio Generale di Londra, «anche se – aveva detto Engels – senza molta energia».
La Federazione Lombarda, il 1° luglio 1876, aveva lanciato un manifesto in cui prendeva netta distanza dalle «Società di Mutuo Soccorso, le quali negano il male esistente, [ed essendo] dirette dai privilegiati, non possono recare alcun rimedio alla nostra situazione». Altrettanta distanza prendeva dalle cospirazioni insurrezionali le quali «non possono, in massima, servire che di pretesto ad una implacabile repressione», e concludeva: «Se per queste parole qualcuno ci accusasse di essere troppo opportunisti e troppo pacifici, noi risponderemmo agli impazienti che noi siamo impazienti quanto e più di essi, ma che non possiamo farci illusioni intorno a conati destinati ad aver sempre un esito infelice, e che sapendo di non poter attualmente riuscire a qualche cosa se non alla condizione di essere il numero e di essere un’organizzazione, noi attendiamo a divenire numerosi e di essere organizzati. Ed è giustamente per ciò che noi, quanto essi rivoluzionari, anzi nel senso scientifico della parola, più rivoluzionari di coloro che ci muovono questi rimproveri, ci organizziamo». Infine auspicava la costituzione di un «grande Partito Operaio d’Italia» che ponesse le basi «di una possente Federazione Internazionale».
Un altro dissenso all’impostazione anarchica e contro le «sollevazioni inconsulte» veniva da Palermo: «La nostra non è una bandiera di sterili agitazioni improvvisate, né segnacolo ad impazienze individuali, è la bandiera del proletariato, non di alcuna fazione, di alcuna camarilla» (Il Povero, 25 ottobre 1876).
Questi erano i deboli e limitati segnali critici che si manifestavano all’interno del movimento anarchico alla vigilia del Congresso nazionale della Federazione italiana.
Convocato a Firenze per il 22 ottobre, dové subire i «furori della polizia nicoteriana». Nel corso della nostra trattazione abbiamo più volte messo in evidenza la repressione che i governi borghesi della Destra avevano scatenato contro l’Associazione Internazionale, ma la Sinistra, andata al governo nel 1876, non fu da meno: il Nicotera, ex cospiratore compagno di Pisacane, ora nuovo ministro degli Interni, scatenò una persecuzione fino ad allora mai vista. Alla Camera, rispondendo ad una interrogazione di Felice Cavallotti affermò che gli anarchici «in Romagna erano accoltellatori, nel Napoletano camorristi, mafiosi in Sicilia». Nella sua lettera al barone Nicotera, Andrea Costa scriverà: «Contro l’Internazionale si sono diramate più circolari da che siete Ministro, che non da quando ella esiste».
Mentre i delegati affluivano a Firenze da ogni parte d’Italia e molti già avevano preso alloggio in città, Nicotera diramò alla polizia l’ordine di impedire ad ogni modo il congresso. Il giorno 19 Andrea Costa fu arrestato per avere contravvenuto all’ammonizione; molti altri congressisti intercettati dalla polizia furono presi e messi in carcere e la sala della riunione venne militarmente occupata.
Nicotera, in parlamento giustificava questo suo comportamento asserendo che «nella riunione di Firenze intervenivano taluni ammoniti. Un congresso di ammoniti non lo vorrà neanche l’on. Salarini. Essendo innegabile che molti di coloro che dovevano recarsi a Firenze erano ammoniti, domando se credete che gli ammoniti debbano essere trattati, in quanto al diritto di riunione, come è trattata la gente non ammonita». Inoltre, «molti internazionalisti sono quasi analfabeti e non bisogna confonderli con i pensatori, cogli scienziati, coi pubblicisti».
In effetti di ammoniti ce n’era solo uno, ed era già stato arrestato: Andrea Costa. Riguardo al secondo argomento lasciamo a Costa la parola: «Qual conseguenza vorreste trarre dall’essere molti internazionalisti quasi analfabeti? Vorreste riserbarlo il diritto di riunione solo ai pensatori ed agli scienziati? [...] Ma allora molti dei vostri deputati e colleghi, e voi stesso, onorevole ministro, sareste privi di un tal diritto».
Quelli tra i delegati che riuscirono a sfuggire all’arresto, decisi a tenere ugualmente il congresso, per sfuggire le ricerche della polizia uscirono da Firenze e, sotto un’acqua torrenziale, si incamminarono a piedi in direzione di Pontassieve, ma trovarono il paese presidiato da una compagnia di soldati e da ingenti reparti di carabinieri e guardie di pubblica sicurezza. Gli anarchici con tenace determinazione, sempre sotto una pioggia battente, presero la via dei monti in direzione di Tosi. In una locanda del luogo trovarono momentaneo rifugio dall’acqua, ma non dall’inseguimento della polizia. Furono allora costretti a riprendere il cammino inoltrandosi nel fitto del bosco e lì, sotto gli alberi e la copiosa pioggia mandata da un dio avverso, tennero finalmente il loro congresso. L’arresto preventivo di Andrea Costa e del Bignami permisero a Cafiero di determinare l’esito del movimentato congresso, ammesso che possa definirsi tale una riunione condotta in quelle condizioni.
Andrea Costa, nella lettera a Nicotera, dirà: «Espulsi dalla città, si andò nella campagna, inseguiti quivi dai vostri birri si fecero nove ore di aspro e faticoso cammino, attraverso ai monti, e sotto pioggia dirotta, si chiese un asilo ai boschi, e lì proprio all’aria aperta si tenne quella riunione il cui pericolo [...] aveva fatto proibirla a Firenze».
Il congresso di Tosi ribadì quindi tutta l’impostazione di stretta osservanza bakuninista che bene è riassunta in queste poche righe della deliberazione sulla tattica: «Tutti i delegati presenti riconobbero non potersi in alcun modo risolvere la quistione sociale senza la rivoluzione; l’agitazione rivoluzionaria [«la propaganda del fatto» - n.d.r.] essere il solo mezzo efficace e non corruttore che i socialisti anarchici posseggono per interessare le masse e trascinare le forze vive dell’umanità nella lotta contro il privilegio; la partecipazione alle lotte elettorali, siano pure politiche o amministrative, devia il proletariato e ne fa uno strumento incosciente dei partiti politici borghesi, e qualunque concorso dei socialisti alla installazione di una repubblica o di altra qualsiasi forma di governo costituisce un vero tradimento alla causa dell’umanità».
Al Congresso internazionale antiautoritario, che si tenne a Berna dal 26 al 30 ottobre 1876, furono delegati a rappresentare l’Italia Cafiero e Malatesta. Dopo il Congresso i due protestarono contro il resoconto ufficiale, che avrebbe riportato in modo inesatto le affermazioni di Malatesta, inviando una lettera di rettifica: Malatesta non avrebbe detto che l’Internazionale in Italia fosse divisa quando la grande maggioranza dei socialisti italiani aderiva al programma anarchico che concepiva «il fatto insurrezionale come il mezzo più idoneo per affermare i principi socialisti», mentre solo un piccolo gruppo cercava di fare una propaganda «graduale e pacifica».
Abbiamo sempre affermato che l’accusa di gradualismo e pacifismo, che gli anarchici affibbiavano a tutti i loro avversari di intonazione marxista, era del tutto gratuita. Doveva essere ben chiaro che la partecipazione alle elezioni e la lotta per la conquista delle riforme, se allora distingueva i socialisti dagli anarchici, non implicava affatto ammettere che il proletariato potesse conquistare il potere politico per via legale e senza rivoluzione armata.
Prendevano sempre più campo piccole o grandi correnti che si distanziavano dall’anarchismo e dal verbo di Bakunin, anche se in modo spesso confuso ed oscillante.
Lo stesso Andrea Costa nel gennaio 1877 dichiarava: «Per mezzo della cospirazione si può ottenere un cangiamento di forma nel governo; può spodestarsi o pugnalarsi un principe e mettersene un altro al suo posto; ma operare la rivoluzione sociale, come l’intende e vuole l’Internazionale, è impossibile. Per ottenere questo, è mestieri diffondere ampiamente i nuovi principi nelle masse, o meglio risvegliarli in esse, poiché già li hanno istintivamente, ed organizzare i lavoratori di tutto il mondo, affinché la rivoluzione si compia da se stessa, dal basso all’alto e non viceversa, per via di legge e di decreti, o con la forza. E questo importa necessariamente pubblicità, essendo impossibile conciliar l’idea di una propaganda così vasta con la cerchia necessariamente ristretta di una cospirazione» (da “Alcuni Internazionalisti a Nicotera”). Anche se, come vediamo, Costa ancora non ha maturato una netta separazione dall’anarchismo, questo lo pone già in contrasto con le teorizzazioni della scuola di Bakunin.
Prime delimitazioni dall’anarchia ed il giudizio di Engels
A metà febbraio 1877 si tenne il Congresso della Federazione dell’Alta Italia che poneva su più larghe basi territoriali quanto già intrapreso dalla Federazione Lombarda. Seguendo gli interventi dei vari delegati si può notare la netta rottura con il movimento anarchico.
La rivoluzione e la nuova società non si improvvisano,
«di getto, con un fiat [...] Se il socialismo non dà mano ad altri mezzi, se non viene a porgere con altri mezzi un sollievo alle classi più sofferenti, arrischia di intorpidirsi, di sfiduciarsi, lasciando aperto l’adito agli avversari astuti di cacciarsi essi in mezzo alle classi sofferenti, illuderle con questi o con quei ripieghi, acquistarne le simpatie, e intralciare così l’opera nostra».
«Siamo rivoluzionari ed impazienti quanto altri mai di riuscire; ma appunto perché vogliamo riuscire, attendiamo con tutte le nostre facoltà a far sì che il nostro diritto, per numero e per organizzazione, diventi una vera e grande forza d’azione».
«Noi pure non respingiamo la rivoluzione, ma vogliamo che essa trovi un terreno preparato [...] Fare della propaganda per arrivare alla rivoluzione, e non delle rivoluzioni per fare propaganda».
«Lo crediamo noi pure che si dovrà arrivare ad un ultimo sforzo violento; ma bisogna prepararsi ad esso con tutti i mezzi possibili [...] Non è gridando: Anarchia! Rivoluzione! che persuaderemo le masse, bensì dimostrando come sia necessaria una grande riforma economico-sociale [...] Per persuadere bisogna parlare e scrivere [...] E allora perché non parleremo nel Reichstag in Germania, nei grandi Consigli dei Cantoni in Svizzera, nei grandi parlamenti insomma, come parliamo nelle nostre sezioni e nei nostri circoli?»
Quelli che seguono sono alcuni stralci delle conclusioni del congresso:
«Considerando che il socialismo deve mirare al soddisfacimento completo dei grandi bisogni che fermentano in seno all’umanità e che hanno un carattere di universalità, il partito socialista non deve per questo trascurare di porgere sollecita mano soccorrevole a bisogni immediati, particolari, urgentissimi, col mezzo, per esempio, di associazioni, di casse di resistenza, d’aiuti morali e materiali, perché il suo posto dev’essere sempre là dove v’è un’ingiustizia da combattere, una piaga da sanare, una sofferenza da lenire;
«Considerando d’altra parte che l’adozione d’un solo mezzo – designato restrittivamente col nome di rivoluzione – escluderebbe il grande metodo sperimentale e lascerebbe sovente il proletariato nell’inerzia e benanco alle suggestioni dei partiti politici;
«Considerando che, dovendo il socialismo diventare tutto, è necessità si mostri e si affermi da per tutto;
«Considerando ch’esso deve essere perciò una forza morale, intellettuale e materiale, e che per essere tale gli occorre l’indefesso studio e l’indefessa propaganda delle nuove idee redentrici di giustizia e d’amore, e in pari tempo l’aiuto costante e progressivo delle multiformi associazioni del lavoro, e preferibilmente quelle per arti e mestieri, sorte dal seno delle associazioni promosse da circoli socialisti, collegate tutte in una federazione generale cogli stessi principi col carattere di solidarietà;
«Considerando, finalmente, che la pratica attuazione di questi o quei mezzi, sia essa suggerita da speciali circostanze di luogo o da generali esigenze di tempi, mirando sempre al supremo nostro scopo profondamente rinnovatore e umanitario, non può che assecondarne o assicurarne il compimento;
«Il Congresso della federazione dell’Alta Italia e nuclei aderenti, radunato nei giorni 17 e 18 febbraio 1877, crede che, per le suesposte considerazioni, non sia da trascurarsi, per lo sviluppo e trionfo del socialismo, mezzo alcuno, dalla semplice parola d’un propagandista alla manifestazione la più energica delle moltitudini».
La Federazione non si costituisce come partito, ma ne dichiara la necessità e le caratteristiche di classe: «Il partito socialista deve costantemente affermare la propria esistenza, come forza indipendente da qualsiasi governo e da qualsiasi partito politico o religioso». Dichiara inoltre di aderire agli Statuti dell’Internazionale e che l’organizzazione sindacale rappresenta il rimedio all’ «infecondo mutuo soccorso» ed al «romanticismo rivoluzionario».
Engels, che aveva sempre seguito con grande interesse e continuità le vicende italiane, scriveva a Marx il 23 febbraio:
«La settimana scorsa ho scritto a Bignami, facendo l’abbonamento a La Plebe e dandogli notizia delle elezioni [...] Nel numero del 16 febbraio vi è una corrispondenza da Bruxelles sul nuovo movimento fiammingo per la legge sulle fabbriche e per il suffragio universale che termina con le parole: “Noi crediamo altresì di arrivare, con questo metodo, più prontamente e più puramente, all’emancipazione del proletariato, piuttosto che star lì, abbaiando alla luna per degli anni e dei quarti di secolo, e attendendo che mamma Rivoluzione voglia degnarsi di venire a spezzarci le catene dei lavoratori” [...] Oggi ricevo una lettera molto entusiasta di Bignami, in cui dice che avrebbe pubblicato le mie cose sulle elezioni, e conferma che la Federazione dell’Alta Italia che da Venezia va fino a Torino e tiene in questi giorni il suo congresso, vuole lottare sul terreno del suffragio universale. La Plebe è il suo organo ufficiale. In Italia dunque la breccia nella fortezza degli avvocati, letterati e ciondoloni è fatta. E la miglior cosa è che tutti i vecchi alleanzisti di Milano, Mauro Gandolfi, ecc. dell’epoca di Cuno, sembra si siano schierati anch’essi da questa parte. In realtà un movimento pseudo-operaio in una città industriale come Milano non era possibile che per poco tempo. E l’Alta Italia decide non solo strategicamente, ma anche per il movimento operaio, delle sorti della lunga penisola contadina».
Engels sul Vorwärts del 16 marzo 1877 commenterà in maniera entusiastica i risultati di questo congresso:
«Finalmente anche in Italia il movimento socialista è stato posto su un solido terreno e promette un rapido e vittorioso sviluppo [...] Cresceva di giorno in giorno il malcontento degli operai dell’Alta Italia per la proibizione di ogni attività politica, cioè di ogni vera attività che esca dai limiti delle chiacchiere vuote e dell’attività cospiratrice. Le vittorie elettorali dei tedeschi nel 1874 e il risultato da essi conseguito, l’unificazione dei socialisti della Germania, erano noti anche in Italia. Gli elementi che provenivano dal vecchio movimento repubblicano, e che si sottomettevano solo a malavoglia agli strilli “anarchici”, si sono messi ad approfittare sempre più spesso dell’occasione per sottolineare la necessità della lotta politica e hanno avuto modo di esprimere l’opposizione che nasceva su La Plebe. Questo giornale settimanale, di tendenza repubblicana nei primi anni della sua esistenza, ha presto aderito al movimento socialista e si è tenuto nella misura del possibile lontano da ogni settarismo “anarchico”. Quando, infine, nell’Alta Italia le masse operaie hanno sorpassato i loro dirigenti importuni e hanno dato vita ad un vero movimento al posto di quello fantastico, hanno trovato ne La Plebe un organo che pubblicava volentieri di tanto in tanto allusioni eretiche alla necessità della lotta politica [...] Il 17 e il 18 febbraio si è tenuto a Milano un congresso della Federazione dell’Alta Italia. Nelle sue risoluzioni il congresso si astiene da ogni ostilità superflua e inopportuna contro i gruppi bakuninisti membri italiani dell’Internazionale. In esse si esprime persino la disposizione a prender parte al congresso che viene convocato a Bruxelles, congresso che dovrà compiere un tentativo di unire le varie frazioni del movimento operaio europeo. Ma al tempo stesso essi avanzano con la massima precisione tre punti di importanza decisiva per il movimento italiano:
«1) che per assicurare il successo del movimento devono essere impiegati tutti i mezzi possibili, quindi anche quelli politici;
«2) che gli operai socialisti devono costituirsi il partito socialista, partito che non dipenda da qualsiasi altro partito politico o religioso, e
«3) che la Federazione dell’Alta Italia, a condizione della sua autonomia e sulla base degli Statuti iniziali dell’Internazionale, si considera membro di questa grande Associazione, membro che non dipende da tutte le altre associazioni italiane, alle quali, però, essa continuerà a fornire anche per l’avvenire prove della sua solidarietà.
«Quindi: lotta politica, organizzazione di un partito politico e rottura con gli anarchici. Con queste risoluzioni la Federazione dell’Alta Italia ha ripudiato definitivamente la setta bakuninista e si è posta sul terreno comune del grande movimento operaio europeo. E dato che essa abbraccia la parte dell’Italia più sviluppata industrialmente — la Lombardia, il Piemonte, il Veneto — i suoi successi non si lasceranno attendere molto. Di fronte all’impiego degli stessi ragionevoli mezzi di agitazione, corroborati dall’esperienza di tutti gli altri paesi, il vaniloquio dei ciarlatani bakuninisti rivelerà molto presto la sua impotenza e il proletariato italiano anche nel Sud del paese, si libererà presto del giogo degli uomini che fanno derivare la loro missione di guidare il movimento operaio dalla propria condizione dei borghesi rovinati».
“Partire dalle campagne”: la Banda del Matese
Se in campo anarchico una parte, impersonata da Costa, metteva in dubbio le teorie bakuniniste e ripudiava la pratica del complotto, altra parte, di stretta fede anarchica, capeggiata da Cafiero, riproponeva come unica strategia possibile il moto insurrezionale. Poiché il misero fallimento della congiura del 1874 nulla gli aveva insegnato, Cafiero e gli altri anarchici si misero ad organizzare una nuova azione insurrezionale.
Se nel precedente tentativo l’insurrezione avrebbe dovuto partire da una città del centro-nord, Bologna, questa nuova avrebbe avuto il suo centro nelle campagne e nei monti del meridione. Gli organizzatori di quella che venne definita la “Banda del Matese” erano Cafiero, Malatesta e Ceccarelli.
In una lettera di qualche anno dopo, del 1881, indirizzata ad Amilcare Cipriani, il Ceccarelli spiegava quali furono le ragioni del moto e della scelta dei luoghi. Venne scelto il Matese «perché è una giogaia che si trova al centro del sistema dei monti del Mezzogiorno, atta per la sua struttura alla guerra di banda, abitata da una popolazione battagliera che dette un contingente fortissimo al brigantaggio e che credevamo e crediamo disposta a ricominciare». Questo per quanto riguarda la questione logistica. Per quanto riguarda la scelta di partire dalla campagna e non dalla città, Ceccarelli scriveva: «I mille moti spontanei avvenuti nei comuni rurali ci danno ragione di fondare le nostre più grandi speranze sui contadini». I “guerriglieri” anarchici avrebbero ottenuto la “liberazione” dei comuni rurali, che sarebbe servita da miccia per provocare l’esplosione rivoluzionaria: «principale nostro obiettivo deve essere provocare la rivolta dei contadini, la jacquerie. Là è la salvezza della rivoluzione [...] Persuasi che la rivoluzione bisogna provocarla, noi facemmo atto di provocazione».
Anche in questa occasione, come per il tentativo del 1874, la polizia era a conoscenza fin nei minimi particolari di quanto si stava architettando. La guida della banda, conoscitore della zona per aver partecipato alla repressione del brigantaggio, era una spia della polizia. Ancora una volta la polizia lasciò indisturbati i cospiratori per coglierli in flagrante.
Il questore di Napoli scriveva al prefetto il 26 marzo 1877: «In continuazione della mia nota del 14 corrente [...] sui progetti dei moti internazionali mi affretto a soggiungerle quanto segue. La casa che deve servire di riunione ai capi del movimento e di deposito delle armi è stata presa a pigione negli scorsi giorni a San Lupo [...] a cui si accede dalla stazione di Solopaca [...] Comunico alla S.V. Ill.ma le suaccennate notizie con la massima riservatezza, raccomandando che le indagini che si volessero praticare a San Lupo sieno le più oculate e le più segrete, onde non dar motivo alcuno di sospetto ai caporioni del progettato movimento. Secondo il mio remissivo avviso sarebbe bene che i caporioni stessi venissero sorpresi solo quando si trovassero riuniti in detta casa con le armi, e quando cioè fosse arrivato il momento opportuno per colpirli efficacemente [...] Compiere le relative operazioni quando le notizie che continueranno a pervenirmi mi faranno conoscere quando sia il momento di operare».
La banda, che avrebbe dovuto essere composta da più di un centinaio di partecipanti, di fatto si ridusse alla metà della metà.
Poiché la dottrina anarchica nega per principio ogni tipo di autorità, un terribile dilemma si pose alle loro coscienze: quello della direzione delle operazioni militari. Il problema non era da poco, non può esistere esercito senza un comando, ma qualsiasi comando rappresenta la negazione della libertà: che fare? Si trattava di trovare un escamotage che riuscisse a conciliare le due inconciliabili alternative: libertà ed autorità. Fu trovato un compromesso decidendo che il comando delle operazioni sarebbe stato assunto giorno per giorno da un diverso componente, senza alcuna distinzione. Il comandante di giornata sarebbe stato riconoscibile da una fascia rossa cinta ai fianchi.
Ma la contraddizione si risolse da se stessa perché l’esperienza guerrigliera fu brevissima. Per la descrizione dei fatti ci atterremo ad alcuni stralci della relazione di Malatesta inserita nella circolare della Commissione di Corrispondenza dell’8 giugno:
«Mille cause han concorso al nostro insuccesso; ma più delle altre, due furono principalissime.
«1°) Non aver avuto il tempo di completare la nostra organizzazione;
«2°) La cattiva stagione che ci rovinò con le nevi e con le piogge.
«Infatti non era ancora giunta che la quarta parte degli amici che aspettavamo, quando la truppa, preceduta da una vanguardia di carabinieri venne per sorprenderci: fummo costretti a pigliare i monti, senza aspettare gli altri [...] Alcuni altri amici per una coincidenza fortunata riuscirono a raggiungerci, ma erano senz’armi, e dovemmo dividere con loro le armi che avevamo. Restammo in campagna sei giorni; e facemmo il più di propaganda possibile. Entrammo in due Comuni, bruciammo l’archivio comunale, i registri delle imposte e tutte le carte ufficiali su cui potemmo mettere le mani, distribuimmo al popolo i fucili (inservibili, è vero) della fu guardia nazionale, le accette sequestrate ai contadini nel corso di vari anni per contravvenzione alle leggi forestali, ed il poco denaro che trovammo nella cassa dell’esattore di uno dei due comuni. Rompemmo il contatore del macinato, e poscia spiegammo al popolo, che tutto entusiasmato si era riunito in piazza, i nostri principi, che furono accolti con la più grande simpatia. Non potemmo far di più per mancanza di forza e di tempo. Nicotera aveva scagliato contro di noi tutto un Corpo d’armata, che faceva ogni sforzo per chiuderci in mezzo [...]
«Il popolo di Gallo e di Letino (i due comuni da noi occupati) invitato da noi a collettivizzare la proprietà, lo avrebbe fatto volentieri: ma, ci dissero, “il paese non è nello stato di difendersi [...] domani verrebbe la truppa e ci massacrerebbe, ecc." e noi non sapevamo dar loro il torto [...] Finalmente l’acqua e la neve venne a rovinarci. Eravamo circondati per ogni dove: una sola ritirata sicura ci restava; e questa era per un monte altissimo coperto di neve, traversato il quale ci saremmo trovati in altra Provincia, della quale forse il governo non sospettava. Camminavamo con la pioggia fin dalla mattina; verso il tardi arrivammo ai piedi di questo monte; e pioveva sempre; montiamo per un’ora colla neve fino al ginocchio, e pioveva sempre; la nostra guida non era pratica del monte; i più deboli fra i nostri incominciavano a restare indietro; qualcuno dichiara che non può fare un passo di più. Intanto arriva la nebbia: siamo costretti a ritornare indietro, e ripararci in una masseria. Grondavamo acqua da ogni parte; e quel che è peggio, grondavano acqua i nostri fucili e le nostre munizioni. [...] La truppa arriva e ci fa prigionieri senza che possiamo fare un colpo; le nostre armi non avrebbero preso fuoco in una fornace».
Furono tratti in arresto anche i due preti dei comuni occupati e che, tra gli abitanti, più di tutti avevano solidarizzato con gli anarchici. Il parroco di Letino, dopo che Cafiero ebbe parlato al popolo, volle addirittura prendere la parola qualificando gli insorti come dei «veri apostoli mandati dal Signore per predicare le sue leggi divine».
Gli insorti catturati, ristretti nelle prigioni di Santa Maria Capua Vetere, vennero deferiti alla Corte di Assise con le accuse di cospirazione, insurrezione, ribellione, incendio.
Il 9 gennaio 1878 moriva re Vittorio Emanuele II ed il 19 dello stesso mese Umberto I, per ringraziare dio del posto che si era liberato, concedeva una amnistia per tutti i reati politici, così gli arrestati che non avevano preso parte all’azione militare vennero liberati nei mesi successivi. Gli altri restarono in carcere a causa di uno scontro a fuoco avvenuto a San Lupo dove due carabinieri rimasero feriti, uno dei quali morì poco dopo. Durante i 15 mesi di carcerazione gli anarchici si dedicarono allo studio e Cafiero iniziò il famoso “Compendio del Capitale” che fu molto apprezzato dallo stesso Marx.
Al processo, che si svolse a Benevento nell’agosto 1878, tutti gli imputati vennero assolti. Dopo la lettura della sentenza, nella sala scoppiò un fragoroso applauso. Gli imputati, messi in libertà, scesi in piazza vennero attorniati e scortati da una folla di popolo festante. Ma i rivoluzionari non possono fare affidamento sulla folla, facile sia all’acclamazione che al vituperio.
“Prima il partito, poi la rivoluzione”
Ma, esito del processo a parte, la repressione si scatenò contro tutto ciò che aveva odore di socialista; il governo emanò un decreto che dichiarava sciolte tutte le federazioni, sezioni, circoli e gruppi dell’Associazione Internazionale, ordinava la chiusura dei suoi locali ed il sequestro di tutto ciò che vi si trovava. I giornali dell’epoca mettevano in evidenza come tutti quanti i ministri erano stati unanimi sulla opportunità di tale decreto. Perquisizioni ed arresti furono effettuati su vasta scala in tutta la penisola. In più luoghi l’esercito occupò paesi e città bivaccando nelle piazze. Atti di provocazione vennero compiuti per farne ricadere la colpa sugli anarchici.
Per tentare di distruggere definitivamente l’internazionalismo una serie di processi si svolsero in diverse regioni d’Italia. Al processo di Firenze del 1879 vennero comminate pene severissime: un ergastolo, due condanne a 20 anni, e quattro a 19. Nel processo che si aprì a Bologna il 9 novembre 1879 tra gli imputati spiccò un personaggio femminile il cui ruolo assumerà importanza nel socialismo italiano degli anni successivi: Anna Kuliscioff. La sua compiuta maturità politica può essere ricavata da queste sue affermazioni pronunciate nel corso dell’interrogatorio:
«Le rivoluzioni non le posson fare gli internazionalisti a loro comodo, perché non è nelle forze degli individui né di farle, né di provocarle; è il popolo che le fa: quindi non conviene insorgere in bande armate, ma attendere che quelle rivoluzioni e quelle bande si formino per dirigerle ai principii socialisti. I socialisti debbono prendere parte ai movimenti popolari, come ad ogni altra manifestazione della vita popolare, per dirigerli, ma non possono crearli essi stessi. La rivoluzione deve partire dal popolo e non può esser fatta suo malgrado [...] Il socialismo deve essere pronto a prendere la direzione del movimento, convertire gli istinti, i sentimenti che sono latenti nel cuore del popolo, in forze socialiste. Il movimento non è il socialismo che lo crea, ma è promosso dalla anormalità in cui versa la società attuale e dalla miseria dei più».
Nel settembre 1877, per iniziativa di alcune associazioni del Belgio, si era tenuto a Gand un congresso universale con lo scopo di riavvicinare le varie tendenze socialiste. Lì Zanardelli, delegato dei circoli socialisti di Milano, Lodi, Palermo e Siena, riaffermò la linea di rottura con il movimento anarchico. Dichiarò che i socialisti avevano il compito di fare una «propaganda attiva, incessante, più vasta di quella ch’è stata fin’oggi», perché non ci si doveva aspettare «il miracolo di una sollevazione più o meno spontanea» fino a quando «l’immensa maggioranza [non] sarà mossa da una convinzione profonda e illuminata [...] Quello che bisogna fare oggi – affermò – è, avanti tutto, della propaganda per giungere alla rivoluzione e non la rivoluzione per fare propaganda. Prima la tribuna, poi la barricata: dei rivoluzionari prima, poi la rivoluzione».
Invece Andrea Costa, che al congresso di Gand ripropose le classiche tesi anarchiche, mantenne in quegli anni il suo atteggiamento confuso e oscillante. Anche nella famosa lettera «Ai miei amici di Romagna», inviata il 27 luglio 1879 a La Plebe, non c’è una posizione netta di rottura con la teoria anarchica, più che altro sembra un invito rivolto al movimento anarchico a riesaminare il passato, senza rinnegarlo, e a procedere oltre facendo un bilancio delle passate esperienze e traendo insegnamento dalle sconfitte subite:
«Miei cari amici! Noi ci troviamo, parmi, alla vigilia di un rinnovamento. Noi sentiamo tutti o quasi tutti che ciò che abbiam fatto fino ad ora non basta più a soddisfare né la nostra attività, né quel bisogno di movimento senza cui un partito non esiste: noi sentiamo insomma che dobbiamo rinnovarci o che i frutti del lavoro che abbiam fatto fin qui saranno raccolti da altri [...] Io sono ben lungi dal negare il passato. Ciò che facemmo ha la sua ragion d’essere [...] Noi facemmo quello che dovevamo fare». Non rinnega i moti insurrezionali, «la propagazione delle idee per mezzo dei fatti [...] Ma i tentativi di rivoluzione falliti, avendoci privati per anni interi della libertà, o avendoci condannati all’esilio, noi ci disavvezzammo disgraziatamente dalle lotte quotidiane e dalla pratica della vita reale: noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi e ci preoccupammo assai più della logica delle nostre idee e della composizione di un programma rivoluzionario, che ci sforzammo di attuare senza indugio, anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e de’ suoi bisogni sentiti ed immediati. Noi trascurammo così fatalmente molte manifestazioni della vita, noi non ci mescolammo abbastanza al popolo: e quando, spinti da un impulso generoso, noi abbiamo tentato d’innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti, e ci ha lasciati soli [...] Come vedete, non si tratta di rigettare il nostro passato, di cui, nonostante le sventure e i molti disinganni sofferti, possiamo per sempre andar fieri; né di cessar di essere quel che fummo; si tratta solamente di far di più e di far meglio».
Andrea Costa non aveva compreso un fatto essenziale, che ormai erano in formazione due opposti partiti, con programmi incompatibili, e che indietro non era possibile tornare. Di fatto con questa lettera Andrea Costa si poneva fuori dell’anarchismo. Giustamente Malatesta commentò «Costa non è più d’accordo con noi», e Cafiero tagliente aggiunse: «La propaganda non ci accosta al popolo ma alla borghesia [...] disgiunta dal lavoro segreto ci ammollisce, ci abitua a pascer di frasi e di parole, a cullarci nella speranza. La propaganda ci divide, il lavoro segreto ci unisce». Troppo facile sarebbe ironizzare sulla “segretezza” del lavoro cospirativo svolto dagli anarchici!
Andrea Costa, rientrato clandestinamente in Italia dove era ancora ricercato dalla polizia, il 14 marzo 1880 partecipò ad una riunione nella quale venne dichiarato che «i socialisti [...] sono convinti che l’attuazione del nuovo ordinamento sociale non può avvenire se non in seguito ad una lotta violenta e che non lasceranno sfuggire qualsiasi occasione per promuovere e sostenere questa lotta [... ma ...] intendono tuttavia valersi di tutti quei mezzi che lo stato attuale di cose può loro offrire sia per diminuire la resistenza che [il governo] ci oppone, sia per provocare l’ottenimento immediato di tutte quelle riforme che possono facilitare la via all’attuazione dell’ideale socialistico o provocare la lotta tra il vecchio e il nuovo ordine di cose, almeno incominciare una agitazione di cui i socialisti approfitteranno sia per diffondere sia per attuare dove sia possibile tutto o in parte il loro programma».
Ormai sembra che tra Costa e Cafiero, difensore al oltranza del programma anarchico, non ci sia più possibilità di intesa. Agli anarchici, che avevano definito come «empiastri di cattiva lega sulle piaghe dei lavoratori» ogni tipo di rivendicazione di riforma sociale, compresa la lotta per la diminuzione delle ore di lavoro, Costa risponde: «Voler opporsi, per esempio, all’agitazione che si propone di ottenere la diminuzione delle ore di lavoro? Ma perché? A vantaggio di chi? Io mi meraviglio che non abbiano detto che bisogna, invece, agitarsi perché si lavori 20 ore al giorno!». E continua: «L’agitazione economica e sociale avverrà con o senza que’ rivoluzionari che pretendono opporsi in nome di non so quali principii assurdi allo svolgimento naturale del secolo. Oh, come sentono poco l’odore del popolo certe risoluzioni! E come è naturale che gli operai preferiscano il marchese Popoli! E noi li trattiamo da imbecilli! Gli imbecilli siamo noi, che, superbi delle nostre teorie, ci alziamo al di sopra del popolo [...] Le invocazioni continue all’ideale che trovo in queste risoluzioni mi fanno male alla pancia. L’Ideale, un cavolo! Io, per me, preferisco che l’operaio lavori un’ora di meno al giorno ed abbia un piatto di più sulla tavola a tutti gli ideali aristocratici del mondo».
Il mancato congresso di Milano e il clandestino di Rimini
A Milano, per il 4 maggio 1880, era stato indetto un congresso per la costituzione del partito socialista. Senonché qualche giorno prima il questore convocava il Bignami e gli notificava che il congresso era stato proibito per decreto del prefetto e che si sarebbe risposto con misure repressive qualora si fosse tenuto clandestinamente. Il Bignami rispose che i socialisti, abituati a essere considerati alla stregua dei fuorilegge, avrebbero sottostato a tale arbitrio solo per risparmiarsi spese e disagi inutili.
Anche se il congresso non ci fu è interessante il manifesto in cui si affermava: «Bisogna che ci uniamo e ci intendiamo non solo per riaffermare i nostri principi generali, ma per determinare la nostra condotta pratica di ogni giorno e di ogni momento, e quale azione immediata possiamo esercitare sullo stato attuale delle cose per diminuire gli ostacoli che esso oppone ad uno stato di cose migliore» (La Plebe, 4 aprile 1880).
Costa appoggiò l’iniziativa scrivendo che «un’insurrezione ad ogni costo ci sembra altrettanto assurda quanto la legalità ad ogni costo [...] La legalità ad ogni costo conduce all’evirazione sociale; l’insurrezione ad ogni costo non conduce, spesso, se non al trionfo dei propri avversari, quando avviene, di fatto, discredita chi la predica quando alle parole non seguono i fatti» (Rivista Internazionale del Socialismo, 15 maggio 1880).
Nell’aprile del 1881 egli fondava a Cesena l’ Avanti!... dove si affermava che «la borghesia ha ormai compiuto il suo ufficio secolare: essa abbatté energicamente le tirannidi politiche, interne ed esterne, e i pregiudizi religiosi, concentrò i capitali e le forze di lavoro, inaugurò lo sfruttamento colossale della natura e riuscì a sottometterla all’uomo; ma nel tempo stesso preparò gli strumenti della propria rovina: chiusasi nel suo egoismo di classe non vide le miserie che cagionava [...] strettasi avidamente ad una forma di proprietà, sparisce con quella forma medesima». Questa breve citazione è sufficiente per affermare che Costa è ormai approdato nel campo del marxismo.
In luglio, o in agosto, la data è controversa tra gli storici, verrà convocato il congresso clandestino di Rimini cui parteciparono circa quaranta delegati, rappresentanti una cinquantina di circoli o sezioni romagnole, più una rappresentanza dei socialisti marchigiani. Nasceva così il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, ma il congresso esprimeva il proposito di promuovere la costituzione di un Partito Socialista Rivoluzionario Italiano e a questo scopo dava mandato alla Commissione federale «di mettersi in relazione con le associazioni e coi nuclei socialisti, esistenti in Italia». Una commissione fu incaricata di redigere il progetto di programma del nuovo partito, da inviare a tutte le organizzazioni aderenti e da sottoporre poi all’approvazione del prossimo congresso. Il progetto, pubblicato dopo pochi giorni, si componeva di due parti: Programma e Regolamento. Si tratta di un documento di fondamentale importanza per la nascita e lo sviluppo del partito in Italia.
Nella nostra “Storia della Sinistra” leggiamo:
«La premessa al programma del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna (Rimini 1881) è […] di una straordinaria lucidità, e di una formulazione ineccepibile:
«“Considerando:
«“che condizione primordiale della emancipazione umana delle classi lavoratrici, e perciò di tutti gli esseri umani, è la emancipazione economica;
«“che questa non può ottenersi se non quando le classi lavoratrici delle città e delle campagne si impossessino, pel bene di tutti, della terra e dei capitali e, per conseguenza, di tutto il potere politico militare e sociale, che dà il loro possesso;
«“che, l’esperienza storica dimostrando come una classe privilegiata non ceda mai pacificamente i suoi privilegi secolari, l’appropriazione della terra, dei capitali e di ogni potere sociale non può avvenire se non per via di rivoluzione, tanto che la rivoluzione non è soltanto il miglior modo, che noi proponiamo, per isciogliere efficacemente la questione sociale ed emancipare le moltitudini, ma è una fatalità storica inevitabile, che noi non facciamo se non formulare, rendere cosciente ed affrettare con tutte le forze nostre; per queste ragioni:
«“il Partito Socialista di Romagna è e non può non essere rivoluzionario.
«“La rivoluzione è, prima di tutto, un’insurrezione materiale violenta delle moltitudini contro gli ostacoli, che le istituzioni esistenti oppongono alla affermazione e alla attuazione della volontà popolare.
«“La rivoluzione è perciò, prima di tutto, dittatura temporanea delle classi lavoratrici, cioè accumulazione di tutto il potere sociale (economico politico militare) nelle mani dei lavoratori insorti, allo oggetto di atterrare gli ostacoli, che il vecchio ordine di cose oppone all’instaurazione del nuovo, di difendere, di provocare, di propagare la rivoluzione, e di eseguire l’espropriazione dei privati, di stabilire la proprietà collettiva e l’ordinamento sociale del lavoro”.
«Il programma osserva poi che la “trasformazione dalle radici di tutto l’ordinamento sociale” al quale il socialismo mira, non può avvenire per opera “di cospirazioni, di raggiri diplomatici e di decreti”, né di “tentativi di rivolta di minoranze audaci” (tentativi che non sconfessa, ma lascia alla “iniziativa individuale”), bensì richiede “non solamente la cooperazione degli individui coscientemente socialisti e rivoluzionari, che non sono generalmente mai se non una piccola minoranza, ma [...] la cooperazione efficace ed energica delle moltitudini dei salariati industriali e agricoli”.
«Non respinge le riforme e le rivendicazioni immediate e contingenti, ma proclama che “per noi [esse] non sono che un’occasione, un mezzo di attrazione e di lotta — mezzo passeggero il quale non impedisce che rendiamo possibili e approfittiamo di altre manifestazioni dell’attività popolare e rivoluzionaria, particolarmente quando ogni manifestazione legale ci sia resa impossibile”.
«Dichiara che la rivoluzione deve: “Essere preceduta da un’ampia propagazione delle idee socialistiche-rivoluzionarie ed aver per organo un partito fortemente ordinato [ecco un balzo avanti nettissimo dal concetto anarchico del partito come rete elastica di gruppi autonomi, o addirittura del non-partito], capace di provocarla, quando esistano le condizioni necessarie alla sua buona riuscita, e d’inspirarla e anche di dirigerla, quando sia scoppiata.
«Perciò il nostro partito ha un doppio oggetto: quello di svegliare con la parola, con gli scritti, con gli esempi, e all’uopo con altri mezzi, le moltitudini assopite delle città e delle campagne, preparandole alla rivoluzione che si va compiendo inesorabilmente nella società per opera di quegli stessi fattori sociali, che ora ci tengono oppressi; e quello di approfittare della occasione favorevole per rovesciare le moltitudini stesse sull’ordine esistente, inspirarle e dirigerle nella lotta e far ogni sforzo perché la rivoluzione dia quei frutti, che le moltitudini ne aspettano”.
«Quanto sappiamo dell’Andrea Costa dei momenti migliori, tra l’altro precursore del più reciso anticolonialismo, permette a noi di inserirlo nella traccia storica dell’autentica sinistra italiana.
«Abbiamo qui l’attestazione programmatica della dittatura marxista del proletariato […] Essa non era ignota in Italia, sebbene soffocata dalla menzogna che gli anarchici sono per la violenza e che i socialisti se ne staccarono per pacifismo sociale»
Tornando sugli ultimi anni della
A.I.L.: dal 1871 al 1883
Fra marxismo, lassallismo ed anarchia
La storia dei partiti politici negli Stati Uniti prende le mosse già negli anni ’20 del secolo XIX, con il Working Men’s Party. Ben presto però questa strada viene abbandonata, e la massa degli operai delle poche industrie allora esistenti, degli arsenali e delle botteghe artigiane si dedica a costruire organizzazioni sindacali, che promettono una efficace difesa delle condizioni di vita e di lavoro. Una storia molto ricca, che abbiamo descritto nei resoconti del lavoro di partito presentati alle riunioni generali. Sul piano politico invece i risultati sono scarsi, e la classe operaia americana passa attraverso le esperienze deludenti di cooperativismo, collaborazione con partiti borghesi, movimenti moralisti vari, fino al coinvolgimento nella guerra di secessione del 1861-65.
La guerra è sotto questo punto di vista uno spartiacque: la necessità di darsi una veste politica, per lottare efficacemente in nome di tutta la classe, viene sentita e si traduce nel tentativo di trasformare un organo sindacale, la National Labor Union, in un vero e proprio partito. L’esperienza ha breve durata, ma il coinvolgimento che determina nella classe, favorito anche dalla lotta per le otto ore, è fondamentale nell’aprire la strada a un movimento più modernamente politico della classe. E, soprattutto, a rendere possibile l’attività della Associazione Internazionale degli Operai, la Prima Internazionale.
Partito e sindacato
Una caratteristica del movimento operaio negli Stati Uniti per gran parte della sua storia è stato il mancato collegamento tra le sue componenti politica ed economica, tra il partito e i sindacati. Per la scuola marxista è essenziale la definizione dei ruoli e il corretto rapporto tra queste due manifestazioni di energia del movimento.
La questione si era posta in tutta la sua importanza nei dibattiti all’interno della Prima Internazionale, che si era costituita come una Associazione di generiche organizzazioni operaie. Ma, pervenuta alla sua Conferenza a Londra, tenuta il 17-23 settembre 1871, si affermava:
«Considerando
«che all’inizio degli Statuti viene detto: “L’emancipazione economica della classe operaia è il grande scopo al quale ogni movimento politico è subordinato come mezzo”;
«che l’Indirizzo inaugurale dell’Associazione Internazionale degli Operai afferma: “I padroni della terra e del capitale non vogliono che una cosa: impiegare i loro privilegi politici per difendere e perpetuare i loro monopoli economici. Non certo vogliono favorire l’emancipazione del lavoro, anzi, non vogliono se non continuare a frapporle ogni sorta di ostacoli... La conquista del potere politico è perciò diventato il grande dovere della classe operaia”;
«che il Congresso di Losanna (1867) ha dichiarato: “L’emancipazione sociale degli operai non può essere disgiunta dalla loro emancipazione politica”; che la dichiarazione del Consiglio generale sul preteso complotto degli internazionalisti francesi alla vigilia del plebiscito (1870) conteneva il passo che segue: “Secondo i nostri statuti, tutte le nostre sezioni in Inghilterra, sul continente e in America hanno senza dubbio il compito specifico non soltanto di costituire punti centrali per l’organizzazione militante della classe operaia, bensì di appoggiare nei loro rispettivi paesi ogni movimento politico, che contribuisca a far raggiungere il nostro scopo finale: l’emancipazione economica della classe operaia”;
«che erronee traduzioni degli Statuti originali hanno dato luogo a interpretazioni false, che hanno danneggiato lo sviluppo e l’efficacia dell’Associazione Internazionale degli Operai;
«Considerando inoltre
«che l’Internazionale si trova di fronte a una reazione sfrenata, che reprime spudoratamente ogni sforzo di emancipazione dei lavoratori, e intende eternare attraverso la bruta forza le diversità di classe e il predominio, fondato politicamente su di questa, delle classi possidenti;
«che la classe operaia, contro questo potere collettivo delle classi possidenti, può agire come classe soltanto allorquando si costituisce come partito politico particolare, contrapposto a tutte le vecchie formazioni partitiche delle classi possidenti;
«che questa costituzione della classe operaia in partito politico è indispensabile per il trionfo della rivoluzione sociale e del suo fine ultimo: l’abolizione delle classi;
«che l’unione delle singole forze, che la classe operaia fino a un certo punto ha già edificato tramite le sue lotte economiche, deve servire anche come leva per la sua battaglia contro il potere politico dei suoi sfruttatori;
«per questi motivi, la Conferenza ricord a tutti i membri dell’Internazionale:
«che, nello stato militante della classe operaia, il suo movimento economico e la sua azione politica sono indissolubilmente uniti».
Marx affronta in modo deciso la questione in una lettera al suo discepolo americano Bolte, il 23 novembre 1871:
«Il movimento politico della classe operaia ha naturalmente come scopo finale la conquista del potere politico per la stessa classe operaia, e a tal uopo è naturalmente necessaria una precedente organizzazione della classe operaia, giunta a un certo grado di sviluppo, che nasca dalle stesse lotte economiche.
«D’altra parte, però, ogni movimento tramite il quale la classe operaia come classe si contrappone alle classi dominanti e le preme dall’esterno, è un movimento politico. Ad esempio il tentativo di costringere i singoli capitalisti, in singole fabbriche o anche in singole officine tramite scioperi ecc., a concedere una diminuzione dell’orario di lavoro, è un movimento puramente economico; invece il movimento per la conquista di una legge per le otto ore ecc. è un movimento politico. E in questo modo dagli isolati movimenti economici degli operai nasce ovunque un movimento politico, cioè un movimento della classe per conseguire i propri interessi in forma generale, in una forma che possiede forza generale, forza socialmente coercitiva. Se questi movimenti accettano una certa organizzazione preesistente, essi rappresentano nello stesso tempo uno stimolo per lo sviluppo di questa organizzazione.
«Se la classe operaia non è ancora abbastanza progredita nella sua organizzazione per intraprendere la lotta decisiva contro il potere collettivo, cioè il potere politico delle classi dominanti, deve almeno essere educata tramite la costante agitazione contro la politica delle classi dominanti (e l’atteggiamento ostile alla politica). Altrimenti rimane uno strumento nelle loro mani».
Al successivo congresso dell’Associazione, tenuto all’Aja, 2-7 settembre 1872, dove si consumò la definitiva separazione dei comunisti dagli anarchici, fu approvata la seguente scultorea Risoluzione:
«L’articolo seguente, che riassume il contenuto della risoluzione della Conferenza di Londra (settembre 1871), sarà inserito negli statuti dopo l’articolo 7:
«Art.7a - Nella lotta contro il potere collettivo delle classi possidenti, il proletariato non può agire come classe se non costituendosi esso stesso in partito politico distinto, opposto a tutti i vecchi partiti formati dalle classi possidenti.
«Questa costituzione del proletariato in partito politico è indispensabile per assicurare il trionfo della rivoluzione sociale e del suo fine supremo: l’abolizione delle classi.
«La coalizione delle forze operaie, già ottenuta attraverso la lotta economica, deve anche servire da leva in mano a questa classe, nella lotta contro il potere politico dei suoi sfruttatori.
«Poiché i signori della terra e del capitale si servono dei loro privilegi politici per difendere e perpetuare il loro monopolio economico e asservire il lavoro, la conquista del potere politico diventa il grande dovere del proletariato».
Lassallismo e marxismo
La questione si era posta già ai primi autentici rappresentanti del marxismo sin dal momento in cui avevano posto piede sul suolo americano, primo tra tutti Joseph Weydemeyer, che lottò a fondo contro le illusioni utopistiche di Wilhelm Weitling per riaffermare i corretti moduli di organizzazione della classe operaia, e per la sua difesa e per la presa del potere.
Quando, un anno più tardi, il Consiglio Generale dell’Internazionale si trasferì in America, il programma del “comunismo autoritario” avrebbe continuato ad essere difesa dal nuovo Segretario Generale, il fedele amico e seguace di Marx, Friedrich Sorge.
La posizione dalla frazione lassalliana, che nell’Internazionale aveva una presenza significativa e all’epoca anche influente, era invece molto diversa. Per essa le lotte economiche erano necessariamente condannate alla sconfitta perché, nella loro lezione, i livelli salariali erano imposti dalle immutabili leggi dell’economia. Al posto dei sindacati ritenevano quindi si dovessero creare organizzazioni produttive di mestiere, emulazioni dei precedenti di Weitling e Owen, concentrandosi nel costruire una economia alternativa basata sull’assistenza reciproca, sull’autosufficienza e sulle cooperative. Per costruire questa economia su grande scala, che avrebbe avuto bisogno di credito a basso costo e aiuti statali, i lavoratori alle elezioni avrebbero dovuto sostenere i candidati lassalliani. Persuaso il resto dei cittadini della validità del loro programma, gradualmente un numero crescente di votanti si sarebbe avvicinato alla loro idea, e infine il potere politico sarebbe stato conquistato. Nel frattempo, conducendo campagne nelle elezioni cittadine, statali e nazionali, si sarebbe riusciti ad ottenere finanziamenti pubblici ai vari livelli. La prospettiva di una specie di socialismo municipale e statale attirava soprattutto gli artigiani e i lavoratori in proprio.
Evidentemente, la vernice cooperativista copriva una prospettiva sostanzialmente individualista, il cui appello interclassista avrebbe attirato anche i piccoli proprietari, come gli aderenti al movimento Greenback, fautori della Riforma Monetaria, che non a caso ricevettero sostegno proprio dai lassalliani.
Dei Greenbackers, chiamati così per il colore della cartamoneta, scrive Sorge: «Volevano, e ancora vogliono, questi intelligentoni, abolire la valuta sia in oro sia in argento, sostituendola in quantità adeguata con cartamoneta, redimibile solo con titoli di Stato a basso interesse; in altre parole praticamente non esigibile. Subito dopo la Guerra Civile – durante la quale le classi lavoratrici e la grande maggioranza della popolazione avevano subìto forti perdite a causa della fluttuazione del tasso di cambio – questa teoria ebbe una larga diffusione perché le classi possidenti dovevano distogliere i lavoratori dalla difesa dei loro interessi, incanalarne le aspirazioni nella direzione sbagliata e impedire il rafforzamento delle organizzazioni operaie, anzi fare di tutto per indebolirle».
Opposta alla frazione lassalliana e dall’alto della loro ben più ampia e complessiva visione della società comunista, i marxisti auspicavano una organizzazione politica diversa. Il partito politico della classe operaia dei marxisti prevedeva la conquista del potere politico.
Entrambi marxisti e lassalliani allora concordavano nel doversi il partito impegnare nel campo elettorale, in urto con gli anarchici, i quali rifiutavano ogni manifestazione di attività politica della classe operaia.
Ma sarebbe stato proprio negli Stati Uniti, dove il voto era stato prima che altrove esteso ad ampi strati del proletariato, che fu smentita dai fatti la troppo ottimistica possibilità di una “via pacifica” al potere delle classi lavoratrici, seppure forti della loro prevalenza numerica.
I marxisti americani non tardarono a notare questa maturità e già nel 1876, al Congresso di fondazione del Partito degli Operai degli Stati Uniti (Workingmen’s Party of the United States), fu affermato che «L’urna elettorale ha da un pezzo cessato di registrare la volontà popolare, e serve solo a falsificarla nelle mani dei politicanti di mestiere». Vista la presenza di «un gran numero di piccoli riformatori e ciarlatani (...) in questa Repubblica borghese», e «considerando che la corruzione e l’abuso dell’urna elettorale, come pure l’insulso movimento riformatore fioriscono soprattutto durante le elezioni presidenziali, minando seriamente l’organizzazione dei lavoratori», le sezioni del partito e in generale tutti i lavoratori sono invitati ad astenersi da qualsiasi campagna elettorale e a dirigere i loro sforzi verso la loro propria organizzazione.
La possibilità che la classe operaia arrivasse a conquistare il potere a seguito di un favorevole risultato nelle urne, auspicato dall’esempio della grande avanzata elettorale del partito tedesco, permaneva solo a condizione della presenza di una ampia base di organizzazioni di massa, informate ad un chiaro senso della propria identità e dei propri interessi di classe, e decise e determinate a perseguirli.
Una tale base organizzata, pensavano i marxisti, sarebbe potuta concretarsi solo nei sindacati, da conquistarsi alla direzione del partito attraverso un lungo e paziente lavoro dei comunisti al loro interno e in occasione di particolari movimenti rivendicativi. Il processo di costruzione di queste organizzazioni, che avrebbe contemplato anche le lotte per riforme tese a migliorare le condizioni di vita della classe operaia, sarebbe stato un utile terreno di addestramento. L’evidente resistenza delle classi dominanti a concedere qualsiasi riforma legislativa tesa a migliorare le condizioni della classe operaia, che faceva sì che ogni passo avanti, anche per risolvere problemi di mera sopravvivenza, richiedesse una strenua lotta, avrebbe aperto gli occhi dei proletari e li avrebbe spinti verso una soluzione politica più radicale e definitiva.
Le lotte dei disoccupati del 1873 smorzarono temporaneamente il conflitto interno all’Internazionale, ma il fallimento finale dell’agitazione sarebbe stato sfruttato dai lassalliani per sostenere la loro tesi, che l’unica soluzione possibile era l’azione sul piano politico, che per essi significava elettorale e volto alla concessione da parte dello Stato di forme cooperative di organizzazione del lavoro, in gran parte compatibili con il capitalismo.
I marxisti replicarono che invece le dimostrazioni dei disoccupati avrebbero dovuto continuare, in quanto imponevano un qualche sollievo per le famiglie affamate e senza casa, avvicinavano i lavoratori alle idee socialiste ed erano un’opportunità per far capire ai lavoratori che solo il socialismo poteva porre fine allo sfruttamento delle masse. Inoltre quell’azione politica si sarebbe basata sulla classe operaia e non, come preteso dai lassalliani, su una coalizione di qualsiasi gruppo disposto a mobilitarsi per l’aiuto statale alle imprese cooperative.
Non disposti ad attenersi alle direttive dell’Internazionale, i lassalliani se ne separarono nel 1874, per fondare all’Ovest il Partito degli Operai dell’Illinois (Workingmen’s Party of Illinois) e all’Est il Partito Socialdemocratico degli Operai del Nord America (Social-Democratic Workingmen’s Party of North America). Il fallimento alle elezioni dello stesso anno li costrinse però, nelle successive convenzioni di partito, ad ammettere l’importanza delle organizzazioni sindacali.
L’influenza del partito in Germania
Nel frattempo in Germania i due partiti operai, l’Associazione Generale degli Operai Tedeschi e il partito “Eisenachiano” pro-Internazionale, influenzato dai marxisti e guidato da Wilhelm Liebknecht e August Bebel, erano sulla strada della riconciliazione. Nel 1874, prima ancora della fusione che avrebbe avuto luogo un anno dopo, i due partiti avevano raggiunto dimensioni impressionanti e raccolto quell’anno 350.000 voti portando al Reichstag nove deputati.
Al famoso Congresso di Gotha del 1875, i due partiti avrebbero elaborato un programma di compromesso accettabile da entrambi, per poi fondersi per formare il Partito Social-Democratico.
In America Sorge apprezzò il programma per il Congresso di Gotha, redatto da Liebknecht, soprattutto per l’importanza ivi attribuita all’organizzare degli operai nei sindacati (di fatto la sua ammirazione per il veterano socialista tedesco era stata una delle principali ragioni della sua rimozione da membro del Consiglio Generale dell’Internazionale nell’autunno del 1874).
Ma fu il successo elettorale dei socialdemocratici tedeschi a fare molta impressione sui socialisti negli Stati Uniti, tanto che nell’autunno del 1875 quella della “unità socialista” era divenuta la questione delle questioni nei circoli sia lassalliani sia marxisti.
All’epoca del congresso di unificazione del 1875, nel suo storico pamphlet Critica del Programma di Gotha Marx versò molto fiele sullo zucchero “unitario” e deprecò che fossero state fatte troppe concessioni ai lassalliani. Nel periodo delle leggi anti-socialiste in Germania, 1878-1890, introdotte dopo due attentati anarchici alla vita del Kaiser, Marx e Engels avevano ritenuto di non dover attaccare in pubblico i lassalliani del partito tedesco, anche se non risparmiavano loro critiche vigorose attraverso le lettere e le circolari interne di partito. Solo nel 1891, quando il programma di Gotha fu infine abbandonato in occasione del Congresso di Halle, Engels si sentì di rendere pubblica la critica di Marx, considerandola di “significato molto ampio” come resa dei conti con i principi economici e la tattica lassalliani.
Negli Stati Uniti però lo scontro tra le due frazioni del partito era già emerso apertamente.
La “Legge Bronzea dei Salari”
La Critica del Programma di Gotha, e la lettera a Bracke che l’accompagna del 5 maggio 1875, come la lettera di Engels a Bebel del 18 marzo sono documenti ben noti e forniscono una analisi complessiva del lassallismo. Ci limitiamo qui ad una sintesi delle dottrine di Lassalle, per delineare lo sfondo del difficile rapporto tra l’ala lassalliana, malamente detta “politica”, e quella marxista, che ugualmente male si definiva “sindacalista”, del movimento socialista degli Stati Uniti negli anni ’70 e ’80.
Nella sostanzialmente maltusiana “Legge Bronzea dei Salari” Lassalle sosteneva che i salari operai avrebbero sempre oscillato intorno a un minimo vitale, in quanto ogni miglioramento salariale avrebbe prodotto un aumento delle nascite nelle famiglie operaie. Questo avrebbe aumentato la concorrenza per il lavoro, e quindi determinato un nuovo abbassamento dei salari. Al contrario, in caso di abbassamenti troppo spinti del salario il tasso di natalità sarebbe sceso, sarebbe aumentata l’emigrazione e i salari avrebbero ripreso a salire. Secondo Marx invece, come descritto nel primo Libro del Capitale, i salari sono influenzati dal rapporto tra l’esercito di riserva industriale, i senza lavoro, e gli operai addetti alla produzione ma, entro certi limiti, determinati dal rapporto di forza fra le classi; il che vuol dire, per esempio, che i salari possono salire in un periodo di aumento del tasso di natalità se contemporaneamente un’espansione economica richiede l’assunzione di un numero ancora maggiore di proletari, e se i proletari hanno la forza per imporlo.
Una importante conseguenza dell’analisi di Marx era la necessità di collegare la lotta dei disoccupati a quella del proletariato alla produzione, l’altra la inevitabilità ed importanza dell’attività sindacale.
L’opinione di Lassalle, secondo la quale le lotte economiche sarebbero inutili, lo portò fino ad opporsi alla lotta per l’abrogazione delle leggi antisindacali, il che sarebbe stato condannato da Marx come estremamente pernicioso, non solo in quanto dedotto dalla errata teoria della “Legge Bronzea dei Salari”, ma come prova del rifiuto di accettare ed incoraggiare la espressione esplicita della attività autonoma della classe operaia.
La “Legge Bronzea”, che escludeva ogni utilità dell’attività difensiva operaia, implicava invece che al lavoratore, se artigiano o operaio specializzato, restasse una sola alternativa: diventare egli stesso un imprenditore aprendo delle sue cooperative; non possedendo capitale, doveva essergli fornito dallo Stato. Come ha commentato un biografo, Lassalle non era tanto marxiano (anche se riteneva di esserlo) quanto hegeliano: «Non pensa in termini di lotta di classe. Ciò che vuole non è lo Stato socialista, ma lo Stato sociale; non lo Stato delle contrapposizioni ma lo Stato dei compromessi».
Le opinioni di Lassalle, forse niente altro che ignara pedina, erano il riflesso dei rapporti di classe dell’epoca in Germania, dove lo sviluppo capitalistico era rallentato da un’avida aristocrazia terriera che sfruttava la sua estremamente complessa e onnipresente struttura statale (giustificata a livello filosofico dai professori hegeliani, essi stessi dipendenti statali) per aggiogare alle sue necessità sia borghesia sia proletariato, attraverso la pianificazione statale e le riforme sociali, con lo Stato arbitro che metteva le diverse classi l’una contro l’altra. A Bismarck non dispiaceva apparire un aristocratico alleato degli operai oppressi dalla borghesia, e adattare elementi del programma di Lassalle ai bisogni della classe che rappresentava. Combinando questa strategia con il lavoro di Rodbertus, un monarchico conservatore e per breve tempo ministro prussiano nel 1848, Bismarck avrebbe costruito un’arma formidabile per boicottare il nascente movimento operaio: il “Socialismo di Stato”.
Il lassallismo, con la sua idea degli operai che creano cooperative finanziate dallo Stato, sarebbe presto stato tradotto nella pretesa che qualsiasi Stato, e non soltanto lo Stato Operaio, avrebbe potuto realizzare riforme socialiste.
Le idee di Lassalle, che riflettevano le particolari contraddizioni della Germania di Bismarck, furono trasportate sul suolo americano e dovettero in larga misura la loro diffusione ai loro seguaci nella comunità degli emigrati tedeschi, allora assai numerosa.
La formazione del Partito degli Operai degli Stati Uniti
In occasione delle dimissioni di Sorge dal Consiglio Generale dell’Internazionale nel 1874, Engels il 12 settembre gli scrisse: «Con le tue dimissioni la vecchia Internazionale ha raggiunto la sua conclusione e la sua fine. E questo è bene. Essa apparteneva al periodo del Secondo Impero, durante il quale l’oppressione che regnava in tutta Europa richiedeva unità e astenersi da polemiche interne al movimento operaio, allora ai suoi inizi».
I tempi erano quindi maturi per formare un Partito di classe. Il Partito degli Operai degli Stati Uniti (Workingmen’s Party of the United States) sarebbe nato due anni più tardi come il primo partito socialista in Nord America, composto prevalentemente di vecchie sezioni della Prima Internazionale. Di fatto il congresso di unificazione e fondazione del nuovo partito ebbe luogo nel 1876, a Philadelphia, negli stessi locali dove una settimana prima il suo ultimo congresso aveva decretato la formale dissoluzione dell’Internazionale.
Nel nuovo partito, dopo diversi tentativi di conciliare l’inconciliabile, gli scontri tra lassalliani e marxisti non potevano non continuare ad imperversare. Anche se il linguaggio e le idee della nuova piattaforma, uscita dalla penna di Sorge, erano marxisti, il partito permaneva nel compromesso. Se adottò la politica sindacale dell’Internazionale, dovette accettare la richiesta lassalliana di ridursi ad organizzazione nazionale invece che internazionale. Sulla questione centrale della “azione politica” la piattaforma prese questa posizione: «L’azione politica del partito si limita a ottenere provvedimenti legislativi negli interessi particolari della classe operaia. Non parteciperà a campagne politiche finché non sarà abbastanza forte da esercitare una significativa influenza». La posizione che chiedeva la necessaria presenza di una organizzazione economica dei lavoratori per potersi impegnare in effettive battaglie nel campo politico era appoggiata dai vecchi membri dell’Internazionale (Sorge, McDonnell, Otto Weydemeyer e Speyer).
Ma il comitato esecutivo nazionale, allora posto in Chicago e dominato dai lassalliani, contrastò questa linea e fece passare una risoluzione che autorizzava le sezioni locali ad impegnarsi in campagne politiche, cioè elettorali, dove le circostanze fossero considerate favorevoli. Inoltre, nonostante le obiezioni di Sorge e degli altri marxisti, la piattaforma sostenne la richiesta lassalliana del trasferimento delle imprese industriali alle cooperative di produttori ad opera del governo.
Mentre i lassalliani insistevano sulla natura intrinsecamente conservatrice dei sindacati, e sul fatto che la conquista del potere politico da parte del partito li rendeva di fatto superflui, i marxisti ribadivano che non vi era nessuna contraddizione tra attività sindacale e azione politica, e che al contrario le due attività erano complementari. Certo i sindacati avevano una visuale che tendeva ad essere ristretta, ma essi non erano per costituzione ostili al socialismo e, sotto la guida del partito, potevano essere portati a comprendere che miglioramenti quali salari più alti e orari più corti, ancorché importanti, non avrebbero risolto alla radice i problemi della classe operaia in regime capitalistico. La lotta per queste conquiste immediate rimaneva importante sia per migliorare le condizioni della classe operaia sia per addestrarla a lottare per il socialismo.
I marxisti su questo potevano contare sui risultati pratici del loro lavoro. Per esempio forti collegamenti si erano stretti tra i marxisti e la Lega per le otto ore di Ira Steward (il “Gruppo di Boston”, dopo che questo nel 1872 si era separato dai Greenbackers). Sorge aveva spedito a Steward copie manoscritte di traduzioni di intere sezioni del Capitale, compresa quella sulla giornata lavorativa, e Steward fece sapere a Sorge che sia lui sia McNeill ne erano rimasti molto colpiti, e che volevano quindi farlo conoscere agli americani. Come scrisse Sorge, «con l’aiuto dei vecchi internazionalisti, i capi della Lega per le otto ore di Boston furono convinti a entrare nel Partito. Questo determinò giustificate speranze per un’espansione del Partito e dei suoi principi negli Stati del New England. L’esecutivo di Chicago, nell’Ovest, non comprese la situazione e la loro goffaggine causò la fuoriuscita dei nuovi del New England».
Le obiezioni dei marxisti alla partecipazione prematura del partito alle campagne elettorali sarebbero state ignorate, e il comitato esecutivo, dominato dai lassalliani, fra i quali il segretario Philip Van Patten, perseverò su quella strada. Così a New Haven furono nominati candidati per le elezioni dell’autunno 1876, e l’esempio fu seguito a Milwaukee, Cincinnati e Chicago, sempre in deroga ai deliberati del partito. Quando poi i risultati elettorali mostrarono che i candidati socialisti di New Haven, Chicago e Cincinnati avevano ricevuto molti voti, e che a Milwaukee sei membri del partito erano stati eletti, i lassalliani si sentirono ancora più giustificati nell’ignorare la tattica del partito e imbastirono un nuovo attacco concertato alla posizione marxista.
Ora i lassalliani si sentivano abbastanza forti per cercare di sostituire i marxisti nel controllo dell’organo in lingua inglese, il Labor Standard, diretto da J.P. McDonnell. Tentarono varie strade, anche sporche, come la manipolazione dei fondi e il controllo della tipografia, per tentare di togliere ai marxisti questo loro importante portavoce, ma il giornale continuò a tenere una posizione favorevole all’esistenza dei sindacati, che sostenne con la pubblicazione di articoli di Engels che riferivano delle attività e delle lotte operaie in Europa.
Mentre avevano luogo queste diatribe scoppiò la grande rivolta del 1877, e il successivo successo elettorale alle elezioni dello stesso anno sembrò avvalorare la prospettiva lassalliana. Nonostante l’opposizione degli ex internazionalisti (Sorge, McDonnell, Weydemeyer e Speyer rifiutarono di partecipare), i lassalliani convocarono una convenzione straordinaria a Newark, New Jersey, per il 26 dicembre 1877; in quell’occasione i partigiani della “azione politica” conquistarono il completo controllo del partito. Il Labor Standard fu tolto dall’elenco degli organi di partito e, come racconta Sorge, «ebbe luogo un completo ripulisti di quello che rimaneva degli Internazionalisti (...) Gli statuti, il programma e il nome dell’organizzazione furono cambiati e modellati secondo il famoso modello d’oltreoceano». Era nato il Partito Socialista del Lavoro (Socialist Labor Party). Il “modello d’oltreoceano” a cui si riferisce Sorge è quello della Socialdemocrazia tedesca.
Continua Sorge: «Come si sa, al congresso di unificazione delle due correnti del movimento operaio tedesco a Gotha, i lassalliani impressero il loro sigillo e le loro idee sul programma e sulla tattica; ma gli eisenachiani, cioè gli internazionalisti tedeschi, assunsero ben presto la guida del Partito Socialista Tedesco nel mirabile sviluppo che seguì all’unificazione. Negli Stati Uniti la situazione era capovolta. Al Congresso di unificazione di Philadelphia (1876) gli internazionalisti americani, sebbene in minoranza (due su cinque), imposero per lo più le loro posizioni; che, però, furono presto neglette, ignorate e infine rinnegate dai dirigenti del nuovo partito. I Vecchi Internazionalisti reputavano pericolosa questa tendenza emersa nel nuovo partito negli anni 1876-1878, ma i loro avvertimenti e le loro proteste furono accolti con arroganza e respinti. In queste circostanze l’attività del partito appariva loro un lavoro di Sisifo; così a poco a poco si tirarono fuori dalla mischia, si dedicarono in prevalenza all’attività sindacale e lasciarono il campo dell’agitazione socialista ai giovani immigrati che, allora, ne presero il controllo».
Sorge, McDonnell, Weydemeyer e Speyer si ritirarono così dal partito per ricongiungersi con Ira Steward, George E. McNeill e George Gunton per formare la Unione Internazionale del Lavoro (International Labor Union).
Poiché abbiamo trattato gli eventi legati a questa organizzazione in un altro recente lavoro di Partito, ci limitiamo ad aggiungere che una delle direttive date dal Congresso dell’Aia al Consiglio Generale dell’Internazionale quando nel 1872 si era trasferito a New York City era che avrebbe dovuto concentrarsi sulla creazione di un sindacato internazionale.
Come racconta Foner, «anche se visse solo cinque anni e non superò il 1882, la International Labor Union è importante per quello che rappresentò e per quello che cercò di compiere. Fu il primo, grande sforzo per organizzare tutti i lavoratori non specializzati in un sindacato, unito ai sindacati dei lavoratori specializzati, per conquistare la solidarietà del lavoro su tutto il territorio nazionale, senza riguardo per nazionalità, sesso, razza, credo, colore o religione».
Il Partito Socialista del Lavoro
Il partito con questo nuovo nome, impostato ai fini elettorali, riscosse un discreto successo alle consultazioni di primavera e autunno 1878. I voti ricevuti a Chicago nella primavera furono circa 8.000 e due socialisti furono eletti nel consiglio comunale. Nell’autunno successivo i socialisti di Chicago elessero 4 membri nel corpo legislativo, un senatore e tre deputati. Agli inizi del 1879 il partito era cresciuto fino a contare circa 100 sezioni in 25 Stati con circa 10.000 iscritti e il successo alle elezioni continuava.
Ma, invece dell’inizio di un’ascesa, fu un suo culmine. Gli avvertimenti dei marxisti circa i pericoli del gettarsi nella politica elettorale senza sufficiente preparazione e senza sostegno dei sindacati si sarebbero presto dimostrati fondati: i voti socialisti nelle elezioni di Chicago dell’autunno 1879 crollarono da 12.000 a 4.800. Quando la seconda convenzione di partito si riunì a Allegheny alla fine del 1879 la sua forza si era notevolmente ridotta: ventiquattro delegati, in rappresentanza di venti sezioni.
I socialisti dell’ “azione politica” furono svelti nell’attribuire la sconfitta alla ripresa dell’economia. Come disse Philip Van Patten, il segretario nazionale del partito: «I lavoratori sfruttati vengono rapidamente riportati all’ordine, e si tappano le orecchie agli appelli della ragione. Stanno vendendo la loro primogenitura per un piatto di lenticchie, rifiutando la prospettiva di una emancipazione avvenire per la bramosia di trascurabili vantaggi del presente». Ma, per quanto lassalliano, dovette fare una concessione ai marxisti: «L’unica struttura affidabile oggi è l’organizzazione sindacale e, mentre gli sforzi anche spasmodici di natura politica spesso otterranno successi solo temporanei, la vera dimostrazione di forza politica è la misura in cui le organizzazioni sindacali sostengono il movimento politico».
Non sbagliava, in effetti, nel dire che i successi elettorali del partito erano dovuti in misura non trascurabile al sostegno che aveva ricevuto dai sindacalisti, e nelle zone in cui il sostegno era venuto a mancare i risultati erano stati deludenti. A Chicago, per esempio, dove il partito aveva riscosso i successi elettorali più clamorosi, Albert R. Parsons, membro fondatore della International Labor Union e presidente della Amalgamated Trade and Labor Unions of Chicago and Vicinity, era stato un importante fautore della realizzazione di una alleanza formale tra sindacati e Partito Socialista.
La scissione del SLP
Nel 1880 il movimento socialista organizzato si spaccò in due fazioni inconciliabili; l’evento, oltre ai contrasti già descritti, fu accelerato da due fatti occorsi in quell’anno.
Il primo riguardava la illegittima esclusione da parte dell’apparato giudiziario di un candidato socialista che aveva ottenuto un seggio a Chicago; il fatto dimostrava che la borghesia era in grado di manipolare la macchina elettorale democratica per ottenere i risultati desiderati.
Il secondo fu la divergenza all’interno del partito sul modo di partecipare alle elezioni presidenziali del 1880. La maggioranza era per un’alleanza con i Greenbackers, i quali chiedevano crediti governativi alle cooperative dei produttori, richiesta analoga a quella dei lassalliani, ed avevano così attratto sezioni del Socialist Labor Party.
Il movimento Greenback, che per molti anni «si era rintanato all’Ovest tra i piccoli agricoltori», riapparve in una nuova forma alla fine degli anni ’70. Come racconta Sorge: «Sapendo molto bene che non avevano possibilità di trovare largo seguito nell’Est industriale senza fare ampie concessioni agli operai, aggiunsero alcune richieste sindacali al loro programma – naturalmente solo sulla carta – e grazie a queste indussero l’esecutivo del SLP a stringere un’alleanza con loro e a inviare una nutrita delegazione alla convenzione per la nomination del loro movimento a Chicago nell’estate del 1880 (...) Il buffo è che quando i socialisti si risolsero a lavorare con la coalizione Greenback-Labor, gli operai avevano già lasciato il partito».
Il risultato dell’alleanza dell’esecutivo con i Greenbackers fu l’uscita per protesta del gruppo di Chicago, che secondo Sorge era «il più attivo e progredito, che non volle più saperne di alleanze con i riformatori». Il gruppo, capitanato da Albert Parsons, seguito dai sindacati, nominò propri candidati indipendenti nelle elezioni locali.
Il partito, notevolmente indebolito dalla secessione, gradualmente ma inarrestabilmente scivolò sulla strada dell’anarchismo.
Le milizie operaie
Una ulteriore spiegazione della scissione proveniva dalla posizione che l’esecutivo aveva preso nei confronti delle “Società di Educazione e Difesa” (Lehr und Wehr Vereine), che erano state costituite dai socialisti di Chicago e Cincinnati.
Anche se queste milizie operaie, nella maggior parte composte da membri del SLP, erano state fondate a partire dal 1875, il loro numero si moltiplicò a causa della repressione seguita al grande sciopero del 1877, durante il quale le forze congiunte di polizia, milizie territoriali ed esercito federale lanciarono violenti attacchi contro gli operai. A Chicago in particolare gli operai erano stati oggetto di una repressione particolarmente brutale, a causa del sostegno efficace e organizzato che avevano dato allo sciopero. A una riunione degli operai mobilieri «la famigerata polizia di Chicago irruppe, disperse i partecipanti, uccise un sindacalista, e gettò le basi per l’aspro e giustificato odio degli operai di Chicago nei confronti degli eroi del manganello» (Sorge). Dopo il 1877 furono costruite, nelle grandi città industriali, fortezze e grandi depositi di armi, e i militari furono addestrati alle tecniche anti-insurrezionali, con la produzione di numerosi manuali sull’argomento.
Per molti anni non fu molto saggio per gli operai che volevano tenersi il posto di lavoro iscriversi ai sindacati, o sostenere movimenti radicali; molti furono costretti a firmare l’impegno a non iscriversi ai sindacati, o addirittura a non sostenere il movimento per le otto ore. La conseguenza inevitabile di tutto ciò fu la discesa del movimento operaio nella clandestinità. Sorge ritenne che la fine della International Labor Union fosse stata almeno in parte imposta dal bisogno di segretezza per gli operai; e questo soprattutto nelle enclave delle aziende, dove «intere città – terreni, case, scuole, chiese, tutto senza eccezioni – appartenevano ai proprietari delle fabbriche, che in questi luoghi regnavano tanto dispoticamente quanto lo Zar di Russia».
Una così forte oppressione esercitata su tutti i lavoratori, e sui loro movimenti e organizzazioni, che arrivava alla violenza e alle uccisioni, fece sì che l’autodifesa armata, e quindi l’azione politica armata, fosse considerata la logica risposta; in fondo l’esempio della Comune di Parigi era ancora un recente ricordo. Non c’è quindi da sorprendersi se in tanti consideravano l’organizzazione segreta di milizie operaie, l’acquisto di armi e l’addestramento nei boschi come una preparazione alla prossima battaglia finale contro il capitalismo – la rivoluzione – nella quale affrontare la polizia e le altre forze del capitale con fucili e bombe.
Il comitato esecutivo nazionale del partito era contrario a queste organizzazioni prevalentemente militari. Van Patten, smascherando la sua politica anti-rivoluzionaria, nel suo rapporto alla convenzione affermava: «poiché sventolano la bandiera rossa e professano un credo socialista, il messaggio alla gente è che i socialisti sono determinati a compiere con la forza quello che non possono ottenere con il voto».
Nel 1878 fu ordinato a tutti i membri del SLP di abbandonare tali organizzazioni.
I sostenitori delle organizzazioni militari non gradirono l’interferenza del comitato esecutivo, e quando la convenzione si riunì proposero una mozione di censura del comportamento dell’esecutivo. La mozione passò, con una maggioranza di pochi voti, dopo un’infuocata discussione.
I club socialrivoluzionari
Nell’insieme, però, la convenzione fu dominata dai moderati e non dai radicali, i quali presto manifestarono un’aperta insoddisfazione nei confronti della gestione del partito. Nel novembre 1880 numerosi membri di New York, appartenenti alle sezioni della sinistra del partito, lasciarono l’organizzazione per fondare un Social Revolutionary Club, che adottò una piattaforma modellata in gran parte sul programma di Gotha del Partito Socialdemocratico Tedesco, anche se inframmezzata di violente frasi anarchiche. Presto altri Revolutionary Clubs sorsero a Boston, Philadelphia e Milwaukee, tutte città con una ampia popolazione di immigrati particolarmente sensibili verso le idee anarchiche dopo le esperienze di repressione nei loro Paesi di origine, e dopo le nuove e amare esperienze vissute al loro arrivo negli Stati Uniti. Particolarmente importanti furono i club di Chicago dei quali i più eminenti componenti erano Paul Grottkau, August Spies e Albert R. Parsons.
Foner scrive: «Il Club di New York aveva partecipato a Londra a un congresso nel quale si era tentato di ridare vita alla Associazione Internazionale dei Lavoratori (IWPA) – la cosiddetta Internazionale Nera – l’organizzazione di anarchici fondata da Bakunin (...) Al ritorno dalla convenzione di Londra, dove avevano affiliato il loro club alla IWPA, i Socialisti Rivoluzionari di New York portarono con sé la dottrina della “propaganda dei fatti”. Secondo questa dottrina solo l’azione cospirativa e il terrore individuale nei confronti della classe dominante potevano riuscire a spingere le masse alla rivolta».
«La convenzione dei Club Socialisti Rivoluzionari del 1881 non ebbe come risultato la nascita di una organizzazione unificata, ma furono adottati un nome – Revolutionary Socialist Party – e una piattaforma. Questa invocava l’organizzazione di sindacati su principi “comunisti” e sosteneva che si sarebbe dovuto sostenere solo quei sindacati che fossero di carattere “progressivo” – un classico esempio di confusione di ruoli tra organizzazioni politiche e economiche, confusione cui i marxisti resistevano con tutte le forze. La piattaforma denunciava anche il sistema elettorale come “una invenzione della borghesia per infinocchiare gli operai” (...) L’arma fondamentale da utilizzare nel combattere il sistema capitalistico era “l’organizzazione armata dei lavoratori, pronti col fucile a resistere all’usurpazione dei loro diritti».
Le caratteristiche del nuovo movimento rimasero oscillanti tra un socialismo di tono radicale e un dichiarato anarchismo.
Fedele espressione di questo eterogeneo movimento fu Johann Most, discepolo di Dühring e traduttore di una versione abbreviata (e penosa, secondo Marx) di Das Kapital. Eletto due volte al Reichstag e due volte incarcerato per “comizi sovversivi”, nel 1878, alla promulgazione della legge anti-socialista, fu espulso dalla Germania. A Londra iniziò a pubblicare Die Freiheit (La Libertà) che, anche se si presentava come un organo semi-ufficiale del Partito Socialdemocratico Tedesco, clandestinamente diffuso in Germania, presto divenne veicolo delle opinioni anarchiche di Most, specialmente dopo che nel 1880 fu espulso dal partito.
In una lettera a Sorge del 19 settembre 1879 Marx dice che, mentre Bernstein (Aaron, zio di Eduard) e altri avevano criticato il giornale di Most in quanto “troppo rivoluzionario”, lui e Engels gli rimproverano di non avere «alcun contenuto rivoluzionario, ma solo di indulgere in un gergo rivoluzionario». In un’altra lettera Engels definisce “vuoto strillare” quello di Die Freiheit, che si vorrebbe «il giornale più rivoluzionario del mondo, ma a questo non si giunge semplicemente ripetendo in ogni riga la parola rivoluzione».
Nel 1881, per aver pubblicato in Russia un articolo che lodava l’assassinio dello zar Alessandro II e invitava ad emularlo, Most fu arrestato e condannato a 16 mesi di lavori forzati. Poco dopo aver scontato la pena Most arrivò a New York. Il grande raduno organizzato per il suo arrivo nella grande sala del Cooper Union Institute nel dicembre 1882 si trasformò in un vero e proprio trionfo per la “vittima della giustizia borghese”, e un corteo trionfale fu il suo giro di propaganda per le principali città del Paese nei primi mesi del 1883.
Ancora Foner: «Ad un congresso degli anarchici americani a Pittsburgh, nell’ottobre 1883, nel quale erano rappresentate 26 città, si costituì la International Working People’s Association. I delegati più eminenti erano Most, Parsons e Spies».
Questo nuovo movimento anarchico rinato su suolo americano, adottato un atteggiamento di maggior riguardo verso i sindacati, sarebbe stato uno spazio naturale ove sfociare la rabbia operaia e i suoi sentimenti di ribellione, nei ristretti limiti dell’individualismo e del volontarismo.
Dopo gli eventi di Haymarket 1886, lo Stato borghese avrebbe chiuso la morsa della sua repressione sull’intero movimento operaio.
Narreremo in un futuro capitolo il succedersi degli eventi che portarono a tale conclusione, insieme alla descrizione del comportamento del Socialist Labor Party attraverso siffatta situazione.
(Continua)
Parte terza - Il capitalismo
F - Il Risorgimento italiano
LA SPEDIZIONE DEI MILLE
1. Breve riepilogo
Il complesso e difficile processo di unificazione italiana prosegue lentamente ostacolato dalle tante contraddizioni che abbiamo descritto nei precedenti rapporti. A livello internazionale, dalla definizione territoriale europea stabilita al congresso di Vienna del 1815, a quello nazionale, tra le maggiori erano: 1) il retaggio storico del frazionamento in una miriade di stati e staterelli tra cui il potente Stato della Chiesa che taglia in due l’Italia e per la sua grande influenza ideale; 2) l’arretratezza produttiva rispetto analoghi paesi europei; 3) il dominio austriaco dispotico e di rapina sulla ricca e sviluppata Lombardia e sulle regioni venete. Lo sviluppo del giovane capitalismo italiano, che richiede un unico e libero mercato interno, muove i sentimenti di una ritrovata unità nazionale libera dal dominio di potenze straniere, pur con forti contrasti tra i sostenitori dei regimi monarchici e i repubblicani, mentre già si fa avanti il pensiero socialista. La scelta del “male minore”, cioè muoversi d’anticipo, quasi controvoglia, pur di ostacolare l’avanzata di repubblicani, mazziniani o socialisti di varia ispirazione, influenza le scelte politiche che a loro volta si traducono in confuse operazioni militari; insomma si avanza perché spinti alle spalle e non in una precisa direzione.
Con il fallimento della prima guerra di indipendenza era svanito per sempre il sogno di una guerra federale dei principi italiani contro l’Austria; rimaneva la monarchia sabauda che, di conseguenza, considerò l’unità nazionale come un allargamento dei suoi confini a scapito degli altri, contando anche sul diffuso sentimento antipapalino. Il Regno di Sardegna, entità statale già consolidata e sviluppata economicamente, era anche da Marx considerato l’unico capace di realizzare l’unità italiana, pur con una casa reale niente affatto all’altezza del compito; contava però politici, Stato Maggiore ed esercito di buon livello.
La vocazione e tradizione militaresca di casa Savoia (dinastia che da fieri montanari signori delle proprie terre governò ininterrottamente per circa mille anni fino al farsesco impero dell’epoca fascista per degenerare poi ingloriosamente) è ben illustrata dalla seguente tabella dove si confrontano Francia, Prussia e Regno Sabaudo in termini di popolazione e dimensione degli eserciti.
La Francia nel 1738 su una popolazione di 22 milioni aveva 140.000 soldati, 1 ogni 157 civili; nel 1789, prima della Rivoluzione, la popolazione sale a 26 milioni, i soldati a 180.000, 1 ogni 145 civili. La Prussia nel 1740 su una popolazione di 2,2 milioni conta 80.000 soldati, 1 ogni 27 civili; nel 1789 su una popolazione di 5,7 milioni i soldati salgono a 194.000, 1 ogni 29 civili. Lo Stato sabaudo nel 1738, su una popolazione di 2,43 milioni stanzia 61.000 soldati, 1 ogni 40 civili e nel 1774 su 3 milioni di abitanti ha un esercito di 70.000 soldati, 1 ogni 43 civili.
Dato che il regno di Sardegna da solo non avrebbe mai potuto sconfiggere l’Impero asburgico, si pose il problema delle alleanze che l’abile Cavour individuò in Napoleone III e nelle sue mire di prestigio personale. Su queste basi si organizzò la seconda guerra di indipendenza, precipitosamente interrotta dal Bonaparte, nonostante un relativo successo militare, per la concreta minaccia dei prussiani sul Reno. Significativo anche l’atto formale con cui Vienna consegnava non al Piemonte bensì alla Francia la Lombardia, poi “girata” a Vittorio Emanuele. Scontati plebisciti dei territori che si erano ribellati, ingrandirono il Regno sabaudo che diviene d’Italia, pur limitando i suoi confini a nord delle Marche, escludendo parte dello Stato pontificio e tutto il Regno delle Due Sicilie.
2. Il contesto generale
I capitalisti del settentrione dietro il manto dei nobili sentimenti unitari e patriottici celavano un progetto di fatto antimeridionalista, di stampo coloniale, che considerava l’unificazione nazionale dal punto di vista del loro vantaggio economico.
Occorreva trovare altre alleanze, la francese non essendo più proponibile, per ricacciare gli Asburgo dal Veneto, trovare una soluzione per il Papa e cacciare i Borbone dal meridione.
La situazione nel Sud, in Sicilia in particolare, vedeva una massa contadina fortemente oppressa dalla proprietà fondiaria. Parte dei nobili e dei borghesi desiderava affrancarsi dal dominio borbonico, con l’indipendenza dell’isola o confluendo nel regno sabaudo.
La seguente citazione, tratta da un testo di L. Carpi, “L’Italia vivente”, Milano 1878, ne è un esempio: «Il Regno (delle due Sicilie, in parentesi quelli in Sicilia n.d.r.) contava 380 (208) principi, 441 (123) duchi, 610 (244) marchesi, 185 (104) conti. Il Carpi rivolse la domanda al prefetto di Napoli che ruolo svolgevano nella società questi aristocratici; rispose in modo inequivocabile “L’aristocrazia antica e moderna è impotente, niente istruita, generalmente povera e poco influente, nulla sotto il rapporto politico, onesta di carattere, incapace di qualunque iniziativa, niente laboriosa, rappresentata da largo numero di famiglie bisognose, da poche mezzariamente agiate, e da rare ricchezze”». La classe economicamente dominante sono ovviamente già la borghesia e i proprietari fondiari capitalisti.
Alla morte di Ferdinando II di Borbone nel 1859 gli successe il giovane e inesperto figlio Francesco II, per niente interessato alla gestione del mandato; seguì le indicazioni del padre rifiutando ogni alleanza con i Savoia e la concessione di statuti liberali, propostagli persino dal generale Filangeri, suo presidente dei ministri. Non avendo ricevuto alcuna educazione militare, preferì quella religiosa e finì col disinteressarsi dell’esercito proprio nel momento di necessità, aprendo così un quadro più favorevole alle sollevazioni.
Già nell’ottobre del 1859 a Palermo fu organizzata una prima sollevazione, ma per la defezione all’ultimo momento di molti partecipanti i pochi rimasti furono facilmente dispersi o catturati.
Nel 1860 ne fu organizzata un’altra nelle principali tre città siciliane, dove l’entusiasmo sopperiva la superficiale e approssimativa organizzazione militare. Anche questa usufruì del consistente sostegno economico dei circoli londinesi di esuli e rifugiati politici; la raccolta di fondi, in Italia e all’estero, raggiunse cifre enormi, segno del diffuso sentimento per l’unificazione. Vedremo come buona parte di esso fu utilizzato.
A Palermo base della rivolta era il Convento della Gancia dove erano state introdotte armi e un nucleo di patrioti. All’alba del 4 aprile la campana del convento avrebbe dato il segnale alle squadre dislocate nelle campagne e in altre chiese cittadine di prendere il controllo della città. Ma la polizia, venutane a conoscenza, durante la notte fece presidiare dall’esercito i punti strategici della città ed ebbe facile sopravvento sui rivoltosi quando si mossero, per poi assaltare a cannonate il convento della Gancia; 20 rivoltosi, tra cui un frate, morirono negli scontri; 13 arrestati con le armi in pugno furono condannati da un consiglio di guerra il 14 aprile e fucilati il giorno stesso. Insorsero altre città ma la generale disorganizzazione fece sì che le forze borboniche potessero riprendere il controllo delle grandi città; i gruppi armati si dispersero nelle campagne e sui monti, senza cibo ed armi, contando solo sul sostegno della popolazione.
Quattro giorni dopo le fucilazioni giunsero nel porto di Palermo due navi da guerra piemontesi con lo scopo ufficiale di proteggere i sudditi piemontesi presenti in città, in realtà per raccogliere informazioni sulle sollevazioni. Il “casus belli” avanzato dal Regno di Sardegna per attaccare il Borbone sarebbe stato il “ripristino dell’ordine” contro eventuali “sollevazioni repubblicane”, così come preteso dalla politica internazionale del governo di Cavour, che non emise mai una dichiarazione di guerra contro il Regno delle due Sicilie. Pratica questa che vediamo ancora oggi usata in buona parte del mondo: si suscitano o si fomentano disordini interni in un paese, con gravi sofferenze alla popolazione, perché poi qualcuno, ben preparato da prima, possa intervenire, chiamato o meno, per ripristinare ordine e legalità.
Nonostante l’invio di colonne mobili i borbonici non riuscirono però a riprendere il controllo dei centri minori perché questa volta l’insurrezione si era estesa nelle campagne e invece che una rivoluzione per l’unità nazionale, cosa che ai contadini interessava poco o nulla, divenne una generale sollevazione della miseria, una temibile jacquerie. Esperti sudamericani di guerriglia, giunti in Italia al seguito di Garibaldi, ne presero presto la direzione militare e riusciranno a tenere in scacco polizia ed esercito borbonico infliggendo loro piccole, limitate ma umilianti sconfitte. Il movimento contadino, sostenuto da una borghesia locale esclusa da ogni quota di potere, tra giugno e agosto assunse vaste proporzioni rivelando i suoi contenuti economici e sociali che nulla avevano a vedere con quelli patriottici ma erano contro il governo e i proprietari, quasi tutti borbonici. Contro la loro emancipazione, che essi vedevano nella confisca dei latifondi e nella distribuzione di quelle terre, con la formazione della piccola proprietà contadina, e in migliori condizioni per i salariati agricoli e i mezzadri, avevano buona parte dell’aristocrazia terriera che, pur di mantenere gli antichi privilegi, era disposta anche a sostenere la monarchia sabauda. Queste rivolte contadine culmineranno nei fatti di Bronte. Ne risultò alla fine un compromesso tra le classi sociali dominanti, a tutto svantaggio della proletaria e contadina.
Nessuno aveva previsto l’evoluzione di questa sollevazione: né Mazzini, né Garibaldi, abbagliati dai loro utopistici sogni, tanto meno i siciliani Rosolino Pilo e Francesco Crispi, che da anni in Italia e all’estero raccoglievano fondi e organizzavano moti senza una realistica visione della situazione. Mazzini, sopravvalutando il sentimento nazionale in Sicilia, incitava Garibaldi a formare una libera repubblica meridionale ed aveva fondato il Partito d’Azione con lo scopo di liberare tutta l’Italia e lanciato una sottoscrizione per l’acquisto di un milione di fucili. Cavour sperava in un loro generale fallimento per potersi liberare di entrambi e dei loro seguaci. Tutti però volevano approfittare dei moti sociali per trarre vantaggio alla propria fazione.
Nella disputa tra Cavour e Garibaldi, figure opposte per vocazione, formazione, capacità e storia, e in odio reciproco, si inserì Re Vittorio, riuscendo ad annettersi vasta parte d’Italia, senza coinvolgimento personale e dell’erario sabaudo, messo a dura prova da due guerre fallimentari.
Erano al nord già presenti piani ben delineati e in fase di attuazione quando giunsero le notizie delle sollevazioni in Sicilia; i primi incompresi focolai delle rivolte contadine spingevano a decidere e agire in fretta in una frenetica accelerazione del complesso quadro politico interno e internazionale.
Il nuovo governo Cavour, pur in maggioranza, rischiava però di saltare sul caso delle cessioni di Nizza e Savoia i cui falsi plebisciti, fissati per il 22 aprile, avrebbero dovuto poi essere ratificati a giugno, presente una forte opposizione popolare e parlamentare. Era arrivato a Torino anche Garibaldi per parlarne contro al Parlamento.
I preparativi della spedizione in Sicilia erano fatti quasi alla luce del sole; tutta Europa ne era a conoscenza; lo stesso Francesco II ordinò alla flotta borbonica di restare in crociera per impedirne lo sbarco.
Napoleone III, oltre a pretendere le due province, avrebbe protestato energicamente o addirittura cercato di impedire la spedizione, fuori dagli accordi di Plombieres in cui non si era discusso del Sud Italia e nemmeno della sorte dei Borboni a vantaggio dei Savoia. Il suo disegno di sistemazione italiana prevedeva per il regno di Napoli il figlio di Gioacchino Murat.
L’Inghilterra per suoi fini strategici e commerciali sosteneva l’unificazione italiana e dette man forte a Garibaldi per la realizzazione della sua spedizione anche con forniture di armi dai suoi depositi a Malta.
Convinto, senza troppa fatica, Garibaldi a lasciar stare la questione di Nizza ma di precipitarsi in appoggio ai siciliani, si procedette alla preparazione della “Spedizione dei Mille”, in una versione ufficiale e in una ufficiosa. Le armi raccolte a Milano con la sottoscrizione per il milione di fucili furono inizialmente bloccate dal Cavour, che poi rilasciò a Garibaldi; questo si sarebbe impadronito di 2 piroscafi inscenando un fasullo atto di pirateria per non coinvolgere il governo di Re Vittorio. In realtà il 4 maggio, il giorno prima della partenza della spedizione, nello studio del notaio Gioachino Vincenzo Boldi in Via Po a Torino si firmò il complesso rogito per “l’acquisto temporaneo” da parte del Regno di Sardegna presso l’armatore Rubattino dei due piroscafi Piemonte e Lombardo, nominandone beneficiario Garibaldi. Garanti del debito erano il Re sabaudo e il suo Primo Ministro.
Fu un ottimo affare per tutti, tanto sarà il denaro proveniente dal Sud: dalle sottoscrizioni volontarie e nelle banche del Regno delle due Sicilie si attinse a piene mani, con le buone e con le cattive, specialmente nell’ingente patrimonio che Francesco II fuggendo prima a Gaeta e poi a Roma aveva lasciato nei forzieri del Banco di Napoli. «Nel 1860 la riserva aurea degli Stati italiani, prima delle annessioni, ammontava in lire [una lira valeva circa 4,5 euro]: Regno delle due Sicilie: 445,2 milioni; Regno di Piemonte: 27; Toscana: 85,2; Romagna, Marche e Umbria: 55,3; Lombardia: 8,1; Parma e Piacenza: 1,2; Modena: 0,4; Venezia (1866): 12,7; Roma (1870): 35,3 Totale: 640,7 milioni di lire» (G.B.Guerri, “ Il sangue del Sud”).
Il finanziamento alla spedizione del Piemonte ammontò a 7.905.607 lire, computato, a impresa conclusa, nel bilancio del nuovo Stato unitario. Tutte le operazioni di armamento delle due navi e della loro partenza furono meticolosamente sorvegliate dalle autorità piemontesi, e in alcuni momenti presente a Genova lo stesso Cavour, alla faccia della versione del colpo di mano dei garibaldini, come pure il mai completamente chiarito infruttuoso rifornimento presso la fortezza di Talamone, e il più consistente di Orbetello, di armi, munizioni, carbone e materiale vario, perché i Mille erano partiti da Quarto forti del loro entusiasmo, ma privi di adeguato armamento.
Gli inglesi avevano assunto il controllo dell’arcipelago maltese e della sua grande fortezza nel 1800; la stabile e continuata presenza britannica in Sicilia, specialmente nel porto di Marsala, risale a qualche decennio prima. Quel porto, già da sempre importante, si trovava in un punto favorevole sulla rotta delle navi inglesi da Gibilterra a Malta per rifornirsi di acqua e viveri, lì particolarmente vari e abbondanti. Il vino liquoroso locale, prodotto col metodo usato in Portogallo e Spagna per il Porto e lo Sherry, aveva riscosso un grande successo commerciale in Inghilterra. Imprenditori inglesi fondarono diversi stabilimenti per la produzione in assoluto monopolio, infranto solo nel 1833 dall’imprenditore palermitano Florio. Altro importante traffico derivava dalla concessione in esclusiva dell’estrazione e del commercio dello zolfo, usato per la produzione di esplosivi, per il trattamento dei vigneti, e per i derivati tra cui soda e acido solforico. Nella cittadina si era costituita quindi una stabile e importante comunità inglese dedita agli affari. Per questo Londra consigliò lo sbarco in quel porto attestando i due piroscafi tra quelli inglesi, mentre uno sbarco a Palermo sarebbe stato più arduo e incerto.
3. Da Calatafimi a Palermo
Non è da riscrivere la storia della spedizione dei Mille, tanto, troppo, è stato scritto al punto che è difficile capire l’esatta portata degli eventi; nel contesto generale del nostro lavoro di Partito commentiamo i fatti più significativi dal punto di vista militare, che la retorica risorgimentale ha distorto e falsato.
Le forze in campo erano molto sproporzionate, pareva un duplicato, in scala maggiore, della sfortunata spedizione di Pisacane a Sapri tre anni prima, ma i tempi erano cambiati. Contro i Mille, o poco più, di cui la metà intellettuali o professionisti lombardi ma quasi tutti veterani dei Cacciatori delle Alpi, era un consistente esercito che sulla carta disponeva di 93.000 unità più 4 reggimenti ausiliari di mercenari, il più numeroso d’Italia, con la flotta più potente di stanza nel Mediterraneo: 11 moderne fregate, 5 corvette e 6 brigantini a vapore oltre a vari tipi di navi a vela. Era però un esercito che non aveva affrontato alcuna seria guerra; Ferdinando II affermava che il suo regno era protetto “dall’acqua salata e dall’acqua benedetta”, cioè dal mare a sud e dalla protezione francese allo Stato della Chiesa a nord. Quindi l’esercito era stato modellato per difendersi dai nemici interni, il diffuso brigantaggio e le rivolte popolari, puntando prevalentemente sui corpi di fanteria leggera di stampo napoleonico, viste le poche strade carrozzabili presenti all’epoca e il terreno collinare e montuoso. Difettava inoltre di collegamento nella catena di comando generale. Il livello di armamento era similare per entrambi i fronti: fucili di medio livello, pochissima artiglieria. La forma principale di combattimento prescelta da Garibaldi, per i motivi di scarso equipaggiamento, fu l’assalto alla baionetta, come ben espresso nell’ordine del giorno n° 5 del 10 maggio: “Bisogna essere ben parchi di tiri e ricorrere, se si debba pugnare, allo spediente più spiccio della baionetta”.
Partirono in tutta fretta nella notte tra il 5 e il 6 maggio senza adeguata preparazione, senza adeguato materiale ma con molto entusiasmo. Durante i rifornimenti a Talamone, Orbetello e Porto Santo Stefano Garibaldi fece sbarcare una colonna di 64 uomini, che si accrebbe di altri 200 volontari, con lo scopo diversivo, attraversando i territori pontifici, di far credere di voler attaccare l’esercito borbonico da nord e far spostare truppe borboniche dalla Sicilia. Questa spedizione dopo solo pochi giorni fu facilmente dispersa anche per la forte ostilità dei contadini.
I due piroscafi, avvertiti che la flotta borbonica era in mare per intercettarli, per evitarla approntarono una più lunga rotta fin quasi sotto le coste tunisine, quando Garibaldi decise di sbarcare a Sciacca. Ma, avvertito in mare da alcuni pescherecci siciliani e da una nave da guerra inglese che in quel porto erano presenti diverse navi borboniche, fu consigliato di dirigersi su Marsala, approfittando della presenza di due navi militari inglesi e della scarsa guarnigione a terra. Al momento dello sbarco da terra non fu sparato alcun colpo di cannone per tema di colpire le navi inglesi: le sopraggiunte navi borboniche, che erano infine riuscite ad intercettare quelle dei Mille, furono avvertite da quelle inglesi in porto che v’erano due loro ufficiali che, se colpiti, avrebbero considerato il gesto atto di guerra, come pure eventuali danni ai magazzini inglesi del porto. Il vice comandante della flotta mediterranea della Marina inglese, Rodney Mundy, aveva ricevuto l’ordine da Londra di incrociare le acque del Tirreno e del Canale di Sicilia con il grosso delle navi a disposizione e di effettuare frequenti scali nei porti delle Due Sicilie, a scopo intimidatorio e di raccolta di informazioni per ostacolare eventuali reazioni borboniche allo sbarco.
L’11 maggio lo sbarco, benché segnalato dai servizi di informazioni, fu facilitato anche perché il giorno prima tutte le truppe di terra di Marsala e dintorni erano state fatte convergere su Palermo, per contrastare una minacciata insurrezione nella città.
Nei 4 giorni che precedettero il primo scontro campale con i borbonici già emersero tutte le difficoltà: Garibaldi si rese conto che la tanto celebrata rivolta non era così generalizzata; le milizie di Rosolino Pilo erano già state disperse dai borbonici. Dei primi 500 volontari al primo scontro nella battaglia di Calatafimi ne rimasero in linea solo 140 mentre la più parte si sedette sulle colline ad aspettare l’esito della battaglia: erano milizie personali dei signori locali, male armati o contadini con solo bastoni o falcetti senza alcuna esperienza. I 14 ribelli liberati dal carcere di Marsala fuggirono tutti la notte stessa con i fucili appena ricevuti. Ciò demoralizzò non poco i garibaldini che si attendevano maggior sostegno e entusiasmo; anche per questi motivi Garibaldi non distribuì ai contadini le poche armi che aveva.
I siciliani poi si aspettavano un vero esercito e non mille volontari anche se con Garibaldi al comando.
I comandi militari borbonici invece credevano di incontrare la solita banda di delinquenti o ribelli improvvisati, cui erano avvezzi, che si sarebbe dispersa alle prime scariche di fucileria, nonostante il fortunato sbarco a Marsala e l’entusiasmo del passaparola popolare sui volontari che si sarebbero uniti ai Mille. Adottarono quindi una strategia di accerchiamento: una spedizione via mare da Gaeta avrebbe dovuto sbarcare anch’essa a Marsala e prendere alle spalle i Mille mentre il contingente palermitano li avrebbe bloccati nella loro marcia verso la città. Invece, per contrasti tra i comandi le navi partirono con forte ritardo e sbarcarono a Palermo vanificando completamente il piano. L’inesperienza al comando di battaglie campali e non di mera repressione emerse alla prima occasione, nella battaglia di Calatafimi.
Già il 13 le guide garibaldine avevano individuato le posizioni dei borbonici. Garibaldi aveva due opzioni: spingersi all’interno dell’isola e attivare forti azioni di guerriglia allo scopo di disarticolare le formazioni borboniche, oppure puntare direttamente su Palermo per la strada militare carrozzabile Trapani-Calatafimi-Palermo e ingaggiare combattimento con il primo presidio posto a sua difesa a Calatafimi, liberando la via per la capitale. Pur in forte inferiorità numerica scelse la seconda, più ardita: i rinforzi locali sarebbero arrivati coi primi successi. Mosse da Salemi verso il crocevia della strada militare presso Calatafimi, nascose le sue forze, 1.500 uomini, nella vallata sottostante, dando l’ordine di aprire il fuoco solo al suo ordine e attese le mosse dei borbonici.
Landi, il settantenne comandante borbonico, uomo indeciso e insicuro, aveva tre possibilità: ritirarsi su Palermo per l’incerto controllo delle vie per i rifornimenti e la reale possibilità di estese rivolte popolari; attaccare frontalmente per disperdere i 4.000 uomini del nemico; oppure attestarsi saldamente su Calatafimi e offrire battaglia da una posizione consolidata. Scelse invece di disperdere le sue truppe in varie colonne per mostrare di controllare tutto il territorio e demoralizzare gli invasori.
La colonna del maggiore Sforza individuò degli spostamenti di armati sul monte Pietralunga, ma, poiché la maggior parte dei garibaldini vestiva abiti civili parvero solo una banda di siciliani; le poche camicie rosse furono scambiate con i camisacci dei galeotti evasi o liberati. Il grosso dei garibaldini era invece ben mimetizzato nella vallata. Sforza, nonostante l’ordine ricevuto di “circolare per la campagna”, decise di attaccare quelli che credeva dei rivoltosi isolati scendendo dalla collina con due file di soldati mentre una buona parte fu tenuta di riserva sulla sommità. Furono bloccati da una prima ordinata scarica di fucili; ripreso l’attacco furono per alcune volte respinti alla baionetta; compresero così che avevano di fronte dei soldati esperti.
Dopo le successive cariche borboniche, quando la ritirata, per l’assenza di retrovie fortificate, sarebbe stata una fuga disordinata, Garibaldi dette l’ordine di un altro contrattacco alla baionetta, che disorientò e respinse per la sua incisività i borbonici, senza però essere determinante vista la netta inferiorità numerica. A questo punto, inspiegabilmente, Landi impartì l’ordine della ritirata sotto lo sguardo incredulo dei garibaldini che invece si aspettavano un grosso contrattacco. Landi, spiegò poi ai comandi superiori di Napoli, temeva di essere tagliato fuori dalla linea dei rifornimenti di Palermo da cui dipendeva totalmente e di essere intrappolato dalle sollevazioni popolari che preavvisava.
La strada per Palermo era aperta. Contro entrambe le parti, a Partitico, per le razzie e i saccheggi allo scopo di rifornirsi di viveri, vi fu una sollevazione della popolazione con significativi scontri armati ed eccidi di prigionieri; era il tanto atteso segnale che i siciliani insorgevano.
Dal punto di vista militare questa battaglia, durata 4 ore con una trentina di morti e un centinaio di feriti su entrambi i fronti, fu poco più che una scaramuccia, ma ebbe grande importanza strategica: quando la colonna di Landi giunse a Palermo stremata dalla fatica e dalla fame il mito di Garibaldi, eroe popolare e condottiero invincibile, spronò i siciliani a unirsi a lui contro i borbonici.
Si giunse presso Palermo con piccoli scontri. Il grande problema era la forte disparità numerica, nonostante l’unirsi di altri volontari: oltre alla flotta napoletana la città era presidiata da oltre 21.000 soldati; solo con una forte sollevazione popolare si poteva pensare alla sua conquista. Il piano prevedeva di ridurre le forze borboniche nella città per poi condurre un attacco simultaneo e di sorpresa da più direzioni.
Così Engels descrive la geniale manovra: «Con un’abile combinazione di attacchi e finte ritirate indusse il generale napoletano a far uscire dalla città un numero sempre maggiore di truppe, finché il 24, fuori dalla città, in direzione di Parco, comparvero 10.000 napoletani. Era quel che voleva Garibaldi. Li impegnò immediatamente con parte delle sue forze, ripiegando quindi lentamente di fronte ad essi, in modo da allontanarli sempre più, passo a passo, dalla città; quando li ebbe attirati a Piana, al di là della principale catena di alture che attraversa la Sicilia e che qui divide la Conca d’Oro (la valle di Palermo) dalla valle di Corleone, di colpo gettò il grosso delle sue truppe sull’altro versante della catena, nella valle di Misilmeri, che si apre sul mare vicino a Palermo (...) Non siamo informati di quel che fece dei 10.000 uomini disseminati lungo l’unica strada in cattivo stato che attraversa la montagna, ma possiamo esser certi che li tenne occupati a dovere con una serie di nuove, apparenti vittorie, per impedire loro di tornare troppo presto a Palermo» (“New York Daily Tribune”, 22 giugno 1860).
Così, all’alba del 27 maggio, due colonne garibaldine penetrarono in Palermo, avuta ragione della resistenza borbonica sulle strade che portano ai ponti dell’Ammiragliato e a quello della Guadagna, mentre i gruppi dei volontari siciliani entravano dagli altri accessi con alterna fortuna.
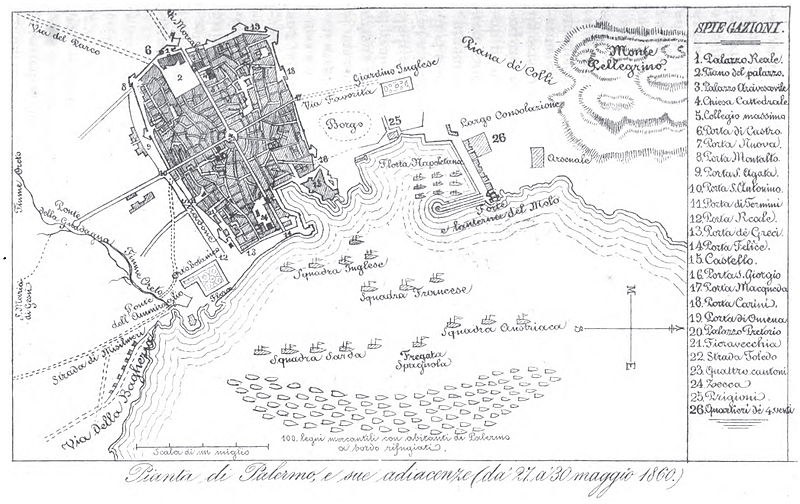 La battaglia per la presa di Palermo durò ben
4 giorni, dal 27 al 30
maggio, con decine di episodi valorosi sotto la feroce difesa borbonica
che cannoneggiava da terra e da mare i quartieri che si ribellavano o
man mano che i garibaldini ne prendevano possesso e lentamente
conquistavano la città. I difensori che, nonostante la forte
superiorità numerica, non disponevano di un piano militare preciso ma
si davano solo ad azioni disordinate di saccheggio e rappresaglia,
furono infine costretti a ritirarsi all’interno del Palazzo Reale e del
Castello a Mare, assediati con penuria di armi e munizioni. Dopo una
prima tregua il giorno 30 si giunse alla convenzione del 6 giugno che
permetteva ai borbonici di lasciare la città, via mare, con l’onore
delle armi!
La battaglia per la presa di Palermo durò ben
4 giorni, dal 27 al 30
maggio, con decine di episodi valorosi sotto la feroce difesa borbonica
che cannoneggiava da terra e da mare i quartieri che si ribellavano o
man mano che i garibaldini ne prendevano possesso e lentamente
conquistavano la città. I difensori che, nonostante la forte
superiorità numerica, non disponevano di un piano militare preciso ma
si davano solo ad azioni disordinate di saccheggio e rappresaglia,
furono infine costretti a ritirarsi all’interno del Palazzo Reale e del
Castello a Mare, assediati con penuria di armi e munizioni. Dopo una
prima tregua il giorno 30 si giunse alla convenzione del 6 giugno che
permetteva ai borbonici di lasciare la città, via mare, con l’onore
delle armi!
Nel porto, oltre alle napoletane, erano navi militari inglesi, francesi, piemontesi, austriache e una spagnola. L’interesse per la situazione vi aveva richiamato anche il corrispondente di guerra del Times; giunse perfino Alessandro Dumas con una nave con armi e munizioni per i garibaldini.
Di sicuro, oltre che per le capacità militari di Garibaldi, l’avanzata fu il frutto della dissoluzione dell’esercito borbonico.
Liberata tutta la Sicilia orientale, altre città insorgevano. Il conflitto si spostava ad occidente perché, ricalcando il piano del 1848, quando Ferdinando II bombardando Messina iniziò a riprendersi la Sicilia, le truppe reali furono concentrate intorno allo stretto: di 22.000 uomini ancora nell’isola ben 18.000 erano a Messina
Nel frattempo la maggior parte dei volontari siciliani era ritornata alle proprie occupazioni, altri arrivavano dal resto d’Italia. Da Malta gli inglesi fecero arrivare un migliaio di moderni fucili e munizioni. Da Genova tre navi al comando del generale Giacomo Medici, con 3.500 volontari, 8.000 fucili moderni a canna rigata e 400.000 munizioni, trasformarono la spedizione dei Mille in una vera campagna di una guerra mai dichiarata. Altre navi con volontari e armi giunsero in quei primi giorni in aiuto a Garibaldi. Il neonato “Esercito Meridionale” sorto dall’amalgama di tutte queste forze eterogenee si stima raggiunse un massimo di ben 50.000 effettivi. Molti di questi, truppa ma soprattutto ufficiali, provenivano dall’esercito borbonico, convinti con promesse di denaro e carriera nel nuovo esercito nazionale. Il generale Landi godette poi di una cospicua pensione del nuovo esercito sabaudo mentre 4 suoi figli, già alti ufficiali borbonici, vi si arruolarono.
Garibaldi il 14 maggio, dopo la vittoria di Calatafimi, assunse la carica di “dittatore della Sicilia”; tra i vari provvedimenti che qui ci interessano vi furono: il 14 maggio stesso aveva ordinato lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli Civici e la formazione della Guardia Nazionale; il 2 giugno la promessa della divisione delle terre e di aiuti contro la diffusa miseria; con un decreto del 17 giugno escludeva dai Consigli Municipali i favoreggiatori diretti e indiretti della restaurazione borbonica. Se da un lato gli premeva l’aspetto militare e di unificazione nazionale sotto casa Savoia, dal lato politico e sociale si esprimeva con istintività e approssimazione. Certo non era l’uomo per affrontare e tanto meno risolvere la questione agraria in Sicilia!
4. La battaglia di Milazzo
Dopo l’arretramento le forze borboniche contavano oltre 22.000 effettivi intorno a Messina più la modesta guarnigione nella fortezza di Milazzo; Garibaldi decise di attaccarla, disponendo per quell’occasione di oltre 6.000 uomini, ora ben armati dei nuovi fucili a canna rigata, anche se completamente privi di cavalleria e con poca artiglieria. In aiuto della cittadella fu inviato da Messina un contingente di 3.400 uomini con cavalleria e artiglieria guidati dall’esperto colonnello Ferdinando Beneventano del Bosco. La battaglia combattuta tra il 17 e il 24 luglio 1860 fu ben diversa dalle precedenti perché per la prima volta i garibaldini, ora in forte superiorità numerica, si trovarono di fronte ad una formazione borbonica ben organizzata e diretta da un comandante intenzionato a combattere una vera battaglia.
Dopo una serie di scaramucce volte allo scopo di saggiare la reattività avversaria, il piano di battaglia di Garibaldi prevedeva un forte attacco frontale con una massiccia colonna centrale e due attacchi laterali simultanei allo scopo di disarticolare i 2.600 borbonici attestati su due linee nella piana sotto la fortezza. L’attacco garibaldino fu così scoordinato che si rivelò un disastro e a malapena riuscirono a contenere il contrattacco borbonico subendo forti perdite. Contando sulla superiorità numerica tentarono altri infruttuosi attacchi; Garibaldi, disarcionato, rischiò addirittura di essere colpito o catturato. Ma, da Messina, il generale Clary non inviò altri aiuti e addirittura il colonnello Pironti, comandante la fortezza, si rifiutò di far uscire a rinforzo i 1.400 uomini nella cittadella, asserendo di non riconoscere un ordine da un suo pari grado ma di minor anzianità di servizio!
Del Bosco decise quindi di ritirarsi dalla pianura verso l’abitato di Milazzo, che offriva maggiori opportunità di difesa. In quel mentre arrivò nella baia la pirocorvetta Tukory, che alcuni giorni prima era stata consegnata alla marina sarda dal suo corrotto comandante Anguissola, convinto per denaro al tradimento dall’ammiraglio Persano. Era un’unità moderna, la “Veloce”, poi rinominata Tukory, armata con 10 potenti cannoni che iniziarono a bombardare l’ala sinistra borbonica, impedendo loro ulteriori pericolosi contrattacchi e costringendo infine tutto lo schieramento borbonico, non sconfitto, a riparare nella cittadella. Forti le perdite garibaldine: 750 uomini tra morti, feriti e dispersi contro i 160 dei borbonici.
Alcuni giorni dopo alle truppe borboniche fu concesso di imbarcandosi per Napoli; nell’isola rimasero alcune isolate fortezze che si arresero nell’arco di qualche mese.
Di Garibaldi così Engels scrive: «Dobbiamo affermare che le manovre con cui Garibaldi preparò l’attacco di Palermo lo qualificano immediatamente come un generale di grande statura. Fino ad oggi lo conoscevamo soltanto in veste di capo di guerriglieri assai abile e fortunato; persino l’assedio di Roma, con il suo modo di difendere la città mediante sortite continue, difficilmente poteva offrirgli l’occasione di sollevarsi al di sopra di quel livello. Ma noi qui lo vediamo agire su un buon terreno strategico; ed egli supera la prova di maestro consumato nella sua arte. Il modo con cui induce il comandante napoletano a commettere lo sproposito di inviare la metà delle sue truppe fuor di portata di mano, la sua fulminea marcia laterale per riapparire a Palermo là dove era meno atteso, ed il suo energico attacco nel momento in cui la guarnigione era indebolita, sono operazioni che portano l’impronta del genio militare più di qualsiasi altro avvenimento della guerra italiana del 1859. L’insurrezione siciliana ha trovato un capo militare di prim’ordine; speriamo che l’uomo politico Garibaldi, il quale presto dovrà comparire sulla scena, saprà conservare senza macchia la gloria del generale» (New York Daily Tribune, 22 giugno 1860)
5. Bronte primo assaggio di unità nazionale su proletari e contadini
La speranza del nostro Federico andò smentita. Garibaldi sapeva che per il successo della spedizione aveva bisogno del sostegno popolare siciliano e ancor più delle grandi masse di braccianti e contadini poveri; eppure non fece nulla per loro. Anzi, come risulta evidente nell’episodio di Bronte, per tranquillizzare i governi di Londra e quello sabaudo e i potenti capitalisti e finanzieri inglesi che operavano in Sicilia, volle dimostrare il completo controllo sulle classi inferiori e che la proprietà fondiaria non sarebbe stata intaccata.
A Bronte, alle prime elezioni dall’arrivo di Garibaldi furono sconfitte le indebite speranze del partito di quanti avevano creduto alle promesse di divisione delle terre e in particolare del vasto latifondo della Ducea di Nelson. Questa enorme proprietà, in aggiunta del titolo di Duca di Bronte, era stata concessa da Ferdinando IV di Borbone ad Orazio Nelson in ricompensa dell’aiuto che la flotta inglese gli aveva dato per soffocare i moti repubblicani del 1799: fu sul pennone della sua nave che fu impiccato il generale Caracciolo, lo stratega dei moti. Su quella sconfinata proprietà lavorava gran numero di braccianti. Questi, esasperati dalla miseria, dalle troppe promesse deluse, dal 2 al 4 agosto 1860 si dettero ad azioni violente che sfociarono in incendi, saccheggi e nell’uccisione di 16 fra proprietari terrieri, amministratori della Ducea, guardie ecc.
Così riassume lo storico siciliano Benedetto Radice: «Dietro questi eccidi vi erano una fame secolare di terre, odi mai sopiti, soprusi mai scordati, un’estrema miseria, ma anche desiderio di libertà e ansie generose risorte di fronte a quella che appariva la splendida e rapida azione di Garibaldi con le sue promesse di dare soddisfazione immediata alle rivendicazioni contadine. Si erano improvvisamente riaccese le speranze dei contadini, quasi tutti poveri braccianti, di riappropriarsi dei demani e anche dell’immenso patrimonio terriero per due volte palesemente usurpato in quattro ininterrotti secoli dall’Ospedale di Palermo (1494) e dall’ammiraglio Nelson (1799). E poteva finalmente avere uno sbocco la gigantesca causa legale intrapresa da ben tre secoli dalla comunità brontese contro gli usurpatori (durava dal 1554 ed ancora non era stata conclusa). L’ira a lungo repressa dei contadini esplose in forme di atroci violenze anche per l’infiltrazione dei molti elementi che erano scappati dalle carceri di tutta la Sicilia e per l’arrivo contemporaneo di altri individui poco raccomandabili piovuti dai paesi circostanti a fomentare vieppiù gli animi».
Crispi e Garibaldi decisero allora per l’invio di un centinaio di soldati della neonata Guardia Nazionale; questi giunti da Catania il 4 agosto non ottennero alcun risultato e preferirono ritirarsi in buon ordine. Il giorno successivo 300 soldati con artiglieria giunsero a Bronte mentre la rivolta stava rientrando da sé.
Bixio così esprimeva i suoi sentimenti antimeridionalisti in una sua lettera alla moglie: «Che paesi! Si potrebbero chiamare dei veri porcili! Questo insomma è un paese che bisognerebbe distruggere o almeno spopolare e mandarli in Africa a farli civili». Giunse a Bronte per presiedere il tribunale speciale quando la maggior parte dei responsabili degli eccidi erano già fuggiti. In un frettoloso processo durato meno di quattro ore furono giudicati oltre 150 arrestati e si condannò a morte il neo sindaco, eletto per acclamazione dai rivoltosi ma completamente estraneo agli eccidi, ed altri quattro tra cui un povero mentecatto. Furono fucilati il mattino seguente e i cadaveri esposti a monito insepolti. Istruttivo che fossero proprio i garibaldini a reprimere nel sangue una rivolta plebea che eppure si ispirava ai principi di libertà e di giustizia vantati dalla borghese-rivoluzionaria spedizione dei Mille.
La questione della proprietà fondiaria era però troppo importante per le classi dominanti, locali e nazionali, e non ammetteva deroghe: dopo il primo sommario processo ne seguì un altro contro 745 imputati. I proprietari terrieri vollero si celebrasse a Bronte un consiglio di guerra, che si ebbe poi a Catania tra il 1862 e il 1863 e che si concluse con 37 condanne di cui 25 ergastoli.
6. La battaglia sul Volturno
Con il ritiro dalla Sicilia il processo di decomposizione dell’esercito borbonico accelerava, interi reparti si disperdevano o passavano ai garibaldini e corpi di oltre diecimila uomini si arrendevano senza combattere. Garibaldi occupò facilmente la Calabria e la Basilicata dirigendo direttamente su Napoli senza incontrare resistenza mentre Francesco II le aveva abbandonate per concentrare il rimanente suo esercito tra la fortezza di Gaeta e quella di Capua, presso il fiume Volturno.
Qui avvenne l’ultima battaglia che concluse militarmente la spedizione, un insieme di fatti d’arme in più giorni e in diverse località tra 50.000 borbonici e 24.000 garibaldini. Ai primi, bene armati ed equipaggiati, con buoni ufficiali e soldati, venne meno l’abilità dei capi, a differenza dei garibaldini, mal preparati ma comandati da militari capaci e di grande ascendente, a cominciare da Garibaldi, che mostrò notevole intuito tattico. I borbonici persero giorni preziosi prima di attaccare, a tutto vantaggio dei volontari che ebbero tempo di rafforzarsi sul terreno. Il fronte garibaldino era esteso su una linea lunga ben 20 chilometri allo scopo di controllare tutte le vie di comunicazione tra Napoli e Caserta.
Le prime scaramucce iniziarono il 26 settembre ma lo scontro decisivo, tra alterne vicende, terminò il 1° ottobre con una sofferta vittoria garibaldina quando sopraggiunsero le avanguardie del corpo di spedizione sardo che, passando per le Marche e l’Umbria papalina, aveva sconfitto il 18 settembre nella battaglia di Castelfidardo l’esercito pontificio. Le perdite furono di 1.700 tra morti e feriti e 400 prigionieri circa tra i garibaldini contro i 1.100 borbonici tra morti e feriti ma ben 3.100 prigionieri.
7. La scesa dei piemontesi
Garibaldi aveva conquistato il Sud d’Italia ma per unirlo al Nord rimaneva lo Stato pontificio che tagliava in due la Penisola e al quale era necessario sottrarre vasti territori, visto che era al momento improponibile la sua completa soppressione.
Il governo piemontese decise quindi di intervenire direttamente con un consistente corpo di spedizione allo scopo di annettersi le Marche e l’Umbria, creando un ampio corridoio di collegamento tra nord e sud. Al Papa sarebbe rimasto il Lazio, come già prospettato nei colloqui di Plombieres tra Cavour e Napoleone. La spedizione militare aveva anche lo scopo di fermare Garibaldi prima che, spinto dall’onda delle sue vittorie, puntasse direttamente su Roma, il che avrebbe creato grossi problemi con le potenze europee. Era anche necessario dare un sostegno a Garibaldi, che ora si trovava di fronte ai reparti più fedeli al Borbone.
 L’esercito sardo concentrò in
Romagna 39.000 uomini 2.500 cavalli e
77 pezzi di artiglieria disponendo l’invasione sue due direttrici: una
costiera puntando su Ancona, nella cui roccaforte si trovavano 10.000
soldati, prevalentemente austriaci, richiesti dal Papa già dal 1849;
una squadra navale sarda avrebbe attaccato dal mare; lo scopo era di
attirarvi consistenti forze pontificie. Una seconda, lungo la valle del
Tevere, avrebbe dovuto chiudere l’esercito mobile papalino tra due
fronti obbligandolo a dar battaglia da una posizione sfavorevole.
L’esercito sardo concentrò in
Romagna 39.000 uomini 2.500 cavalli e
77 pezzi di artiglieria disponendo l’invasione sue due direttrici: una
costiera puntando su Ancona, nella cui roccaforte si trovavano 10.000
soldati, prevalentemente austriaci, richiesti dal Papa già dal 1849;
una squadra navale sarda avrebbe attaccato dal mare; lo scopo era di
attirarvi consistenti forze pontificie. Una seconda, lungo la valle del
Tevere, avrebbe dovuto chiudere l’esercito mobile papalino tra due
fronti obbligandolo a dar battaglia da una posizione sfavorevole.
L’esercito pontificio era costituito da sempre da corpi stranieri, qui di ben sette nazionalità; questa, che era stata una sua forza, ora si trasformava in debolezza, incapace di evitare la fine, già matura, del potere temporale della Chiesa. Le proteste del Papa a Napoleone ottennero la promessa di inviare altre truppe francesi a Roma e il ritiro dell’ambasciatore a Torino, ma contemporaneamente Napoleone avvisava Cavour di fare in fretta a chiudere la questione.
Il generale De Lamorcière a difesa dello Stato pontificio aveva diviso le sue forze su quattro presidi: Foligno, Terni, Macerata e Spoleto.
Nemmeno qui vi fu alcuna dichiarazione di guerra: il 10 settembre il generale Fanti inviò una lettera a Lamorcière avvisandolo che se nell’Umbria e nelle Marche si fosse adoperata la forza per reprimere ”manifestazioni nel senso nazionale”, per ordine del Re di Piemonte avrebbe invaso quei territori. La mattina seguente, senza attendere alcuna risposta, le truppe piemontesi varcavano il confine.
De Lamorcière decise di convergere a tappe forzate su Ancona per insieme agli uomini nella cittadella aspettare dalle potenze cattoliche i soccorsi al Papa. L’esercito sardo intese prevenirli riuscendo nella fase finale a percorrere 38 miglia in 28 ore; quello papalino sostava solo due ore al giorno! Le avanguardie piemontesi avevano occupato le alture delle città vicine.
De Lamorcière pur in inferiorità numerica decise di attaccare il 18 settembre. Nella breve battaglia il primo assalto a sorpresa nella piana fu efficace ma subito contrastato dai piemontesi, quelli successivi avvennero fattoria per fattoria ma ben presto i papalini dovettero arrendersi. Solo una minima parte delle truppe con De Lamorcière riuscì ad arrivare ad Ancona attraverso sentieri impervi sul monte Conero. Il giorno dopo i papalini rimasti, circondati su ogni lato, si arresero in 4.000 armi e bagagli.
L’esercito mobile del Papa era distrutto. Ancona cadde dopo alcuni giorni di assedio da terra e da mare: la via per il Sud e per bloccare i volontari di Garibaldi era aperta.
Dopo il Volturno e l’arrivo dell’esercito piemontese col suo Re seguirono il 13 ottobre i soliti scontati plebisciti per l’annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna; e il 4 e il 5 novembre analoghi per l’annessione delle Marche e dell’Umbria. Il 26 ottobre ci fu l’incontro tra Garibaldi e Re Vittorio. Per completare l’unificazione italiana mancavano ancora il Triveneto e il Lazio pontificio.
Agli ufficiali dei disciolti esercito e marina delle Due Sicilie fu consentito entrare nell’esercito e nella marina del Regno d’Italia mantenendo il grado. Chi rifiutò di prestare giuramento al nuovo sovrano e rimanere fedele a Francesco II fu deportato nei campi di prigionia di Alessandria, San Maurizio Canavese e nel più noto Forte di Fenestrelle, ove i più trovarono la morte per fame, stenti e malattie. Altri, datisi alla macchia, continuarono a combattere per l’indipendenza delle Due Sicilie unendosi all’”orda dei briganti” e andando a incrementare il fenomeno del brigantaggio, già esistente sia nel regno dei Borbone sia in quello pontificio. A debellarlo furono poi mandati i bersaglieri del generale Cialdini, che usò la mano pesante e ogni mezzo indiscriminato.
Dopo la sconfitta sul Volturno, Francesco II, la regina e i resti dell’esercito si concentrarono a Gaeta, ultima difesa del Regno delle Due Sicilie, assieme alla cittadella di Messina e di Civitella del Tronto. L’assedio di Gaeta, iniziato dai garibaldini il 13 novembre 1860, fu concluso dall’esercito sabaudo il 13 febbraio. Con la resa di Francesco II, gli ultimi Borbone di Napoli andarono in esilio a Roma; Pio IX poteva così restituire la protezione ricevuta da Ferdinando II alcuni anni prima proprio a Gaeta.
8. Conclusioni
1) Con questa guerra, mai dichiarata, dello Stato piemontese a quello borbonico e al Papa, di Garibaldi da sud verso nord e del corpo di spedizione piemontese da nord verso sud, si ha la più vasta annessione territoriale di tutte le guerre di indipendenza a favore del Regno dei Savoia. Vittorio Emanuele II infatti, pur denominandosi Re d’Italia, non cambiò né il nome né il numerale.
2) Francia e Inghilterra non ostacolarono questa congiunta manovra e la sostennero anche a livello diplomatico contro Russia e Prussia perché un’Italia unita e più forte era un mezzo per indebolire la potenza dell’impero d’Austria, ora rimasto isolato.
Da un punto di vista strettamente militare sulla tanto celebrata spedizione dei Mille possiamo tirare queste conclusioni.
3) Si scontravano due formazioni del tutto diverse, per preparazione, armamento, tradizione militare e spirito combattivo. I veterani garibaldini avevano pratica di combattimento asimmetrico e incondizionata fiducia in Garibaldi e nei suoi ufficiali. Il grande esercito borbonico, molto meglio armato e ben disposto sul territorio, era stato ordinato nel tempo in funzione di controllo poliziesco e di lotta contro le bande dei briganti ma di scarsa esperienza in combattimenti contro formazioni militari regolari.
4) L’avanzata dei Mille fu favorita dalla rapida dissoluzione dell’esercito di Francesco II.
5) Volontari siciliani e di altre regioni italiane come fuoriusciti dell’esercito borbonico confluirono in gran numero nel neonato Esercito Meridionale.
6) Determinanti furono l’aiuto della flotta inglese, come pure la corruzione con denaro e promesse di carriera e pensioni agli ufficiali borbonici.
7) Non vi furono particolari schemi strategici o innovazioni tattiche adottate da nessuno dei due schieramenti. L’intuito di Garibaldi fece la differenza in varie occasioni. L’uso dei nuovi fucili e cannoni a canna rigata e di naviglio moderno è ormai generalizzato.
IL X CONGRESSO DELLO SFI
Bologna, luglio 1921
I documenti che abbiamo cominciato a ripubblicare nel numero scorso di questa rivista dimostrano in maniera inequivocabile la tattica del partito comunista (e solo del partito comunista) in ambito sindacale, ossia il rifiuto e la denuncia della falsa unità del proletariato attraverso blocchi di forze sociali e politiche eterogenee, per la realizzazione della vera e reale unità di classe e delle sue organizzazioni di difesa economica, basata sull’azione di classe ispirata dal programma e diretta dal partito.
Qualsiasi altro tipo di unità sindacale rappresenta solo un imbroglio del quale si sono sempre serviti i politicanti opportunisti sabotatori dell’azione di classe.
Il partito comunista pone l’unità sindacale come un indispensabile obiettivo da raggiungere attraverso chiare proposte ed azioni di lotta, aperta e diretta contro il comune nemico di classe, indirizzate a tutte le categorie e reparti operai.
Il partito comunista, mentre inquadra nella sua organizzazione solo una avanguardia cosciente del proletariato, basa la sua condotta pratica sulla necessità dell’azione unitaria e quindi della unitaria organizzazione di tutti gli sfruttati. Proclama quindi la necessità di unificare le lotte che il proletariato dei vari settori è costretto a condurre, in modo da dare ad esse obiettivi e metodi di azione comuni e quindi dichiara la necessità di unificare anche le loro organizzazioni al di sopra delle località, categorie, appartenenza a partiti politici, etc.
L’organizzazione sindacale, pure essendo il primo stadio della coscienza e della pratica associativa del proletariato, per il semplice fatto di raccogliere gli operai al fine di resistere alla loro comune condizione di sfruttamento, rappresenta l’inquadramento naturale anche per la lotta contro il regime presente, quando diretto dal partito comunista.
Come unica è la condizione della classe e come unici sono i suoi fini immediati e storici, così i migliori coefficienti di efficacia sono da attendersi da una organizzazione sindacale tendenzialmente unica e con una unica disciplina. Di conseguenza i militanti comunisti non escono dai sindacati diretti da capi e partiti opportunisti ma agiscono al loro interno per guadagnarli alla politica rivoluzionaria.
Troviamo un chiaro esempio di questa tattica nell’azione svolta dal partito comunista d’Italia al X Congresso del Sindacato Ferrovieri, lo SFI, svoltosi a Bologna nel luglio 1921.
Il Sindacato Ferrovieri si era sempre distinto per forte combattività, ma, geloso della sua “autonomia”, si basava sulla erronea convinzione di poter difendere meglio gli interessi della categoria restando separato dalle altre organizzazioni di classe. Una vana illusione che ha accompagnato anche successivamente reparti combattivi di ferrovieri.
Contro questa concezione ristretta e chiusa di lotta difensiva, che impediva la solidarietà generale di classe ed apriva ad ideologie di industrialismo operaio di stampo anarcoide, si erano sempre battuti i comunisti, che al congresso proposero l’adesione dello SFI alla CGdL ed alla Internazionale dei Sindacati Rossi.
Era quello in Italia un momento non di tregua sociale, ma di aspra lotta di classe, in cui la borghesia e lo Stato capitalista sferravano il loro attacco decisivo contro la classe lavoratrice, con la repressione violenta delle forze legali e delle squadre fasciste che si abbatteva su di un proletario reso inerme dalla socialdemocratica politica di tradimento. Ma ancora in quei mesi la bilancia delle forze delle opposte classi oscillava fra rivoluzione e controrivoluzione, non ancora irrimediabilmente piegata dalla parte borghese. I sindacati operai erano investiti in pieno dalla febbre rivoluzionaria, travalicante le rivendicazioni contingenti, e imposta, nella recessione produttiva, dalla diminuita efficacia economica degli scioperi di fabbrica e di categoria.
In quella temperie la gran parte di quei delegati già sapeva ed apertamente affermava che la difesa delle condizioni immediate anche solo dei ferrovieri era possibile solo con la “rivoluzione” e il “socialismo”: in discussione era solo come arrivarci.
Il dibattito al congresso in quel frangente si portava quindi, da parte di tutti i partiti presenti fra i ferrovieri, sul piano della strategia e della politica generale della classe, appunto, fra rivoluzione o controrivoluzione, che appariva allora ai delegati fra stare nella CGdL o fuori, e sull’incombente teatro della rivoluzione mondiale, allora ben presente a tutti i proletari, fra Mosca o Amsterdam.
Non è che nei sindacati, quindi, “non si fa e non si parla di politica”, ma si parla e si cerca di fare la politica che immediatamente urge alla classe. Ad un certo punto la difesa immediata è, viene a coincidere con la rivoluzione comunista.
«Per Marx ed Engels (...) dove le situazioni maturano e l’avanguardia proletaria è forte e decisa, anche il sindacato passa da organo di conquiste limitate ad organo di battaglia rivoluzionaria, e la strategia della conquista del potere politico trova la sua base nella decisa influenza del partito, eventualmente anche minoritario, negli organismi sindacali traverso i quali si può chiamare la massa agli scioperi generali e alle grandi lotte» (“Le Internazionali Sindacali”, Battaglia Comunista n. 26, 1949).
L’adesione alla CGdL avrebbe dovuto essere pacifica dal momento che la maggioranza dei delegati appartenevano o seguivano le direttive del PSI, e perché nelle assemblee di preparazione al congresso i socialisti avevano sostenuta l’adesione alla Confederazione. D’altra parte l’adesione all’Internazionale sindacale di Mosca non avrebbe potuto essere rifiutata dagli anarco-sindacalisti, nemici della politica collaborazionista dei socialdemocratici.
Ma, a riprova di come il comunista sia l’unico partito che coerentemente difende anche gli interessi immediati della classe, traditi invece da tutti gli altri partiti, al congresso si verificò un compatto fronte unico anticomunista che abbracciò indistintamente repubblicani, socialdemocratici, anarco-sindacalisti e tutti gli altri.
Vennero presentati ben 8 ordini del giorno, ma poi se ne votarono solo 3: quello socialista, il comunista e l’anarco-sindacalista. I socialisti ottennero 74 voti; gli anarco-sindacalisti 58 ed i comunisti 22.
L’ordine del giorno socialista diceva testualmente: «Il Congresso, discutendo in merito ai rapporti del sindacato con le organizzazioni economiche nazionali ed internazionali, delibera di mantenere nell’interesse supremo della unità sindacale l’autonomia tanto nei riguardi delle organizzazioni economiche nazionali come nei riguardi delle organizzazioni economiche internazionali; e conseguentemente si dichiara contrario ad inviare la rappresentanza del sindacato al congresso dei sindacati di Mosca».
Ora, se era ragionevole, dal punto di vista dei socialisti riformisti, negare la propria adesione all’Internazionale Sindacale Rossa, parrebbe incomprensibile negare l’ingresso del sindacato ferrovieri all’interno della Confederazione Generale del Lavoro, dal momento che loro ne detenevano la direzione, e quando nelle assemblee locali i loro iscritti avevano espresso la volontà di adesione. Ma i delegati dovevano rispettare le direttive dei loro dirigenti, di quei dirigenti che pur non si stancavano mai di blaterare di unità del proletariato.
E lasciamo da parte l’ipocrisia di agire “nell’interesse supremo della unità sindacale” perché, si sa, i traditori del proletariato perdono perfino il minimo senso della decenza.
Votare contro l’adesione alla CGdL aveva un preciso scopo controrivoluzionario. Innanzi tutto, se la CGdL era al momento in mano ai socialriformisti, non è detto vi sarebbe restata per sempre; poi il compito degli agenti borghesi all’interno della classe operaia non è certamente quello di unirla, ma di dividerla per mantenerla debole e vulnerabile. L’adesione dello SFI alla CGdL avrebbe rappresentato una chiara vittoria della tattica comunista tesa all’unificazione delle organizzazioni anche quella delle lotte, ed i socialisti (quelli di destra, così come quelli di sinistra) non lo potevano permette, nel momento stesso in cui trattavano la “pacificazione” con i fascisti, ossia la consegna del proletariato disarmato nelle mani del nemico di classe.
Ancora più vergognosa fu la posizione degli anarco-sindacalisti che per opporsi alla entrata nella Confederazione Generale del Lavoro ed alla adesione alla Internazionale dei Sindacati Rossi di Mosca non trovarono nessun imbarazzo a fare fronte unico con i socialdemocratici, loro presunti “nemici” storici, e nel preciso momento in cui questi siglavano l’ultimo loro tradimento.
Agli anarco-sindacalisti non possiamo neppure concedere l’attenuante del rifiuto di confluire nella CGdL a causa della sua direzione opportunista: infatti non si opposero solo alla CGdL, ma alla unità del proletariato, altrimenti avrebbero potuto proporre l’adesione all’altra Confederazione, quella da loro controllata, l’USI. Anche negli anarco-sindacalisti l’odio per il comunismo era maggiore di quello provato verso il riformismo e, più grave ancora, della loro dedizione alla difesa operaia.
Per verità di cronaca dobbiamo dire che anche tra i delegati comunisti si verificarono alcune inqualificabili defezioni, comunisti che non votarono la mozioni del partito, e che furono immediatamente espulsi.
Un vergognoso episodio fu quello delle cariche sociali dell’organizzazione: 5 membri per il Consiglio Generale. Dopo lunghe trattative e violenti scontri (con scambio di invettive e cazzotti) venne stabilito di mettere un rappresentante per ognuno dei gruppi politici, ma i socialisti misero il veto alla nomina di Azario, candidato dei comunisti, e lo sostituirono con altro elemento già sconfessato per la sua condotta contrapposta alle direttive del partito. Il presidente socialdemocratico, ignorando le proteste comuniste, dava inizio alla votazione per appello nominale. Proclamati gli eletti, questi, non ritenendosi investiti dalla massa degli iscritti, ma solo dal gioco degli intrighi, si dimisero. Seguirono nuovi scontri e nuovi pugilati. Prese allora la parola Castrucci, vecchio anarchico e capo riconosciuto dei ferrovieri, che, deplorando l’accaduto, giustificò la reazione comunista e propose l’elezione di 6 membri (anziché 5) per dare anche ai comunisti la possibilità di avere nel consiglio un loro rappresentante di fiducia. La proposta fu approvata ed anche Azario fu eletto.
Però, a congresso concluso, furono diramate diverse circolari a firma di socialdemocratici ed anarchici in cui veniva contestata l’elezione di Azario perché, si diceva, avvenuta “nell’oscurità del tumulto delle passioni” e quindi si invitavano i congressisti (convocati a domicilio) a dare l’ostracismo al rappresentante del Partito Comunista per sostituirlo con altro nominativo anarchico. La gravità di questo atto è palese: si trattava di una espulsione del Partito Comunista dalla dirigenza del sindacato attuata dai socialisti e dagli anarchici in vergognosa combutta. Tutto questo senza curarsi minimamente dell’effetto demoralizzante sulla classe lavoratrice, che avrebbe perduto la fiducia nelle sue organizzazioni di difesa. Questa guerra anticomunista sarebbe costata molto cara ai ferrovieri e avrebbe giovato solo al governo ed alla borghesia per sottomettere i lavoratori agli interessi del capitalismo.
Il Comunista, 3 luglio 1921
IL CONGRESSO DEI FERROVIERI
Il Congresso del Sindacato dei Ferrovieri che avrà inizio, dopo i parecchi rinvii, a Bologna, fra pochi giorni risolverà l’appassionato dibattito che nel campo dei ferrovieri ha preceduto il Congresso, intorno ai quesiti: Autonomia? Adesione alla CGdL? Federazione dei Trasporti? Adesione all’USI?
Però la esistenza di talune incertezze e incomprensioni non è da porsi meccanicamente in dubbio. E tanto più esse esistono quanto più da alcuni le si vorrebbe mascherate sotto l’equivoca veste di un estremismo di falsa lega. Tanto è vero che l’unità proletaria sul terreno sindacale è una opportuna tattica rivoluzionaria, che l’Internazionale comunista ha posto questo concetto come premessa di tutta quanta la sua tattica sindacale, mentre invece i socialdemocratici, che nel campo della politica pura (adoperiamo questo grossolano aggettivo allo scopo soltanto di chiarire il nostro pensiero) ostentano un assurdo amore per una impossibile unità, nella loro attività sindacale tendono proprio in questi giorni, con varia intensità ma in quasi tutte le nazioni, a selezionare nei sindacati in cui essi dominano, gli elementi estremisti dalla massa, per guidare questa da assoluti padroni.
Chi dice quindi: non vogliamo aderire alla CGdL perché essa è nelle mani dei socialdemocratici, se parla a nome d’una massa animata da sincero spirito rivoluzionario, propone una tattica perfettamente contraddittoria al raggiungimento dei fini rivoluzionari, si rende complice dei socialdemocratici, facendone il gioco migliore.
Ma non è questa, a dire il vero, la posizione dei fautori dell’autonomia in seno al SFI, nelle dichiarazioni di molti di essi si contiene una certa dose di imparaticci (tutt’altro che ben digeriti) intorno alle teoriche sindacaliste, od una aperta dichiarazione di apoliticità. O vengono a narrarci in tono cattedratico che il sindacato è “un partito di classe” e come tale non può né deve sottomettersi al partito socialista od al partito comunista; o favoleggiano intorno a probabili scissioni, in caso di adesione alla CGdL, o fan chiari accenni intorno alla necessaria apoliticità del sindacato, ad esempio perché “un anarchico, un sindacalista, un repubblicano, un comunista non può stare contemporaneamente in un Sindacato o Confederazione Generale di Sindacati, la quale disciplini la propria attività, sia pure politica, a quella di un determinato partito politico, come appunto nel caso che ci interessa, codesti elementi non possono entrare nella Confederazione Generale del Lavoro fintanto che questa resta subordinata al partito socialista italiano”.
Nel brano che abbiamo riportato si parla di incompatibilità degli appartenenti ai partiti politici o seguaci delle concezioni politiche elencate, con la CGdL legata al PSI, ma evidentemente l’autore di esso non vede soluzione alla incompatibilità derivante dall’assoggettamento di “un sindacato o Confederazione Generale di sindacati” ad un qualunque partito politico, fuorché nell’apoliticità del sindacato. Or queste concezioni (accenniamo di volo, perché è inutile rifarci tutta la polemica coi sindacalisti) rivelano un grado di sviluppo della coscienza di classe che l’esempio della realtà va man mano costringendo un po’ tutti a sorpassare.
Ma si potrebbe obiettare: perché allora i sindacalisti del SFI non sostengono almeno l’adesione alla USI? (a sua volta domanderemmo a questa come mai essa, pur aderendo alla Internazionale Sindacale di Mosca, non ne accetta la tattica, respingendo l’invito – che per essa doveva essere ricordo di un elementare dovere – fatto dal PCd’Italia, d’entrare nella CGdL; ma questo argomento merita d’essere trattato a parte).
Il perché è semplice. Lo stato d’animo di larga corrente nel SFI non è sindacalista, o anarchico, o socialista, o comunista: è semplicemente autonomista. Ciò nella massa si spiega col fatto che essa, data la mole e la complessità e la importanza del congegno ferroviario, ha l’erronea sensazione che la sua organizzazione possa bene essere un tutto a sé stante, un organismo vivo e vitale senza bisogno di innesti ed iniezioni, uno strumento perfettissimo di lotta pel raggiungimento dei fini sindacalisti; e veramente l’esperienza degli ultimi anni rafforza, in apparenza, questa credenza.
Ma chi di essa si fa sostenitore, dimentica che non è il caso di parlare di un problema dei ferrovieri o dei metallurgici, o degli impiegati statali isolatamente presi. C’è un solo problema: quello rivoluzionario, che interessa tutto il proletariato.
È problema dai mille aspetti e dalle innumerevoli irte difficoltà; la cui soluzione però chiede come premessa indispensabile la unificazione delle forze proletarie sul terreno del disciplinamento delle energie e delle coscienze, nella cancellazione d’ogni istinto conservatore corporativistico, per la assimilazione spontanea della coscienza di classe il cui senso profondo può comprendere chi ne dimentichi l’abuso fatto dall’oratoria da comizio.
* * *
Dicono i ferrovieri autonomisti: ma il SFI agì sempre concordemente, in armonia con ogni manifestazione proletaria. La sua adesione al massimo organo proletario è un fatto, pur se nella forma non appare tale...
Quest’affermazione, in verità, non è del tutto esatta, ma non stiam qui a far vane, banali recriminazioni.
Coloro che con queste o simili osservazioni credono di tagliare il nodo gordiano del grave problema, non fanno invece che costatarne uno degli aspetti meno importanti. Essi dimenticano che la lotta fra il proletariato e la borghesia attraversa una fase in cui la tattica rivoluzionaria richiede squisita sensibilità critica in chi veramente la segue, perché secondo le apparenze (in parte nella realtà) le forze controrivoluzionarie e conservatrici più temibili, perché meno, a chi grossolanamente giudichi, visibili, si annidano proprio nelle organizzazioni proletarie. Sempre il movimento proletario covò nel suo seno il veleno socialdemocratico: ma mentre questo in altre fasi di sviluppo rivoluzionario non dava effetti esageratamente deleterii, perché non ancora era aperta la crisi di successione del potere proletario a quello borghese, oggi, invece, il prevalere dei socialdemocratici significa deviazione della corrente rivoluzionaria, arresto momentaneo di essa, dispersione di energie, dilagare dell’equivoco e del disorientamento, proprio quando le travolgenti necessità rivoluzionarie dovrebbero creare compattezza ed unità di sforzi.
Diventa così trascurabile cosa, sotto questo aspetto, l’arresto del congegno di produzione e di scambio a scopo di intimidazione e di minaccia contro la borghesia, quando questa manifestazione di forze proletarie può essere abilmente sfruttata dai socialdemocratici ai loro fini, che non sono quelli della causa rivoluzionaria. I socialdemocratici, che non sono assolutamente contrarii ad ogni forma di violenza, comprendono nei modi della loro tattica sindacale anche le più esasperate forme di minaccia proletaria (l’occupazione delle fabbriche insegni), arrestando però, ben si intende, l’azione quando essa da coreografico spiegamento di forze tende a trascendere in reale esercizio di esse, per la conquista del potere proletario.
* * *
Ecco quindi cosa oggi significa unità proletaria: intima coesione di tutte le forze rivoluzionarie, per epurare i sindacati della infezione socialdemocratica.
Ma ciò non ancora intende quella corrente del SFI, che è autonomista. Essa rivela così (è superflua la dimostrazione) d’essere ancora essa medesima dominata da spirito, sia pur larvato da una grossolana tendenza sindacalistoide, socialdemocratico.
* * *
Ciò non ci scoraggia. La socialdemocrazia attraversa oggi un periodo di notevole fortuna. Essa pervade del suo equivoco l’animo di moltissimi proletarii che il rivoluzionarismo parolaio degli ultimi anni disabituò alla esatta comprensione dei fini e dell’aspra strada che la tattica rivoluzionaria è pur costretta a seguire. Essa è incoraggiata dai ceti più intelligenti della borghesia, che accorrono a rafforzare le sue file: ed in ciò essa vede la vittoriosa conferma della sua teoria.
Quale il compito dei comunisti, in questa ora grigia? Non quello di “fare la rivoluzione”, o ignorantissimi critici faciloni, ma quello di prepararla. E prepararla, oggi, non significa altro che inquadrare il nucleo centrale dell’esercito proletario, per le piccole battaglie di oggi, per le grandi battaglie di domani; e significa anche prospettare al proletariato la previsione esatta di ciò che esso domani non per effetto soltanto della nostra propaganda, ma soprattutto per l’incalzare degli avvenimenti, sarà costretto a fare.
Anche nel SFI i nostri compagni comunisti, strenuamente, esercitano questa benefica azione.
Nell’imminente congresso essi porteranno con ogni chiarezza il problema: dimostreranno quali sono i motivi rivoluzionari dell’ingresso nella Confederazione, ed i pericoli dell’autonomia, ribadendo quei concetti che esponeva chiaramente il nostro “appello sindacale”.
Che cosa faranno i socialisti? Che cosa dirà il PSI ai suoi membri ferrovieri?
Pare che esso taccia e la soluzione autonomista allora prevarrebbe come una tacita confluenza del punto di vista sindacalista con quello socialdemocratico.
Ma anche se i socialisti proponessero l’entrata nella CGdL, i comunisti saprebbero differenziarsi da loro, presentando la loro proposta sulla base della ben diversa finalità che la ispira e che risponde alla formula tattica di Mosca: “Nei sindacati diretti dai socialdemocratici, per la lotta a fondo ai socialdemocratici”.
Il Comunista, 14 luglio 1921
Dopo il Congresso dei Ferrovieri
È IL “PANCIAFICHISMO” CHE HA VINTO
Siamo soliti a parlare chiaramente alle masse lavoratrici, ed il nostro giudizio sul risultato, ben da noi preveduto, del decimo Congresso del Sindacato dei ferrovieri italiani lo esprimeremo senza peli sulla lingua.
In quel congresso il fronte unico anticomunista si è realizzato. Anarchici, sindacalisti, socialisti, repubblicani e “senza partito”, si sono incontrati a sostenere lo stesso criterio negativo: la autonomia del Sindacato, non solo dai partiti politici, ma dagli stessi organismi sindacali nazionali ed internazionali della classe lavoratrice; mentre i comunisti, solo i comunisti, presentavano una proposta precisa, completa, ben inquadrata nella mozione che più sotto testualmente riportiamo, vigorosamente sostenuta nei discorsi di Azario, di Gnudi e di altri nostri compagni: Adesione alle direttive rivoluzionarie della Terza Internazionale ed alla sua tattica sindacale, e per conseguenza entrata nella Confederazione Generale del Lavoro per associarsi all’opposizione comunista, militante contro i dirigenti, nel seno di questa, adesione alla Internazionale dei sindacati rossi di Mosca.
Solo 22 delegati si sono affermati su tale mozione. La prevalenza (74 voti) l’ha avuta l’ordine del giorno dei socialisti per l’autonomia assoluta da ogni organismo nazionale ed internazionale, mentre 58 voti otteneva l’ordine del giorno dei sindacalisti-anarchici per la costituzione di una “Federazione dei trasporti” e per mandare una delegazione a Mosca con questo mandato: aderire alla Internazionale sindacale rossa solo se questa abbia come caposaldo la indipendenza del Sindacato da ogni partito politico.
Le obiezioni contro la chiara e sicura impostazione della tattica comunista sono state demolite dai nostri oratori. Tenerezza per la Confederazione? Ed allora perché i socialisti che ne sostengono l’attuale indirizzo sono contro la tesi di entrarvi? Perché gli autonomisti hanno urlato come calandre quando i nostri scarnificavano la traditrice politica dei confederalisti? Difficoltà di conquistare la maggioranza confederale e necessità di dover subire la disciplina dei suoi capi controrivoluzionari? Ma forse in tutte le situazioni dell’anteguerra e del dopoguerra non hanno dovuto i ferrovieri spintisi all’avanguardia subire questa disciplina disfattista per la forza dei fatti, costretti a disarmare quando alla Confederazione piacque, restando esposti alle rappresaglie, constatando che non si lotta, specie quando il conflitto assurge a proporzioni politiche, se si ha solo una organizzazione di una categoria, anche importantissima? E non è stata forse questa la vera ragione delle delusioni del proletariato ferroviario che lo spingono, da una posizione di avanguardia rivoluzionaria, ad una deplorevole tendenza corporativa? Pericolo per l’unità del Sindacato? Ma sono forse i comunisti in procinto di uscirne perché la loro tesi è caduta? E non potevano e dovevano gli autonomisti, se l’unità della categoria li preoccupa più dell’unità di classe, assumere uguale impegno di rispettare in pratica le decisioni della maggioranza del Congresso? Soggezione ad un partito politico, socialista o comunista, secondo che si contenderanno la dirigenza confederale? Ma questo proprio risponde al concetto comunista rivoluzionario dello sviluppo della coscienza proletaria, e se la obiezione è logica in quanto la formulano gli anarchici, è ridicola da parte di socialisti che negano di essere dei riformisti, tanto più in quanto per ora proprio il loro partito sarebbe agevolato formalmente dal passo che farebbero i ferrovieri entrando nella Confederazione, e rafforzandola, mentre è ancora alleata del partito socialista. Ma a costoro non preme tanto la forza della Confederazione, quanto la garanzia del suo monopolio da parte della burocrazia reazionaria daragoniana.
Contro la logica compiutezza della nostra tesi restano miserevolmente inconcludenti le opportuniste posizioni avversarie. Val la pena di discutere la tesi dei socialisti che votano per la non entrata nella Confederazione, tanto amica del loro partito? Ma ha questo detto una sola parola ai suoi iscritti in questa occasione? Si è la direzione del partito pronunziata, almeno nel senso di dare un consiglio ai ferrovieri socialisti? Silenzio di tomba! Sotto tutto ciò, compagni ferrovieri, non c’è una tesi decente, ma solo un giochetto evidentissimo. Nelle assemblee locali i socialisti hanno sostenuta l’adesione alla Confederazione, per confondere le carte e spingere i simpatizzanti comunisti ed estremisti alla tesi opposta dell’autonomia, legando le mani ad alcuni nostri compagni. Al Congresso hanno poi eseguita la parola d’ordine dei socialdemocratici confederali: evitare ad ogni costo l’entrata dei ferrovieri nella Confederazione. Quale migliore riprova della bontà della tattica comunista?
E la tesi anarco-sindacalista? Che gli estremisti di sinistra (?) si incontrino con quelli di destra nel negare l’adesione a Mosca, mentre gli uni e gli altri se ne sono, quando conveniva, gridati fedeli seguaci, che si associno a quelli nelle tesi che “il sindacato deve essere indipendente dal partito politico di classe” (tesi che non giova ripetere ancora una volta come sia la quintessenza dell’antirivoluzionarismo) transeat... Ma sostenere la indipendenza anche da ogni organismo sindacale nazionale ed internazionale, dalla stessa organizzazione secessionista italiana, l’Unione Sindacale, dalla stessa eventuale Internazionale sindacalista che potrebbe contrapporsi a quella comunista (e tacciamo la proposta ridicola della “Federazione dei trasporti”, caduta anche per l’adesione dei lavoratori del mare alla Confederazione, e che non farebbe, caso mai, che allargare il criterio di categoria, senza pervenire alla unità di classe) questo è il colmo dell’inconsistenza di principi e di tattica.
Sì, i sindacalisti, anarchicheggianti più o meno, sostengono che, non il partito politico, ma un organismo sindacale secessionista ed estremista deve guidare la lotta rivoluzionaria proletaria. Ma mai si sono sognati di dire che questa tesi si contrapponga al concetto di unità sindacale, di cui noi siamo fautori nel preciso senso più volte prospettato, perché voglia lasciare le singole categorie isolate tra loro! Una organizzazione comprendente una parte di tutte le categorie organizzate, come l’Unione Sindacale, contrapposta alla Confederazione, in cui le rimanenti parti delle stesse categorie sono organizzate, è un criterio comprensibile, se pure criticabile come falsamente rivoluzionario. Ma il concetto di separare un sindacato di categoria da tutti gli altri, non è una tesi, non è una opinione, non è un metodo, è solo una evidente deplorevole prova di opportunismo conservatore.
Sotto il paludamento socialdemocratico o sotto quello anarcoide non sono state portate all’aperta luce del conflitto nel Congresso dei ferrovieri concezioni precise e rispettabili; ma qualche cosa di ben diverso. E questo qualche cosa è il peggiore veleno per il proletariato che tende alla sua emancipazione di classe, è lo spirito di categoria, l’egoismo corporativo, il concetto: siamo organizzati per la lotta economica, pei benefici materiali, e basta, è l’errore colossale che questi benefici stessi siano conseguibili al di fuori della solidarietà di tutto il proletariato, che la solidarietà nella lotta possa essere altro che compattezza organizzativa.
Il blocco anticomunista si è battuto a Bologna sotto le bandiere del peggiore opportunismo panciafichista. Ecco la verità. Da socialisti e da anarchici non si è messo il Sindacato che organizza integralmente tutto il proletariato al di sopra del partito in cui può militare ciascun proletario; ma si è bassamente messa la sorte del ferroviere, delle sue paghe, delle sue pensioni, della sua – talvolta – possibile posizione di privilegio rispetto ai fratelli lavoratori di tutte le altre categorie, al di sopra delle sorti della generale battaglia rivoluzionaria del proletariato.
Noi non facciamo ai ferrovieri, che tante prove hanno dato, pur tra alcuni errori, di sapersi sacrificare nobilmente per la causa proletaria, il torto di chiamarli responsabili delle colpe della loro burocrazia sindacale dirigente. Anch’essi hanno una rete che li immobilizza e da cui devono liberarsi per assurgere alla libertà di azione che li porrà a lato delle più audaci energie proletarie, ed un estremismo di princisbecco non deve ingannarli su questa verità. In questa lotta il partito comunista, coi suoi immutabili metodi, tende loro una mano fraterna e disinteressata. Compagni ferrovieri comunisti al lavoro! Contro le piccole viltà di tutti gli opportunismi, per portare nei ristretti orizzonti dell’azione puramente sindacale il soffio rinnovatore del programma rivoluzionario del nostro partito e della Internazionale Comunista!
Il Comunista, 14 luglio 1921
MOZIONE COMUNISTA AL CONGRESSO DEI FERROVIERI
“Il decimo Congresso del SFI, discutendo dei rapporti del Sindacato con le organizzazioni economiche nazionali e internazionali, afferma anzitutto che il proletariato ferroviario, per degnamente ed efficacemente assolvere il compito che spetta alla sua organizzazione, così nella difesa dei suoi particolari interessi come nella necessaria azione rivoluzionaria per la causa dell’emancipazione proletaria, non può oltre rimanere estraneo al sistema delle forze proletarie nazionalmente e internazionalmente organizzate, poiché questo equivarrebbe a volersi chiudere nello stretto ed ormai insufficiente ambito dell’azione di categoria, e ciò nel momento storico in cui maggiormente s’allargano le prospettive della lotta di classe e s’affermano le possibilità del compito di tutti i lavoratori ad assurgere, mediante la loro unità di classe, alla direzione della collettività sociale e all’eliminazione d’ogni dominio e sfruttamento borghese;
delibera di aderire alla Confederazione generale del lavoro per sostenere in seno alla Confederazione stessa l’azione della minoranza rivoluzionaria, che vi conduce una lotta decisiva e senza quartiere contro l’opportunismo e la burocratica dittatura dei capi attuali, per la partecipazione delle forze sindacali del proletariato italiano alla battaglia rivoluzionaria contro il regime capitalistico e per l’adesione a Mosca;
facendo proprie le direttive della III Internazionale, unica organizzazione del proletariato mondiale, la cui dottrina e la cui azione corrispondono alle necessità della lotta e della vittoria proletaria, si dichiara aderente all’Internazionale dei Sindacati rossi di Mosca, impegnandosi ad osservare le norme d’organizzazione che il Congresso mondiale, in questi giorni convocato a Mosca, emanerà per l’unificazione dei metodi di lotta delle forze organizzate di tutti i Paesi”.
Il Comunista, 14 luglio 1921
COMUNICATO DEL COMITATO ESECUTIVO
Al recente decimo congresso del sindacato ferrovieri, dove il gruppo dei delegati comunisti ha condotto ammirevolmente una vivace battaglia per l’affermazione delle direttive sindacali della Internazionale comunista contro l’opportunismo dei fautori della “autonomia” del Sindacato, si è verificato, mentre assai lodevolmente qualche nostro compagno sacrificava alla disciplina di partito le sue personali vedute, il deplorevole fatto che alcuni delegati inscritti al partito comunista hanno votato le mozioni di altri gruppi contrapposte a quella sostenuta dal loro partito.
L’atto di indisciplina di questi compagni non può avere alcuna giustificazione, e ad esso deve seguire la immediata loro espulsione dalle file del partito comunista. Il Comitato Esecutivo ne comunicherà i nomi alle federazioni a cui erano inscritti per la applicazione di tale provvedimento.
Nello stesso tempo il Partito Comunista rivolge il suo saluto al proletariato ferroviario, tratto dai suoi dirigenti su di una via che contrasta con le nobili sue tradizioni, ed impegna tutti i compagni ed i simpatizzanti ferrovieri ad intraprendere in seno alla massa dei loro compagni una propaganda attivissima delle precise direttive sostenute dal Partito al Congresso, costituendo sulla base di esse i gruppi comunisti in seno al Sindacato Ferrovieri Italiani, l’attività dei quali deve subito rivolgersi alla dimostrazione, con esaurienti relazioni dei delegati comunisti, della giustezza di quanto essi hanno a Bologna sostenuto. Intanto l’Esecutivo del Partito e l’Esecutivo Sindacale iniziano un attivo lavoro per la costituzione del Comitato Sindacale Comunista ferroviario che nazionalmente dirigerà tale lavoro.
Il Soviet, 17 luglio 1921
I SOCIALISTI E IL CONGRESSO DEI FERROVIERI
Basta dare uno sguardo anche superficiale al movimento sindacale nazionale, per poter giudicare la tattica socialista e confederale usata nei diversi congressi succedutisi alla grande assise socialista di Livorno.
Di recente abbiamo il congresso dei ferrovieri, che ci offre copioso materiale per le nostre affermazioni. La tattica del partito socialista e della confederazione generale del lavoro dopo il congresso di Livorno – lo ripeteremo fino a completa sazietà – è quella di dividere, non di unire il proletariato: han ribadito in noi questa opinione, il gesto e la parola dei socialisti al congresso di Bologna testé svoltosi.
In realtà i diversi discorsi pronunciati dai socialisti nel congresso, propugnanti tutti calorosamente l’autonomia, non sono il pensiero dei singoli, sibbene il risultato di precise istruzioni emanate in segreto dai massimi organismi in contrasto con quelle del precedente congresso. Ai superficiali ed agli ingenui sembra strano l’atteggiamento socialdemocratico a favore dell’autonomia, quando son note a tutti le pappardelle confederali ripetute a iosa sulla stampa multicolore e il farmaco baldesiano per l’unione del proletariato. Ma a noi quel che si è svolto al congresso non ha apportato maraviglia: ben sappiamo che i riformisti confederali, paladini in pubblico della più stretta unione, sono poi in segreto i più indegni fucinatori di secessioni. Non si lanci a noi comunisti la stupida accusa di essere dei disgregatori, quando sono proprio i socialisti e i confederalisti a propugnare l’autonomia delle diverse classi lavoratrici che ancora sono fuori i quadri della confederazione generale del lavoro. Noi non l’autonomia delle varie categorie operaie vogliamo, ma la loro intima fusione nell’organismo massimo confederale per marciare alla conquista di esso e per sostituire ai vecchi capi burocratici del riformismo i veri rivoluzionari.
Oggi, che nel decimo congresso del sindacato ferrovieri italiano eranvi le premesse numeriche di una facile vittoria e la questione poteva essere felicemente risolta, sono stati proprio i socialisti che, coalizzati con gli anarchici ed i repubblicani per combattere i comunisti, hanno sostenuto a spada tratta l’autonomia, contrariamente al precedente congresso, per rimanere fuori i quadri della confederazione del lavoro. Era questo il desiderio dei ferrovieri iscritti al partito? No, era l’ordine dei capi e bisognava rispettarlo, l’ordine di quei capi che predicano quotidianamente l’unione del proletariato, per sabotarla poi quando questa si presenta di facile attuazione.
La verità è palese; essi erano, sono e saranno sempre controrivoluzionari.
Potremmo anche condividere la opinione di alcuni ferrovieri circa la impossibilità della conquista dell’organo confederale da parte degli estremisti, ma è chiaro che il nostro dovere è quello di muovere alla conquista di esso, qualunque siano le previsioni della battaglia. In quanto poi all’opinione di alcuni, che i rivoluzionari esistenti nella confederazione sarebbero assorbiti, noi rispondiamo che sapremmo ben valutare le nostre forze e in ogni caso utilizzarle. Ha assorbito la borghesia i comunisti? Tanto meno li assorbirebbero i riformisti. Ai socialisti che nel congresso dei ferrovieri hanno sostenuto l’autonomia per una pura ragione di gretto corporativismo, adducendo a sostegno della loro tesi che i comunisti desideravano fare del sindacato uno strumento politico; noi comunisti facciamo i nostri sinceri rallegramenti per essersi rivelati – quali sono – piccolo-borghesi e antimarxisti.
Ai compagni ferrovieri che sono stati sempre all’avanguardia del movimento proletario non è il caso di ricordare che ogni grande lotta economica è politica, e come l’una non può prescindere dall’altra, lo dimostra tutta la storia delle lotte di classe in Francia, lo dimostra oggi il fascismo italiano. Chi vi parla un altro linguaggio non è che un rinnegato, tradisce se stesso e la propria classe. I comunisti non temono di affermarlo anche quando devono affrontare le ire, le persecuzioni e le minacce dovute principalmente alla delazione socialdemocratica.
Il resultato del congresso di Bologna per quanto può apparire una vittoria della socialdemocrazia, tanto lascia bene sperare in un prossimo orientamento della classe ferroviaria.
L’invio del delegato al congresso dei sindacati rossi a Mosca accettato quasi all’unanimità dai congressisti è l’indice sicuro di un maggior risveglio rivoluzionario da parte dei ferrovieri italiani. I ferrovieri comunisti devono svolgere tutta l’attività nella loro classe, la quale darà migliori frutti in un prossimo avvenire. Le decisioni dell’ultimo congresso, in cui è prevalso il concetto corporativistico – messo innanzi ad arte dai socialdemocratici – non può certo soddisfare i comunisti, i quali dovranno con maggior lena esercitare tutta quanta la loro pressione sui compagni per farli uscire dal vicolo cieco in cui volontariamente si sono chiusi mercé le deliberazioni prese e che vogliamo augurarci non siano di lunga durata. Il proletariato italiano guarda i ferrovieri come l’unica categoria, la quale – se vuole – può facilitare di molto la comune battaglia per la emancipazione dalla schiavitù del salariato, rovesciando l’attuale regime borghese, per instaurare la nuova società comunista.
Il trapasso da questa società, a cui pure mira la maggioranza della classe ferroviaria, non potrà aversi nell’ambito dell’azione di categoria, quando maggiormente si allargano le prospettive della lotta di classe e si affermano le possibilità del compito di tutti i lavoratori ad assurgere alla direzione della collettività sociale e alla eliminazione di ogni dominio o sfruttamento borghese, bensì nel movimento d’insieme di tutto il proletariato rivoluzionario, quando la maggioranza dei sindacati – contrariamente alle affermazioni socialdemocratiche – saranno divenuti strumenti politici e rivoluzionari.